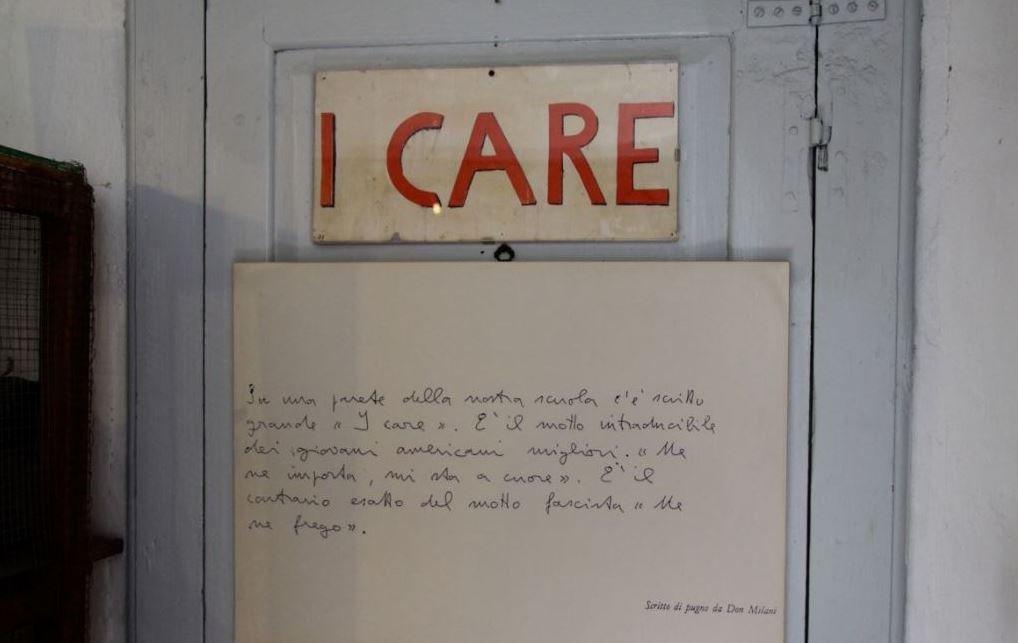don Milani
Schegge per una testimonianza

Un’insegnante alla scuola di Barbiana
Non pretendo di dire come «era» la Scuola di Barbiana, ma quello che «io ho visto» alla Scuola di Barbiana. Per me, insegnante di una scuola di Stato, erano prima di tutto interessantissime le differenze fra quella scuola e la mia. Nella mia scuola, dopo quattro o cinque ore ero distrutta io ed erano distrutti i ragazzi. Lì si stava a scuola una giornata intera e alla sera non si era stanchi. Più volte mi sono domandata perché. Certamente era importante anche il fatto che non c’erano banchi. Intorno ai tavoli ognuno poteva cambiar posizione a suo piacere e anche questo contava. Ma soprattutto, credo, contava il fatto che si era lì per imparare e non per essere giudicati. «L’ultimo veniva accolto come nelle scuole di Stato si accoglie il primo», dice la Lettera a una professoressa, ma la cosa che più si notava e che mi piaceva di più era che lì il primo non esisteva. Nelle scuole «normali» capita che si dica: «Chi sa questo?» e alzano la mano quelli che «sanno». Ma quando si va a scuola per imparare parlano solo quelli che non sanno e tutta la vita scolastica risulta completamente rovesciata quando deve parlare chi non sa. A Barbiana ho assistito tante volte a scenate perché qualcuno non aveva capito qualcosa e non l’aveva detto, ma non ho mai sentito fare elogi a qualcuno per la sua bravura. C’era un ragazzo che, quando parlava francese aveva un accento che sembrava nato a Parigi. A lui veniva detto: «Fai te il dettato di francese». Niente di più. Se un altro era bravo in matematica toccava a lui insegnare la matematica ai più piccini, ma non era un merito, un vanto, era un compito. E siccome non esisteva il primo non esisteva neppure la competitività, su cui fanno leva tanti insegnanti moderni e di larghe vedute. A Barbiana a nessuno passava per la testa di voler essere più bravo dei compagni. Si era lì per imparare, non era concepibile, non esisteva, l’idea di un confronto fra chi aveva imparato molto e chi aveva imparato poco, fra chi sapeva esprimersi bene e chi non si sapeva esprimere. Questo, secondo me, dava a tutti una grande serenità. Ma c’erano altre ragioni per cui non ci si stancava stando a scuola. Non c’erano a Barbiana lezioni «frontali», cioè lezioni durante le quali l’insegnante parla e i ragazzi ascoltano. Anche per questo non si era stanchi la sera. Son lezioni capaci di spegnere qualunque interesse nel ragazzo più curioso, di far venire sonno al ragazzo più vispo e di distruggere chiunque si provi a stare sempre attento. Contribuiva poi, e in modo importante, a tener desto l’interesse dei ragazzi anche il fatto che a Barbiana non c’era diaframma fra la scuola e la vita.
Spessissimo il programma lo suggerivano le circostanze. Se si leggeva sul giornale che c’era stato un terremoto in Guatemala, subito ci si informava su tutto quello che c’era da sapere sul Guatemala. E quando dico ci si informava non intendo dire che il maestro si informava e poi scaricava le informazioni sui ragazzi. Il maestro spesso era l’ultimo a essere informato. I ragazzi si informavano e questo significava lavoro di ricerca e spesso lavoro di gruppo. Nel periodo in cui vennero scritte la Lettera ai Cappellani Militari e la Lettera ai Giudici si fecero ricerche in tutte le direzioni per trovare una documentazione relativa alle guerre del Risorgimento. Ricordo che, dopo la pubblicazione di quelle lettere, un amico di Vicchio, che era stato sindaco ma aveva fatto solo la scuola elementare, mi disse che invidiava moltissimo il Priore soprattutto per la conoscenza che aveva della storia. Ma io sapevo benissimo che don Lorenzo, prima di mettersi a scrivere, di tutto quello che aveva poi scritto sapeva poco o nulla. Quando il programma vien suggerito da quello che succede intorno a noi non ci si annoia, la scuola diventa scuola di vita e la vita diventa occasione di scuola. Barbiana era una chiesa isolata su un monte, i parrocchiani erano pochissimi e dispersi in case abbastanza distanti dalla chiesa, la strada era scomodissima (per arrivare lassù, specialmente d’inverno, non bisognava aver paura di soffrire la macchina), non c’era luce elettrica e quindi non c’era televisione, non c’era telefono, ma il mondo entrava nella scuola tutti i giorni, in mille modi. Non era solo il giornale a metterci in contatto col mondo. C’erano gli amici che venivano ogni tanto, quelli di un giorno e quelli di sempre; c’erano anche le lettere degli amici, conosciuti e sconosciuti; c’erano le lettere dei ragazzi quando andavano a lavorare all’estero; c’erano anche le litigate con i genitori dei ragazzi. Tutto entrava nella scuola ed era un’occasione per far scuola. Durante il processo per la Lettera ai Cappellani Militari arrivarono numerosi i giornalisti. Il confessore e la mamma di don Lorenzo lo pregavano di non riceverli. Ogni giornale tirava l’acqua al proprio mulino e il baccano che si faceva nella stampa intorno a lui lo faceva apparire come un esibizionista. Don Lorenzo diceva: «Mi chiedono di non ricevere i giornalisti. Dovrei pensare al mio interesse e non a quello dei ragazzi. Quando un giornalista viene accolto quassù io parlo con lui davanti ai ragazzi. Se poi scrivendo di noi dice bugie o travisa i fatti, noi possiamo giudicare bene fino a che punto mente e con quanta malizia e con quali scopi. È una scuola a cui non posso rinunciare».