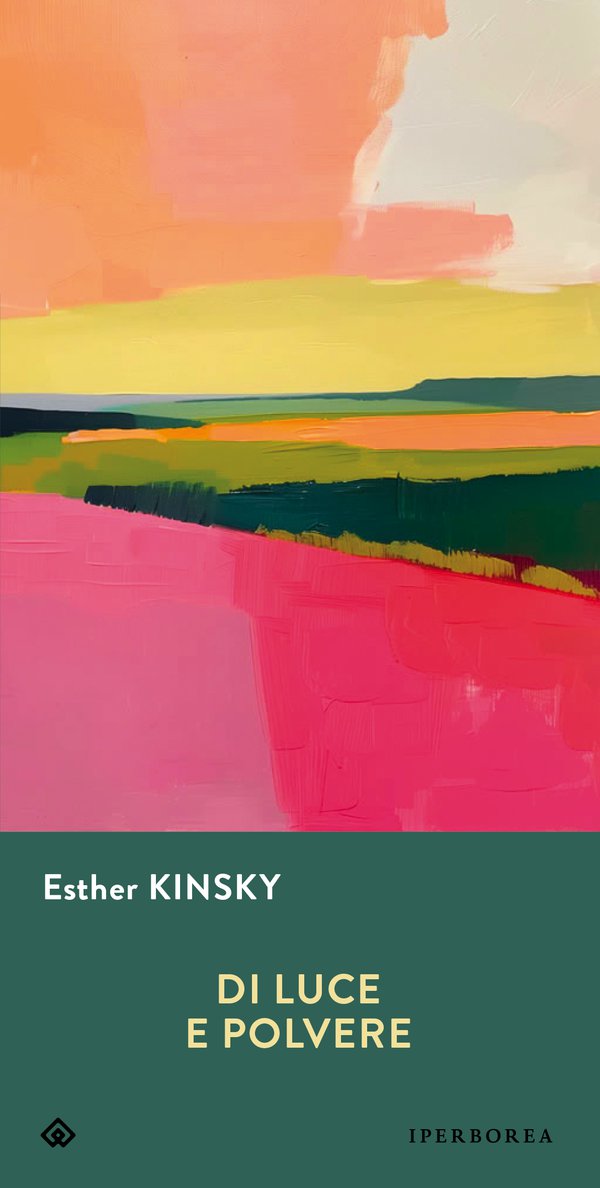L’individuo sotto assedio
Racconti
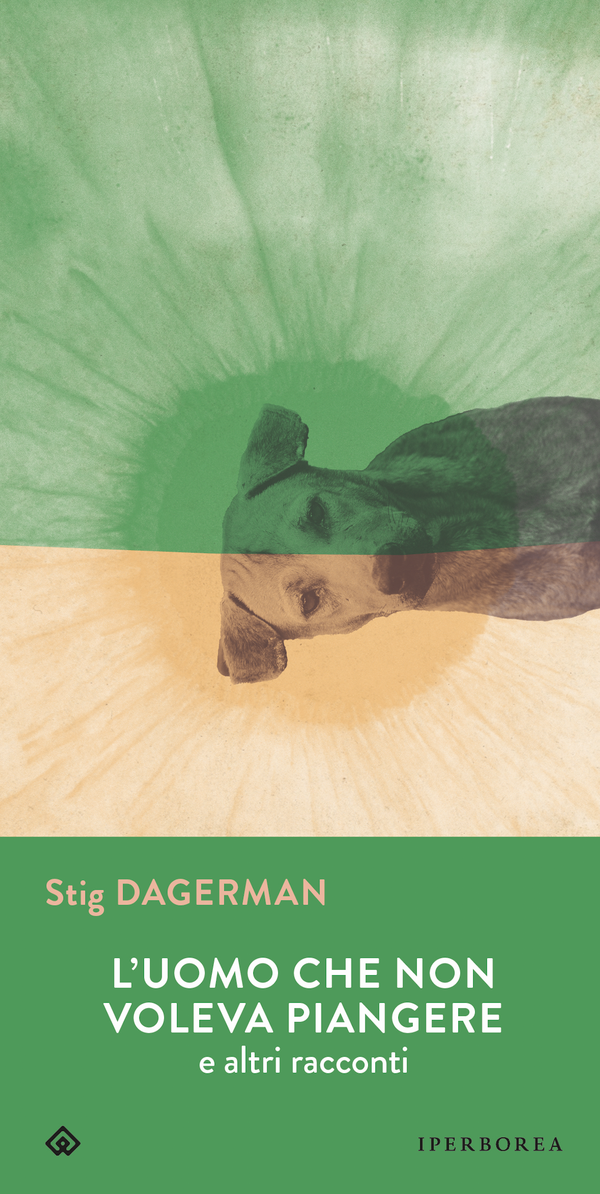
Stig Dagerman
L’uomo che non voleva piangere
Traduzione e postfazione di Fulvio Ferrari
Iperborea, 2025, pp. 320
€ 19
Con L’uomo che non voleva piangere, Iperborea prosegue il suo importante lavoro di traduzione e diffusione dell’opera di Stig Dagerman, una delle voci più significative della letteratura svedese del Novecento. Il volume, curato e tradotto da Fulvio Ferrari, raccoglie sedici racconti scritti tra il 1941 e il 1953, ancora inediti in Italia. Nove di essi provengono da Nattens lekar (1947), l’unica raccolta di racconti pubblicata in vita dallo scrittore e già parzialmente tradotta da Iperborea nel 1996 (I giochi della notte); i restanti sette sono apparsi su giornali e riviste, o in antologie collettive. Il risultato è un libro compatto e multiforme, dove sperimentazione stilistica e coerenza tematica si intrecciano con forza e nitidezza.
Dagerman, giornalista e militante anarchico morto suicida a soli trentun anni, è ormai considerato un classico del Novecento. La sua produzione – romanzi, drammi, poesie, reportage – è sorprendente non solo per profondità e varietà, ma per l’originalità con cui riesce a fondere l’analisi psicologica, l’indagine sociale e la tensione morale. In questi racconti si muove tra toni realistici e visioni simboliche, tra Kafka e Faulkner, passando per Dürrenmatt e Strindberg. Tuttavia, i debiti letterari non soffocano mai la sua voce inconfondibile: quella di un autore che ha saputo raccontare la condizione dell’uomo moderno con uno sguardo compassionevole, critico e impietoso.
L’ampio arco cronologico di scrittura – si va da racconti giovanili scritti a diciott’anni a testi risalenti all’anno prima della morte – consente di cogliere l’evoluzione di uno stile che resta però sempre animato da una tensione etica e politica. Per Dagerman, come ribadisce Ferrari nella sua postfazione, l’arte non è mai fine a sé stessa: è un mezzo di intervento sul reale, un veicolo per interrogare le strutture del potere e la solitudine prodotta da una società che emargina chi non si conforma ai suoi meccanismi – economici, morali, simbolici.
Emblematico in questo senso è Dov’è il mio maglione islandese?, il racconto più lungo e forse anche il più bello della raccolta in cui Knut, uno spazzino alcolizzato e isolato dai familiari, si trova a rivivere la perdita del padre in occasione del suo funerale e con essa un dolore tanto profondo quanto inespresso. Dagerman riesce a restituire la desolazione e l’umanità del personaggio in uno stile capace di toccare vertici lirici senza mai indulgere nella retorica. Il ricordo del padre attraverso il maglione– ultimo appiglio affettivo – emerge nella mente di Knut tra le nebbie dell’ennesima sbornia, rivelando una verità esistenziale che riguarda chiunque abbia amato e perso.
In altri racconti, come L’uomo che non voleva piangere, Il condannato a morte o L’uomo di Milesia, l’individuo è stritolato da poteri ciechi, collettivi o istituzionali, che esigono adesione, uniformità, obbedienza. Il signor Storm, protagonista del racconto che dà il titolo al libro, viene messo sotto pressione dai superiori per non aver pianto alla notizia della morte di un’attrice celebre. Rinchiuso in una stanza finché non si deciderà a “spargere qualche lacrima”, piangerà infine non per l’evento imposto, ma per misericordia verso il povero impiegato incaricato di fargli da testimone.
Non meno potenti sono i racconti in cui l’assurdo si fa intimo, privato. In Mio figlio fuma una pipa di schiuma, la solitudine del protagonista nasce da un dettaglio insignificante che diventa pretesto per l’isolamento totale; in Apri la porta, Rickard!, una donna si chiude nella propria stanza per essere finalmente vista e amata, mentre gli altri cantano, fuori, una canzone jazz che suona come una beffa. In queste storie l’alienazione è assoluta, ma Dagerman la racconta con uno sguardo che non cede mai al disprezzo o al pietismo. Il dolore, la vergogna, la vulnerabilità sono trattati come tratti condivisi, universali.
C’è sempre, in filigrana, il tentativo di riscattare queste vite marginali con la forza della scrittura. Anche nei racconti più oscuri, Dagerman lascia filtrare un barlume di fiducia: la convinzione che l’arte – pur difficile, pur non immediatamente accessibile – possa parlare ai ceti popolari e offrire strumenti per comprendere, sentire, resistere. È una letteratura pedagogica, ma non didascalica; è politica, ma non ideologica. Dagerman “abitava le contraddizioni”, come lui stesso scrisse, e le accettava come condizione ineliminabile del vivere e dello scrivere.