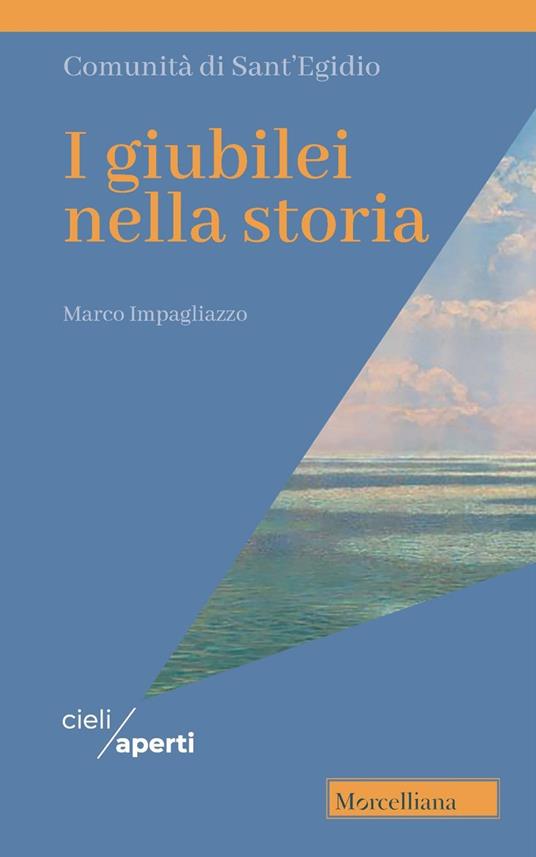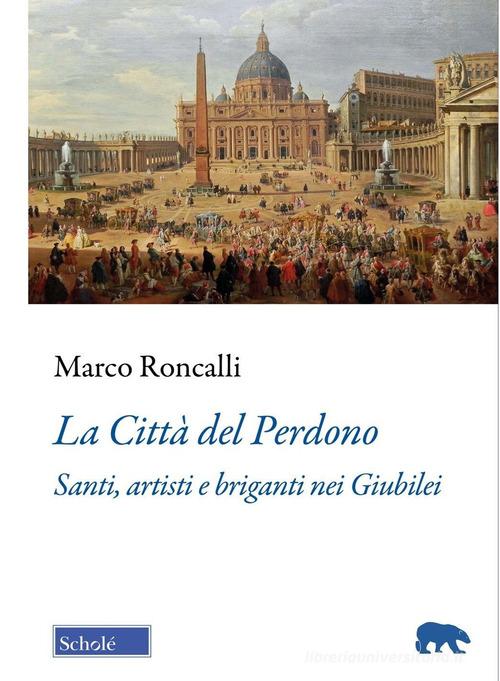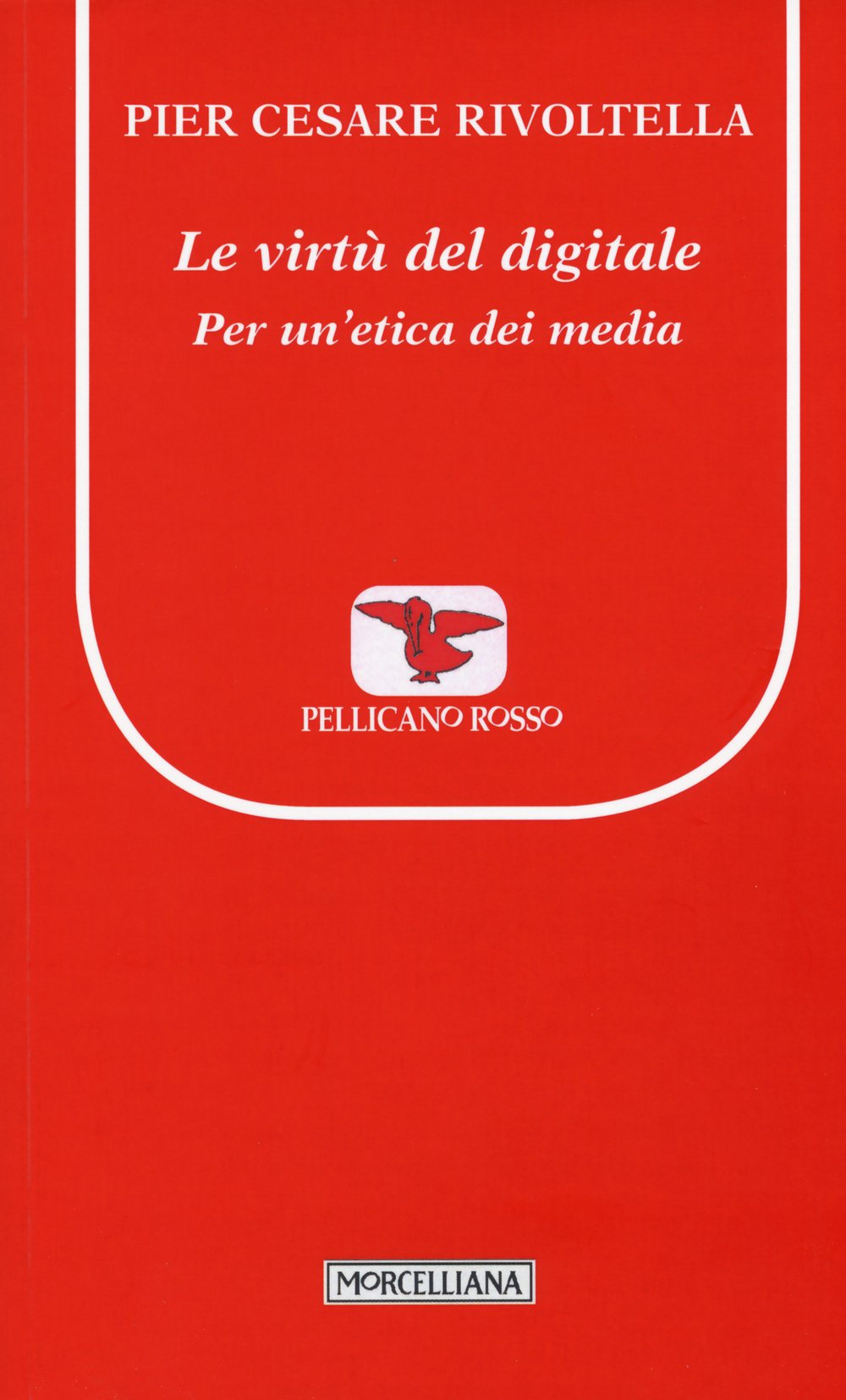Limite e libertà
Dice il saggio

Paolo Becchi
Hans Jonas. Un profilo
Morcelliana, 2025, pp. 200
€ 18
Prima ancora della discesa nell’agone politico, databile intorno al 2013, che lo ha portato a essere considerato l’ideologo dei 5 stelle e più tardi vicino alla Lega, Paolo Becchi ha condotto per lunghi anni attività di ricerca filosofica, concentrandosi principalmente sullo studio della figura e del pensiero di Hans Jonas.
Oggi che la ricerca filosofica è ridiventata la sua principale occupazione ha ripreso in mano, per curarne una nuova edizione con Morcelliana, il profilo di Hans Jonas, uscito per la prima volta nel 2010. Dallo studio di Becchi emerge uno Jonas profondamente attuale, la cui riflessione si oppone in modo rigoroso e consapevole alle derive del transumanesimo, del postumanismo e dello human enhancement.
Il libro di Becchi con Morcelliana consiste in un saggio articolato in tre capitoli dedicati alle fasi della filosofia jonasiana (Dalla gnosi antica al nichilismo moderno. La prima fase della riflessione sotto l’influenza di Heidegger; Il fenomeno della vita. Una filosofia della biologia: il confronto con il pensiero scientifico; Il principio responsabilità. La dimensione etica quale sviluppo di una filosofia della natura organica); due lettere di Jonas (a Ernst Bloch e ad Adolph Lowe) e una conversazione di Jonas con Vittorio Hösle su Anima e corpo. A conclusione del volume una curatissima bibliografia realizzata da Sahayadas Fernando
La figura di Jonas emerge come quella di un pensatore della responsabilità, autore di una proposta etica radicalmente nuova, capace di rispondere alle sfide poste dalla civiltà tecnologica. Con il suo celebre Principio responsabilità (1979), Jonas afferma che l’etica non può più limitarsi a regolare i rapporti immediati tra individui presenti, ma deve estendersi alle generazioni future e alla natura stessa, riconoscendo che l’azione umana ha acquisito una potenza inedita, in grado di modificare irreversibilmente il mondo. Il cuore della sua proposta è un imperativo: agire in modo che le conseguenze delle proprie azioni siano compatibili con la sopravvivenza di un’autentica vita umana sulla Terra. Questo nuovo comandamento morale scaturisce da una concezione dell’essere inteso come vita, una vita vulnerabile, precaria, esposta al rischio del non-essere, ma proprio per questo dotata di valore in sé.
Jonas recupera l’idea aristotelica di una teleologia naturale, opponendosi al riduzionismo materialistico e alla visione meccanicistica della scienza moderna. Per lui, gli organismi viventi non sono macchine, ma espressioni di una libertà originaria, che si manifesta già nel metabolismo e culmina nell’essere umano, l’unico capace di assumere consapevolmente la responsabilità del proprio agire. Questo essere umano, nella prospettiva jonasiana, è ontologicamente distinto dagli altri viventi: possiede una libertà “eidetica”, capace di produrre immagini interiori, immaginare mondi possibili e proiettare intenzionalmente la propria azione. Una tale libertà è il fondamento dell’etica e, al tempo stesso, la prova di una trascendenza inscritta nella natura umana, che Jonas definisce come “iato metafisico” tra l’uomo e l’animale.
La sua riflessione sull’“immagine dell’uomo” diventa allora centrale: essa non è solo il prodotto di un’epoca o di una cultura, ma rappresenta una costante ontologica, una dimensione essenziale che attraversa la storia e che l’etica deve proteggere. L’immagine dell’uomo, dunque, è ciò che l’etica deve custodire, soprattutto in un’epoca in cui la tecnologia minaccia di alterarla irreversibilmente. Jonas mette in guardia contro la hybris dell’essere umano contemporaneo, che vuole superare la propria condizione di vulnerabilità e mortalità, dimenticando che è proprio questa fragilità a fondare la dignità dell’umano.
Le promesse del transumanesimo – prolungamento indefinito della vita, potenziamento cognitivo, creazione di esseri postumani – appaiono a Jonas come un pericolo estremo: quello di distruggere l’umano in nome di un’utopia tecnica. La sua critica è lucida e profonda: non si tratta di rifiutare il progresso in quanto tale, ma di sottoporlo a una valutazione etica rigorosa, che consideri non solo i benefici immediati, ma le conseguenze a lungo termine, e soprattutto i rischi di perdita irreparabile.
Jonas insiste sul fatto che non possiamo manipolare la vita umana senza assumerci una responsabilità profonda: intervenire geneticamente significa compiere un atto irreversibile, che nessuno potrà riparare se le cose andassero male. Per questo, occorre un’etica della prudenza, della precauzione, della salvaguardia – un’etica che dica “no” quando il rischio è la perdita dell’essere.
La filosofia jonasiana si distingue anche per la sua apertura alla trascendenza. Sebbene non fondi l’etica su una religione rivelata, Jonas riconosce che solo una visione del mondo capace di attribuire valore all’essere può fornire un fondamento solido all’etica. La sua ontologia è dunque intrinsecamente assiologica: l’essere è meglio del non essere, la vita è un valore, la libertà è un bene in sé. Questo lo porta ad affermare che la responsabilità etica nasce dal fatto stesso che la vita esiste, e che il suo mantenimento è un dovere originario.
Nella sua riflessione, emerge anche una dimensione teologica implicita: l’essere umano è “a immagine di Dio”, portatore di una dignità che impone rispetto, con o senza Dio. È proprio questa dignità trascendente che rende l’uomo insostituibile, e la sua scomparsa una perdita incommensurabile.
Nel saggio di Becchi si sottolinea anche il percorso biografico e intellettuale di Jonas: dagli studi sulla gnosi, che gli permisero di comprendere l’alienazione e il nichilismo moderni, alla filosofia della biologia, dove elaborò una visione organica della vita, fino alla fase più matura, in cui formulò la sua etica per l’era tecnologica. Ogni tappa è animata da una coerenza profonda, che lega la riflessione teorica all’urgenza delle questioni concrete. Jonas è infatti un filosofo che non si rifugia nell’astrazione, ma affronta il presente con coraggio, chiedendo alla filosofia di essere guida per l’azione.
In Italia, la sua opera è stata accolta inizialmente con interesse per il Principio responsabilità, soprattutto in opposizione al Principio speranza di Bloch (elaborato in fasi successive per oltre vent’anni a partire dalla fine degli anni ’30), ma solo più tardi è emersa l’importanza della sua filosofia della vita e degli studi gnostici. La proposta di Jonas è stata oggetto anche di critiche: alcuni lo accusano di conservatorismo, altri di ricorso a una metafisica superata. Ma Becchi sottolinea come, al contrario, proprio la profondità teoretica di Jonas, il suo legame con la tradizione filosofica ebraica e cristiana, la sua attenzione per l’ontologia e la teleologia, siano oggi strumenti preziosi per affrontare le sfide poste dall’intelligenza artificiale, dalla biotecnologia, dalla crisi ecologica.
Jonas non propone soluzioni semplici, né si abbandona a visioni catastrofiste, ma invita alla riflessione, al rispetto per la vita, alla consapevolezza dei limiti. Solo un’etica fondata su questi principi può dare senso all’azione umana in un mondo sempre più dominato dalla tecnica. La sua voce è una voce profetica, che richiama l’umanità alla sua essenza più profonda: la responsabilità verso ciò che è fragile, verso ciò che ancora non esiste, verso l’immagine dell’uomo. Una filosofia che si fa custodia dell’essere, presidio contro l’oblio del limite, e appello alla salvaguardia del futuro.