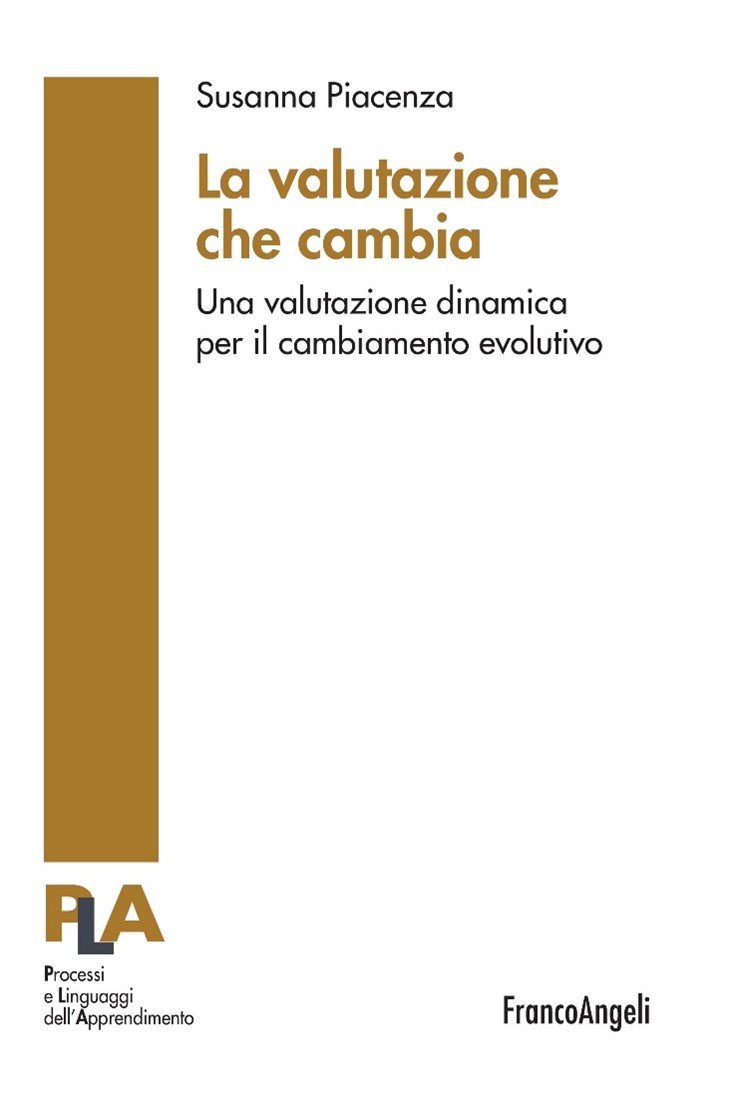Colonialismo e Sherazade ad Almada

LISBONA – La città di Almada quest’anno ha compiuto cinquant’anni. Il Festival de Almada, diretto dal regista Rodrigo Francisco pochi meno avendo raggiunto la 41esima edizione. Almada guarda Lisbona, dopo il grande ponte rosso, Il Cristo di Almada protegge Lisbona, ad Almada è nato Leao, l’ala sinistra del Milan e della nazionale di Cristiano Ronaldo.
Dove risiede l’origine della rabbia, i primordiali vagiti dell’astio, l’abc dell’acredine sociale? Siamo negli anni ’60 nel nord rurale del Portogallo in quest’affresco che l’attrice Cucha Carvalheiro, qui autrice e narratrice a cucire le varie scene fuori e dentro la scena kantorianamente, disegna miscelando “Tre sorelle” di Cechov (qui Aurora, Amelia e Augusta), qualche rimando al “Giardino dei ciliegi” (questa grande casa in campagna limbo e parentesi, salvezza e alibi) mixando il tutto con pellicole come “L’albero di Antonia” o “Speriamo che sia femmina” (per una storia orgogliosamente tutta al femminile). “Fonte da raiva” (Fonte di rabbia, appunto) ci parla di colonialismo ma anche della situazione della donna che in quegli anni comincia in maniera consapevole a porsi domande sul matrimonio, sul divorzio, sull’omosessualità, sui loro diritti, sulla politica, sulla guerra. Di grande impatto la scena che si apre con rami, pietre e foglie a terra come se fosse passato un uragano che porta distruzione ma anche cambiamento e rinascita. Dall’alto calano, come funi per fuggire, tanti rami o liane di foresta tra i quali vi è immerso un salotto borghese di divani a fiori e tè servito, liane come alghe in uno stagno, liane come reti che le imbrigliano in quella situazione – comfort zone, corde verdi che in qualche modo le nascondono, le confondono celandole nella natura. In quell’ambiente si sentono protette anche se la voglia di fuggire e andarsene a tratti preme; uniche figure maschili un missionario rientrato a casa e il promesso sposo ribelle di una delle sorelle. Ne viene fuori una sorta di “Via col vento” in salsa lusitana. Altre scene coreografiche che ci hanno colpito: i panni scossi con la polvere che si alta in volute di fumo, le lenzuola roteate sopra la testa come le danze delle mante nell’oceano, la farina che vola come nebbia di mistero e nostalgia. Un’epopea familiare che scandisce un tempo bucolico pronto a cambiare, l’attimo prima della trasformazione.
“Le mille e una notte” diventano “1001 Noites-Irma Palestina” della compagnia storica portoghese Teatro O Bando che quest’anno compie, anche lei, cinquant’anni di attività, formazione e spettacoli. Una coreografia cupa e notturna di sedie attorno ad un’arena dove si muove una macchineria meccanica simile ad una giostra, un carro da Far West, quasi Cavallo di Troia, macchina di ferraglia uscita da Mad Max, torre o ponte levatoio. Danzano come a frustarsi, a battersi sul petto come mea culpa di espiazione ora come a farsi scivolare le cose di dosso, a lavarsene le mani nell’indifferenza internazionale, adesso sembrano saltare sulle mine ora fuggono, adesso implodono dolorosi, rimangono dei corpi a terra, urlano come bestie alla catena, hanno le mani sugli occhi a coprirsi la faccia, corrono come fossero falciati da cecchini invisibili dentro un immaginario cerchio di zolle secche aride, chiusi e rinchiusi, dal quale non si può scappare. Corpi ammassati, cani alla catena danzano come presi per il collo soffocati. Ogni quadro inizia con il classico “raccontami una storia” ma qui sono vicende drammatiche, senza redenzione né salvezza.