Diario scolastico
Tu chiamale se vuoi emozioni
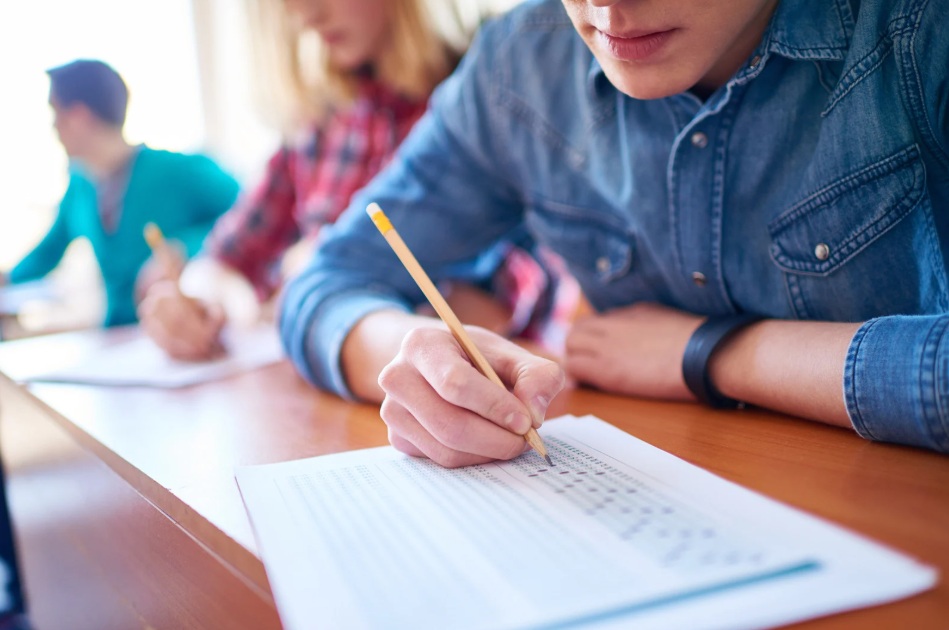
Tra le esperienze più stranianti di un docente degli istituti di istruzione secondaria superiore si inscrive a pieno titolo quella relativa al rapporto che si ha con i propri studenti di quinta nelle ultimissime settimane di lezione. Uso scientemente l’aggettivo “straniante” perché questo è proprio un periodo in cui la normalità scolastica viene sovvertita, senza peraltro generare spinte necessariamente eversive. È il carnevale della scuola, un lasso di tempo in cui tutto si rovescia e i normali rapporti di forza vengono destabilizzati da un senso di fine imminente. È questa, infatti, una fase indubitabilmente di passaggio, una sorta di tregua smilitarizzata dalle interrogazioni e dai compiti in classe, una zona temporale franca in cui ciascun soggetto del dialogo educativo assume contorni umani e si sveste della forma, vagamente pirandelliana, di insegnante e studente. Forse, per qualche manciata di giorni, si diventa capaci di guardarsi davvero negli occhi, e di farlo da adulti, seppur di età, esperienza e prospettive differenti. I giochi, perlopiù, sono fatti, le valutazioni assegnate, i programmi, magari dopo aver arrancato con ultime faticosissime spiegazioni, terminate. Così, si ripassa insieme, cercando di intercettare le possibili domande dei famigerati commissari esterni e si proiettano immagini o testi sulla lavagna multimediale, per saggiare le reazioni individuali e la capacità di elaborare un percorso multidisciplinare che si sviluppi proprio da quel suggerimento, secondo quanto prevede la normativa che regola da qualche anno l’esame di stato conclusivo. Ma non si fa solo questo, dal momento che la maggior parte delle volte, con la maggior parte delle classi, questo diventa un periodo in cui, anche se non lo si riconosce razionalmente e ad alta voce, si vive un senso di commozione venata di nostalgia.
GLI ULTIMI GIORNI DELLE QUINTE CLASSI
Durante gli ultimi giorni di una classe quinta, ad esempio, il docente avverte l’inevitabile quanto implacabile tirannia del tempo che scorre, lo sbriciolarsi della propria esistenza, ossia una serie di sensazioni perturbanti anche se non necessariamente vissute in modo drammatico. Ma è fuori discussione che ogni fine corsa, ogni frase che termina con un punto fermo, ogni ciclo concluso segnino un traguardo e, insieme, offrano tutta insieme la consapevolezza che un altro passo è stato compiuto verso il fondo della propria esistenza. Con questo indescrivibile retrogusto, così, l’insegnante non può esimersi dal riavvolgere le esperienze passate, di tornare ai volti ancora infantili di alcune studentesse e alcuni studenti, per come gli si erano presentati tre o cinque anni indietro; non può fare a meno di ripensare con un sorriso alle arrabbiature, alle delusioni, alle brusche frenate dopo apparenti accelerazioni che hanno caratterizzato l’intero percorso educativo, finendo per considerarli, montalianamente come le trappole, gli scorni, di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ma un docente non può evitare anche di ripensare ai piccoli o grandi successi educativi, a quel particolare allievo che ha cambiato il suo modo di vedere il mondo, non tanto perché ora pensa il mondo come lo pensa il docente, ma per il semplice fatto di riuscire a pensarlo, il mondo, in qualche modo, lontano dalla superficialità.
STUDENTI: LE DISCESE ARDITE E LE RISALITE DEL FUTURO
Gli studenti, poi, sembrano guardare il plesso scolastico e le aule non più come luoghi di tortura, ma con lo stesso sguardo nostalgicamente commosso della Lucia manzoniana nella celebre pagina dell’Addio ai monti. Sono più o meno consapevoli che la loro esistenza stia per subire una trasformazione radicale. Avvertono che il mondo adulto stia bussando perché vuole entrare nelle loro vite. Percepiscono, anche, di essere sull’orlo di un fosso nel quale è bene evitare di cadere, sia perché privi di quel sostegno che la scuola, volente o nolente offre, sia per il fatto che il rischio di farsi male è molto alto, data la scivolosità del terreno contemporaneo. Comprendono, dunque, che è il tempo di fare un salto verso un domani necessariamente incerto, lasciando la mano protettrice di un sistema scolastico che contiene, organizza, guida, esorta, sgrida e premia, per inoltrarsi in contesti di studio o lavorativi in cui occorre diventare autonomi. Prendono coscienza, in altri termini, di quanto sia necessario e nel contempo difficile individuare un traguardo che costituisca proprio ciò che la parola “traguardo” contiene, ossia un punto da cui trans-guardare, guardare oltre, per dare una direzione ai propri passi. Ma, come ho già avuto modo di sottolineare in altri articoli, è anche il momento in cui il chiasso educativo a cui spesso noi adulti li abbiamo esposti finisce con il lasciare fastidiosi acufeni, producendo sibili che generano forme di labirintite esistenziale. Diventano consapevoli che la vita è un intrico complesso di relazioni, scelte, occasioni e programmi, perché il mondo stesso si è spalancato moltiplicando i propri linguaggi fino a rendersi, a tratti, incomprensibile.
SETTIMANE DI AUTENTICITÀ
È proprio in questo tempo così autentico, dunque, che la relazione tra docente e discente vive il suo momento più bello e coinvolgente. Un periodo in cui, come si diceva, ci si può guardare davvero negli occhi e in cui i giovani possono scoprire che il sapere è viatico irrinunciabile per affrontare gli sbalzi tellurici della vita, magari anche per prendere decisioni inedite rispetto al conformismo dominante, scegliendo di muoversi in diagonale e non in linea retta, come tutti si aspettano da loro. È un momento sospeso di verità, nel quale si può fare a meno di giocare un ruolo e in cui si può parlare francamente, aiutando i ragazzi a capire che, manipolando Schopenhauer a proprio vantaggio, occorre aprire se stessi sia alla lotta sia alla contemplazione, se si vuole poter vivere una vita che non lasci un retrogusto amarognolo di rinuncia e di sconfitta. Capire che bisogna farsi lottatori per esprimere e realizzare desideri, per attivare le energie necessarie a costruire e realizzare i propri sogni, perché la vita coincide con un saper sognare, un saper immaginare, un saper evocare, ma, da un altro punto di vista, vuol dire anche comprendere che ci si deve trasformare in contemplatori, in persone capaci di resistere all’effimero, in grado di rifiutare gli attaccamenti inutili e morbosi rilanciati da una cultura superficiale e consumistica. Farsi contemplatori per apprezzare la semplicità di un silenzio e la bontà di una relazione autentica per contrapporsi a una nevrotica cultura del fare a ogni costo e del correre senza posa, che per certi versi caratterizza il nostro tempo complesso. Le ultime settimane di scuola sono un’occasione, dunque, che non va sprecata, occupandole solo con un ripasso forsennato, ma usata per passare le consegne tra generazioni differenti, affinché le nostre ragazze e i nostri ragazzi comprendano che è nel loro diritto alzare lo sguardo e, insieme, un loro dovere immaginare un mondo migliore.



