Riflessioni
Solitudine urbana
tra deserti e nuove oasi di comunione fraterna
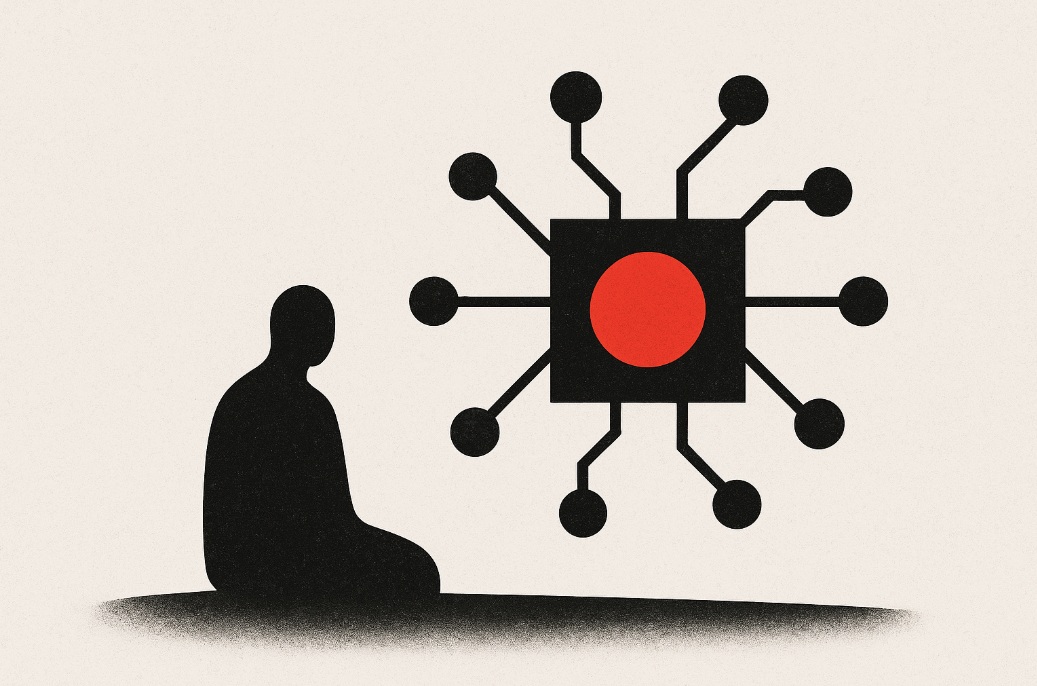
Le metropoli contemporanee ospitano milioni di persone, in questo modo capita di vivere molto vicini gli uni con gli altri. Eppure, non è raro avvertire una lontananza persino tra chi abita sul medesimo pianerottolo; accade che tra dirimpettai si estenda un deserto relazionale che può andare oltre ogni umana misura, concretizzandosi in un’aridità di rapporti che evidentemente la prossimità fisica non riesce a colmare.
Un silenzio corrosivo s’insinua tra la moltitudine indistinta dei volti che possiamo incrociare lungo le nostre traiettorie abitudinarie; in realtà, avanziamo rapidamente incontro alla solitudine, un’esperienza insieme contraddittoria e lacerante. La paradossalità che si sperimenta, in pieno contesto urbano, è quella di un isolamento troppo di sovente forzato. L’anonimato metropolitano ha trasformato le relazioni interpersonali in fugaci incontri tra sconosciuti. L’eterogeneità, anziché arricchire, spesso disperde, mostrandoci il nostro prossimo come una figura dai contorni evanescenti; a ciò si aggiungono la sovrastimolazione dei social media e l’interazione con le intelligenze artificiali, che non aprono alle relazioni, anzi spingono al ritiro, intrappolando l’essere umano in una dinamica perversa di isolamento volontario.
Nel 2023 il Surgeon General – la massima autorità sanitaria americana guidata da Vivek Murthy – aveva diffuso la nota ricerca Our Epidemic of Loneliness and Isolation. Lo studio ha tracciato un’istantanea della situazione, delineandola come una malattia: da un lato evidenzia una solitudine vissuta come esperienza soggettiva e angosciante, dovuta nella maggioranza dei casi a un isolamento percepito o a relazioni significative inadeguate; dall’altro, un isolamento sociale, caratterizzato dall’assenza di relazioni interpersonali, dalla mancata inclusione nei ruoli sociali o appartenenza a gruppi. Questa duplice crisi comporta non soltanto un netto calo delle interazioni tra simili, ma anche il declino della fiducia nel prossimo e il crollo del coinvolgimento a livello comunitario. Un dato significativo è il tracollo dell’adesione a gruppi religiosi, che in America è scesa dal 70% nel 1999 al 47% nel 2020, accentuato anche dall’evento pandemico. A questo punto un pensiero va al fenomeno degli hikikomori in Giappone (approdato recentemente anche in Europa), in cui, soprattutto giovani adolescenti, si ritirano nella reclusione delle proprie mura domestiche. Ben comprendiamo allora come quella seduzione, dipendente in larga misura dalla tecnologia, alimenti la spirale, perché mentre promette allettanti connessioni digitali, trasforma i device in altari di relazioni illusorie, consacrando una solitudine tanto volontaria quanto inconsapevole, grottesca nella sua pretesa di comunione.
Il malessere appena abbozzato, quando giunge alla sua saturazione massima, origina una frattura in grado di presentare, ad alcuni esseri umani, la necessità di ritornare a scorgere l’espressione reale dei volti, di sentirsi parte di una comunità non virtuale, dove poter trovare, da un lato, un luogo per dare seguito alle proprie aspirazioni e, dall’altro, sollecitare a riprendere contatto con la parte più interiore e spirituale di sé.
Gli strumenti della psicologia rivelano che vi è una distinzione fondamentale nell’esperienza della solitudine in quest’epoca: quella tra loneliness, una condizione di solitudine corrosiva e tossica derivante da perdite affettive e dall’incapacità di rimanere con sé stessi, e aloneness, una solitudine feconda intrisa di senso, perché a poco a poco si è giunti ad abitare con sé – esperienza che potremmo inserire nell’orizzonte monastico dell’habitare secum, l’arte di dimorare in pace con la propria interiorità. Capiamo che per vivere proficuamente la solitudine è imprescindibile possedere delle competenze relazionali mature, poiché chi coltiva interiormente la prossimità tende a sviluppare anche quella del dialogo con se stesso. La capacità di fare fronte a un isolamento prolungato esige dunque un equilibrio psichico ben collaudato e una salda architettura interiore, qualità che si consolidano solamente attraverso un’esperienza via via più intensa di Dio.
L’epoca post-pandemica ha reso manifesto un fenomeno di particolare rilevanza: la trasformazione della solitudine da condizione subita a deliberata scelta esistenziale. In questo contesto, siamo chiamati a trovare nella città stessa, quale territorio relazionale desertico, un luogo dove ricercare nuove oasi di umanità. Emblematiche sono le numerose realtà di coliving spirituale, rappresentando un’evoluzione dei modelli abitativi comunitari, possono coniugare la condivisione di spazi con una dimensione di crescita interiore intenzionale. Queste esperienze, a vocazione specificatamente spirituale, pongono al loro centro la ricerca di senso tanto personale quanto collettivo, affiancandovi pratiche di consapevolezza, quali la meditazione, il dialogo profondo e il silenzio interiore; perseguono, inoltre, un’etica della condivisione che trascende l’aspetto meramente materiale. Molte di queste comunità integrano pratiche ecologiche, agricoltura o attività artigianali quali componenti integranti.
Inoltre, il panorama contemporaneo ha creato condizioni particolarmente favorevoli per quanti, ispirandosi al monachesimo antico, ricercano nella solitudine un rinnovato dialogo con il trascendente. Assistiamo infatti all’emergere di varie forme di eremitismo urbano, spesso svincolate dalla vita consacrata, che optano deliberatamente per declinazioni singolari d’isolamento ai margini delle dinamiche sociali convenzionali, pur ponendosi al servizio delle comunità locali. Un servizio che apporta benefici tangibili in termini di ascolto, guida e discernimento spirituale, rispondendo ad aree di estremo bisogno nei contesti urbani.
Carlo Carretto, un propugnatore di queste forme, ci ha lasciato una chiave interpretativa del deserto che questi uomini e donne si sentono chiamati a ricercare: «Il deserto lo puoi trovare ovunque, anche in città. Se sai amare ciò è possibile. È solo un po’ difficile. E non dimenticare che deserto non significa assenza di uomini ma presenza di senso» (Ogni giorno un pensiero, p. 245). Tale intuizione trova conferma nella tradizione patristica, dove già Epifanio di Salamina (IV secolo) osservava: «Alcuni degli uomini che conducono vita solitaria abitano nella città, altri risiedono anche nei monasteri e si ritirano in isolamento lontano dagli uomini» (Sulla fede. Compendio della fede e della Chiesa XXIII,2). In tempi recenti si registra l’esperienza dell’eremita Adriana Zarri. Questa monaca illustra eloquentemente il suo percorso in un celebre saggio, infatti, suo proposito era quello di «ricavarsi una nicchia di silenzio e di solitudine, nella frenesia della nostra vita quotidiana»; esso scaturiva dalla convinzione che «nel deserto non ci si ritira, quasi che fosse un guscio, al riparo dalle difficoltà di tutti. Nel deserto si entra, si cammina, ci si immerge, assumendo la storia e i problemi di tutti» (Un eremo non è un guscio di lumaca).
Questi solitari di oggi vivono la loro esistenza testimoniando l’unicità della propria vocazione battesimale; pur avvalendosi degli strumenti tecnologici e mantenendo una connessione aperta con la realtà circostante, organizzano la vita secondo le prassi del silenzio, della preghiera e della disciplina ascetica in chiave moderna. In tal modo realizzano concretamente l’intuizione profetica del teologo ortodosso Pavel Evdokimov, che propugnava il monachesimo interiorizzato; nel suo celebre articolo del 1963 afferma: «Esiste una terza soluzione. Senza esprimere giudizi affrettati, si può per lo meno dire che tale soluzione dovrebbe appropriarsi delle due soluzioni già esistenti interiorizzandole [cenobitismo ed eremitismo], ovvero appropriarsi dei loro principi al di là delle loro forme precise. “Voi non siete di questo mondo, voi siete nel mondo”: questa parola del Signore preconizza un ministero particolarissimo, che è quello di essere segno, rinvio al “totalmente altro”; tale segno una volta era realizzato diversamente qui e là, mentre ora – così sembra – si fa vedere al di sopra della città e del deserto, in quanto è chiamato a superare ogni forma, al fine di potersi esprimere ovunque e in ogni circostanza […]. Non esiste che una sola spiritualità per tutti – vescovi, monaci o laici – senza alcuna distinzione quanto alle esigenze che pone, ed è la spiritualità monastica. Ora, questa è formata da monaci-laici, il che dà al termine “laico” un senso radicalmente spirituale ed ecclesiale» (Monachesimo interiorizzato, pp. 13-15).
Un’altra forma di testimonianza è la comunità di Madonna House, istituita da Catherine De Hueck Doherty nel 1947. Questa costituisce una traduzione paradigmatica di tale ideale nella dimensione comunitaria, dove laici, sacerdoti e religiosi condividono il medesimo progetto di vita comune, vincolati da promesse di povertà, castità e obbedienza, e sostenuti da un’economia fondata sul dono e sull’ospitalità.
In queste esperienze si manifestano i tratti distintivi dell’eremitismo contemporaneo, che oppone all’individualismo imperante attraverso la pratica della reciprocità, l’adozione della solitudine volontaria quale via di arricchimento relazionale, e l’ancoraggio territoriale, molto vicina alla stabilitas loci monastica, che non sacrifica l’apertura universalistica. All’interno di questa geografia di solitudini feconde si compie il senso ultimo della ricerca spirituale, condensata nelle parole di Adriana Zarri: «La solitudine non è isolamento, ma incontro e comunione».



