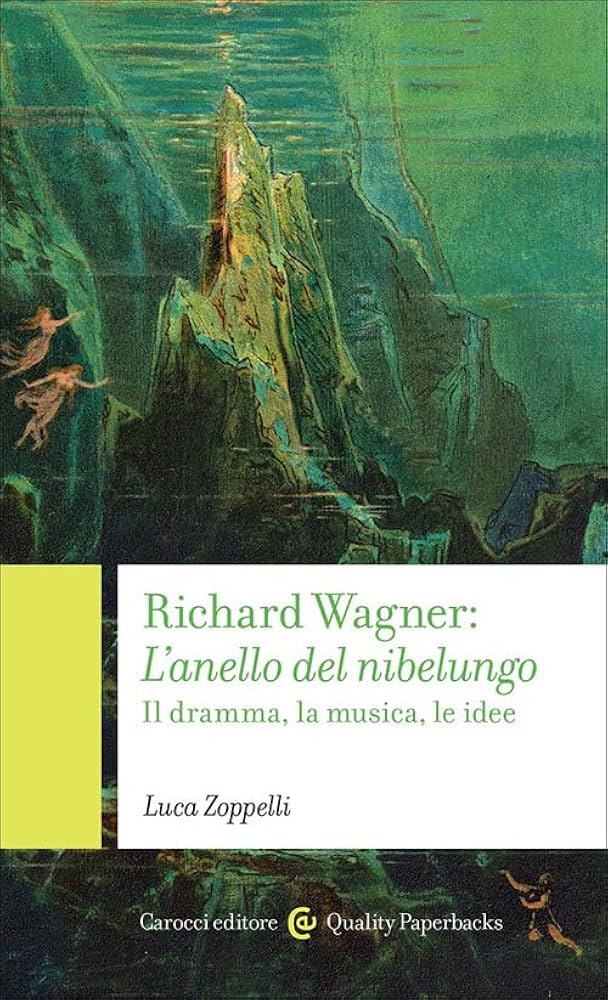Discussioni pedagogiche

O Signore, non correggermi
nella tua
ira,
non castigarmi nel
tuo sdegno.
Ritorna, o Signore,
liberami;
salvami, per la tua
misericordia.
(Salmo 6)
Lidia: il desiderio di vita, che fin da subito si presenta come filo rosso del Libro dei Salmi, prende voce in differenti modi. In questo caso, urla. E non si tratta solo di un grido disperato per la vita che viene meno: nella misura in cui è rivolto ad un altro, al Signore, l’urlo si fa interrogazione – «perché tutto questo?» – e invocazione – «liberami, Signore». Ma qui il grido nasce da un’esperienza di dolore letta nell’orizzonte della colpa. Ci fa problema questa associazione tra il male subìto e la colpa che ne sarebbe la causa. Eppure, ancora oggi sentiamo quel legame oscuro, o almeno ci esprimiamo in termini che sembrano avvalorarlo: «che cosa ho fatto di male per meritarmi questo?».
Angelo: come spiegare questa associazione? Alcuni vi vedono l’estremo tentativo di tenere sotto controllo ciò che sfugge alla comprensione: meglio pensare di essere colpevoli, piuttosto che riconoscere il non senso di certe situazioni. Se individuo la causa, allora il mio dolore è più sopportabile, strappato a un’assurdità ancora più dolorosa del male stesso. Altri applicano alla propria situazione qualcosa che, in effetti, vediamo succedere: e cioè, che certi mali sono esiti di errori e scelte negative. In entrambi i casi si ricorre allo schema «delitto-castigo»: per gli uni uno schema imposto alla realtà, pur di trovare una spiegazione; per gli altri una correlazione che può essere riconosciuta in molte situazioni: la crisi ecologica che affligge il pianeta ne è un esempio. Anche il nostro salmista abbraccia questa chiave di lettura ma la estende e, facendolo, la muta di significato. Il suo dolore non lo vede come sanzione punitiva per una colpa commessa ma come correzione necessaria per ritrovare la vita buona. Più che opera di un Dio giudice, la sofferenza da lui patita è attribuita ad un Dio pedagogo.
Lidia: è vero, qui Dio non viene dipinto come il giudice imparziale, che applica le sanzioni previste dalla legge. Qui Dio è coinvolto nella relazione, si arrabbia. L’ira di Dio, che a molti fa problema, è espressione di partecipazione, di disappunto nei confronti di una creatura amata che vede andare fuori strada. In fondo, l’ira è l’altra faccia dell’amore. Dunque, la grave malattia che affligge l’orante viene letta da quest’ultimo come segno di un necessario intervento educativo da parte di un Dio a cui sta a cuore la vita del suo credente. E la sua domanda, che la correzione non sia troppo severa, nasconde una discussione irriverente del modello educativo di Dio. L’orante, pur nel dolore, non rinuncia all’ironia e osa contestare la pedagogia divina. E non perché questa non funzioni, tutt’altro! Funziona così bene che l’orante è a un passo dalla fossa. Ma se, alla fine, chi deve essere educato muore, è Dio stesso a rimetterci poiché perde chi lo loda. E dunque, conclude l’orante, datti una regolata Dio! Cambia metodo educativo e sbrigati a liberarmi, poiché nella morte non c’è memoria di te; chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti?
Angelo: mi interroga questa interpretazione simbolica della malattia. Molti la trovano ingenua e scorretta, anche se qui è più complessa di come la rappresentiamo per distanziarcene. Pur con le sue ambiguità, questa lettura ha il merito di spostare la domanda sul «perché», ovvero sulle cause, per reindirizzarla su «a che scopo». La diagnosi perde il suo primato a favore della prognosi. Alla diagnosi «medica» o «storica » si sostituisce quella «simbolica», dove in gioco è la qualità della vita libera. Il quadro clinico lascia il posto a quello esistenziale; gli eventi non parlano più di un’oggettività subìta ma di un protagonismo che può essere agito persino sul letto di morte. Lidia: Ma se è questo che conta, allora si capisce l’invocazione del salmista. La correzione funziona se non mette fine a quella vita che intende correggere. Se l’orante intuisce l’appello nascosto nella malattia, ovvero l’invito a tornare al Signore, allo stesso tempo chiede che anche il Signore ascolti la sua invocazione, il suo grido: «ritorna, Signore, fino a quando?». «Ritornare» è il verbo della conversione. Perché il dialogo tra Dio e l’umanità prenda forma è necessario che entrambi si convertano, orientando i loro passi in direzione dell’altro, riconoscendolo come compagno di viaggio necessario. In fondo, la trama di questa invocazione è configurata sul bisogno di un reciproco riconoscimento, più forte del disconoscimento che fa morire prima di morire. Nella solitudine, gli altri sono dei nemici e la vita si riduce ad inondare di pianto il letto. Ma insieme al Signore, si accende un altro sguardo sull’esistenza e si può tornare a vivere, nonostante tutto.