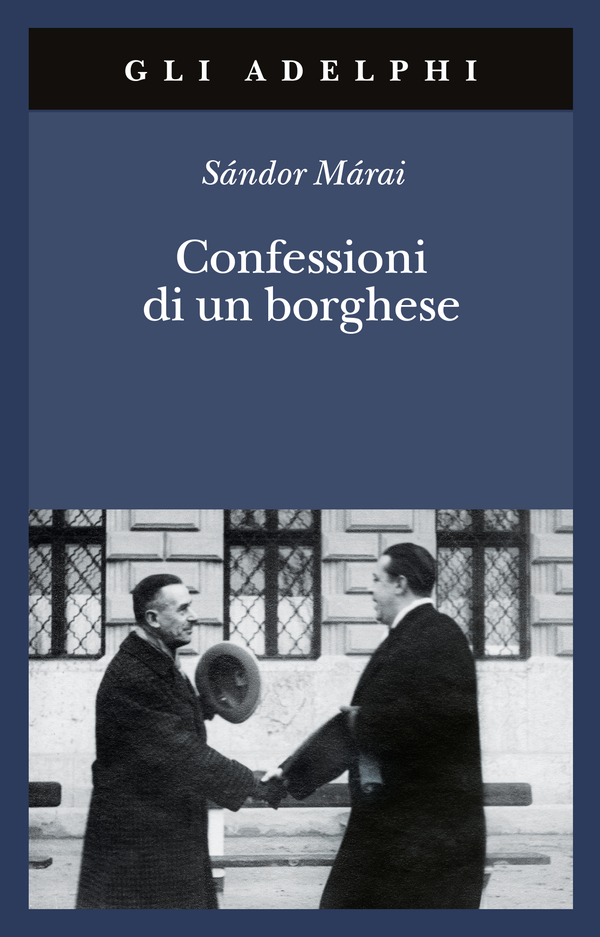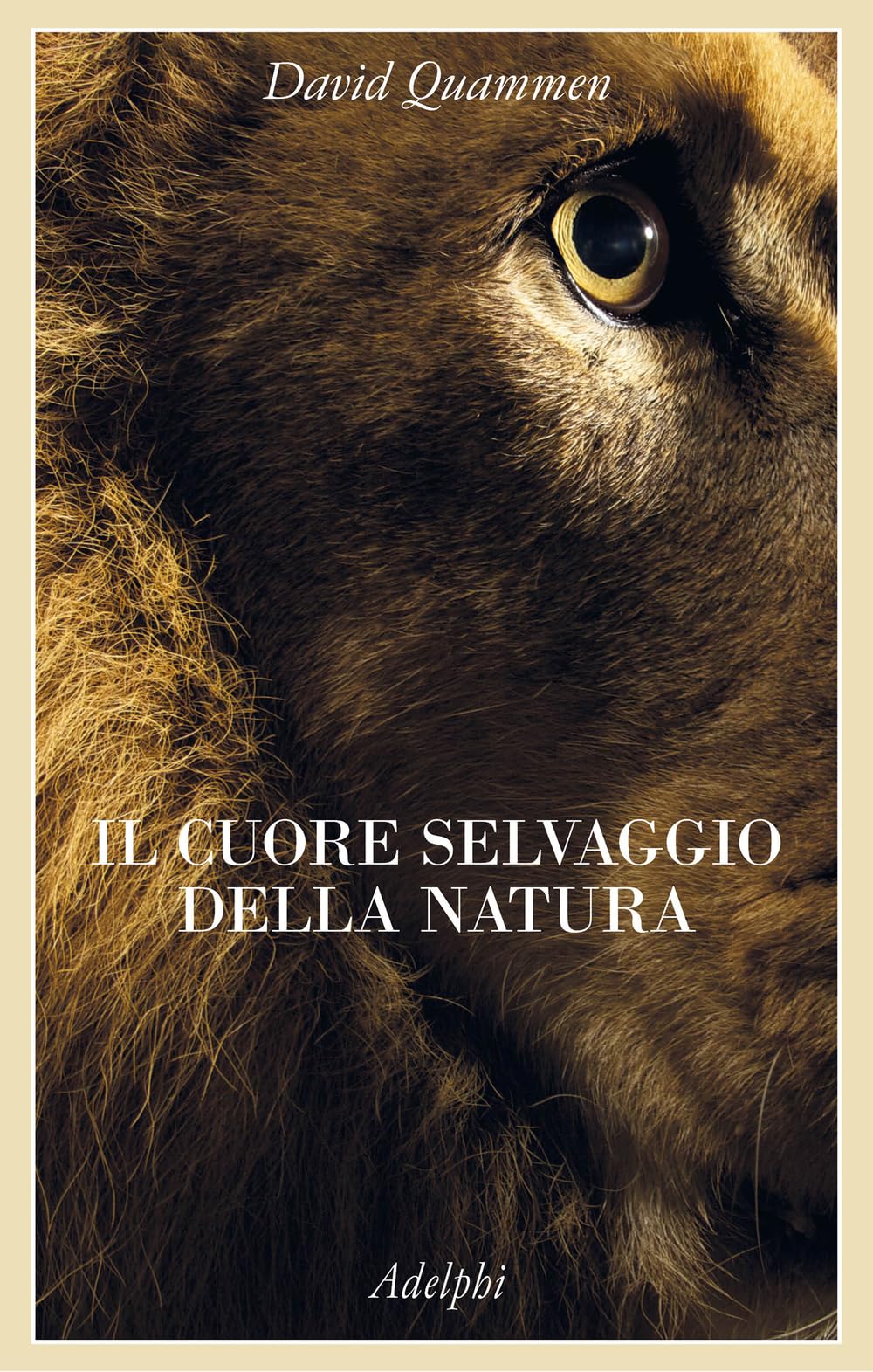Occidente in declino
Dice il saggio

Vittorio Coletti
Figure della crisi (Vol. 1 e 2)
Il Canneto Editore, 2023 e 2024, pp. 148 e pp. 224
€ 16 e € 15
Vittorio Coletti, linguista e lessicografo italiano, membro dell’Accademia della Crusca, consegna al pubblico un’opera forte che lascia il segno con i due volumi di Figure della crisi (Il Canneto Editore, 2023 e 2024). Attraverso una narrazione ibrida tra saggio e fiction, Coletti esplora le contraddizioni della società contemporanea, mettendo in scena personaggi emblematici che incarnano le tensioni etiche, politiche e culturali del nostro tempo. I due volumi, seppur distinti, sono legati da un filo conduttore: l’analisi lucida e disincantata di un Occidente in declino, tra crisi identitarie, sfide migratorie, e il crollo delle istituzioni tradizionali.
Il primo volume si concentra su due figure chiave: un prete e un politico, entrambi anziani e disillusi, alle prese con ruoli sociali sempre più evanescenti. Il prete, protagonista del primo racconto, è un uomo in crisi con la propria fede, stretto tra l’obbligo di accogliere migranti in una sperduta parrocchia di montagna e il fallimento di quell’accoglienza, che si trasforma in tragedia a causa dell’incomunicabilità e della diffidenza reciproca. La sua crisi spirituale riflette quella più ampia della Chiesa, ridotta a “religione senza fede”, dove il prossimo ha sostituito Dio, ma senza offrire risposte al vuoto esistenziale.
Il politico, narrato in terza persona con tono ironico e distaccato, è un ex socialista diviso tra un “cervello di destra” e un “cuore di sinistra”. La sua storia è un affresco della sinistra italiana, irrimediabilmente svuotata, incapace di proporre visioni alternative e intrappolata in stereotipi post-ideologici. Coletti tratteggia con amarezza l’impotenza della politica di fronte a fenomeni epocali come le migrazioni, l’ecologia, e il populismo, descrivendo un sistema in cui la retorica ha sostituito l’azione.
Il secondo volume amplia lo sguardo ad altre due figure simbolo: una pubblico ministero e un professore universitario. La pm, travolta dalle ansie personali e professionali, incarna il conflitto tra giustizia e giustizialismo, tra il rigore della legge e la freddezza di un sistema spesso distante dalle esigenze reali della società. Il professore, invece, rappresenta la crisi del sapere umanistico, schiacciato tra burocrazia, metodologie didattiche demenziali, e un’istruzione sempre più svuotata di significato. Attraverso queste figure, Coletti riflette sul crollo delle istituzioni che un tempo erano pilastri della civiltà occidentale: la giustizia, la scuola, l’università.
Coletti adotta uno stile narrativo originale, ibridando saggio e racconto, con una prosa tesa e spesso amara. I personaggi, pur essendo immaginari, sono “figure” più che individui: archetipi che sintetizzano le contraddizioni di un’epoca. La scelta di alternare prima e terza persona (per il prete e il politico nel primo volume) sottolinea la distanza tra l’introspezione tragica e l’ironia disillusa.
I temi centrali sono la crisi della democrazia e delle ideologie, con un Occidente incapace di rispondere a sfide come le migrazioni, il collasso ambientale, e il ritorno dei nazionalismi, la solitudine dell’intellettuale, che osserva con lucidità il declino ma non trova soluzioni. Coletti, attraverso i suoi personaggi, ammette di non avere “diagnosi certe”, ma invita a uscire dai conformismi. La religione e la politica sono ormai istituzioni svuotate, dove il prossimo ha sostituito Dio, e il populismo ha eroso ogni progetto collettivo. L’opera è un j’accuse contro la superficialità del dibattito contemporaneo. Tuttavia, il tono dominante è quello della sconfitta: Coletti non offre vie d’uscita, ma si limita a descrivere il naufragio. “Sono pagine amare, tese e offese, che chiedono di essere lette non per trovare risposte, ma per imparare a porsi le domande giuste.” Questo potrebbe lasciare il lettore con un senso di impotenza. Figure della crisi è un libro scomodo che costringe a confrontarsi con domande scomode. Non è un’opera consolatoria, ma un grido di allarme: Coletti ci ricorda che, per quanto difficile, l’unica speranza risiede nel coraggio di guardare in faccia la crisi, senza illusioni.