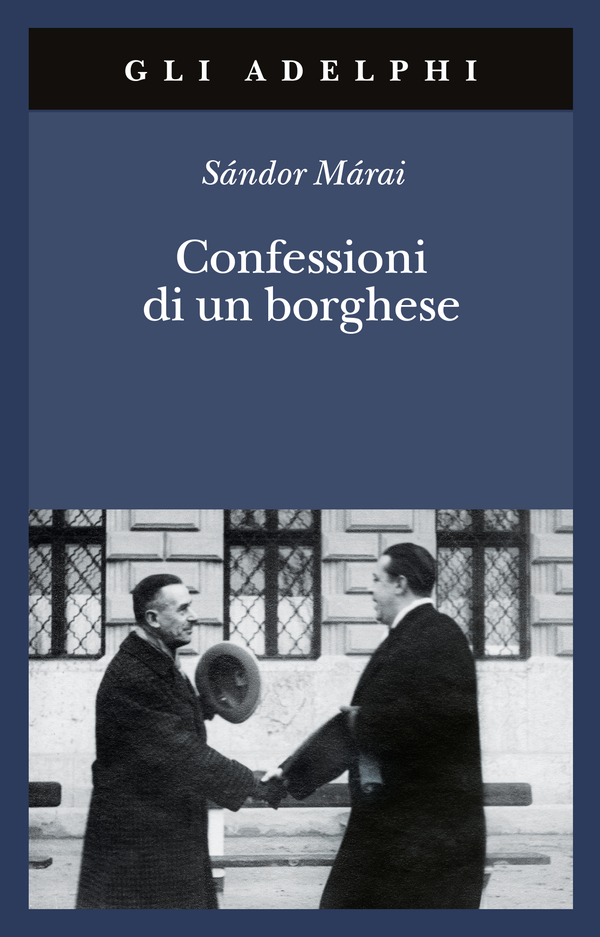Platone segreto
Dice il saggio
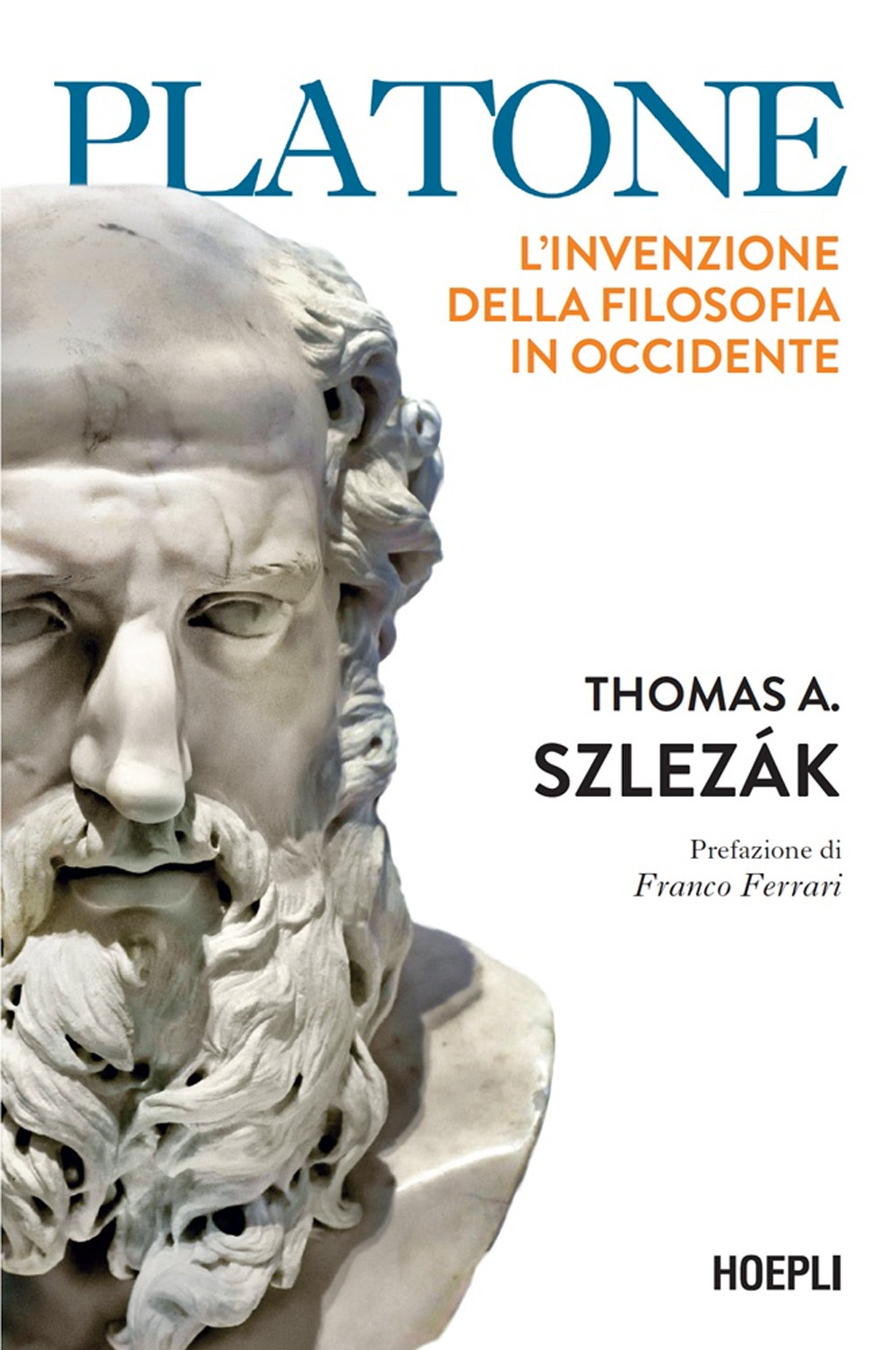
Thomas A. Szlezák
Platone
L’invenzione della filosofia in Occidente
Prefazione di Franco Fornari
Hoepli, 2025, pp. 604
€ 39.50
Il Platone di Szlezák è un capolavoro assoluto. Uno di quei libri che per completezza, livello argomentativo, esegesi delle fonti hanno pochi rivali. Tutto quello che c’è da sapere sul grande filosofo greco (nascita, formazione, opere, sfondo storico, interpretazioni, etica, ontologia, gnoseologia, politica, sviluppi successivi) è qui, nelle seicento pagine che rappresentano la riflessione di una vita. Insomma, un libro imperdibile per chiunque ami e studi il filosofo greco e la filosofia antica. Del resto, Alfred North Whitehead ha affermato che “la storia della filosofia è solo un grande commento a Platone”, e nell’opera di Szlezák si rende conto anche di questa centralità del filosofo nella storia del pensiero umano.
La peculiarità della sua lettura, dal punto di vista ermeneutico, sta tuttavia nella tesi (con la quale si può essere più o meno d’accordo) che il vero Platone, il Platone filosofo, non stia nei dialoghi ma in quel pensiero segreto, che culmina nell’idea del bene, rivelato solo a pochi intimi. I dialoghi sarebbero o una divulgazione di alcuni aspetti non decisivi e tutto sommato secondari del pensiero platonico o, addirittura, dei giochi letterari che rivelano un grande narratore, ma non nello specifico la sua vocazione filosofica. Che, appunto, sarebbe altrove.
Perché Platone abbia taciuto le verità fondamentali è dovuto essenzialmente a due fatti: la scarsa fiducia negli spiriti non eletti e non votati a un serio lavoro filosofico (che è soprattutto un lavoro su se stessi) e la scarsa fiducia nella scrittura che soprattutto nel Fedro, secondo Szlezák, sarebbe delegittimata senza appello.
È la tesi della scuola di Tubinga relativa al Platone esoterico sostenuta anche attraverso una circostanziata lettura della Lettera Settima in cui Platone sostiene che non ha scritto su certe cose, che mai ne scriverà e diffida altri dal farlo in suo nome. Perché? Perché “l’immagine scritta – scrive Szlezák – per sua natura comporta la perdita della spontaneità di ciò che è vivente, e il passaggio dalla dialettica vivente alla scrittura, che è vivente solo in apparenza e in verità incapace di reagire”.
Resta il fatto che Platone abbia scritto tantissimo, oltre trenta dialoghi e diverse lettere, che la sua scuola, l’Accademia, abbia prodotto non pochi scrittori e dialoghi spuri e che molti interpreti, prima e dopo Szlezak, non si riconoscano nelle posizioni della scuola di Tubinga ritenendo il rapporto tra oralità e scrittura molto più problematico e articolato di una semplice condanna. E resta il fatto che Platone affidi a Socrate, con il quale non sempre è d’accordo, le sue critiche alla scrittura.
E se Socrate fosse solo una delle tante maschere che Platone indossa per depistare il lettore su come la pensi veramente? Anche la posizione non esoterica dunque ha le sue ragioni, di vario tipo e molto profonde. Magari ne parleremo una prossima volta a partire da qualche libro che le presenta e le rappresenta.