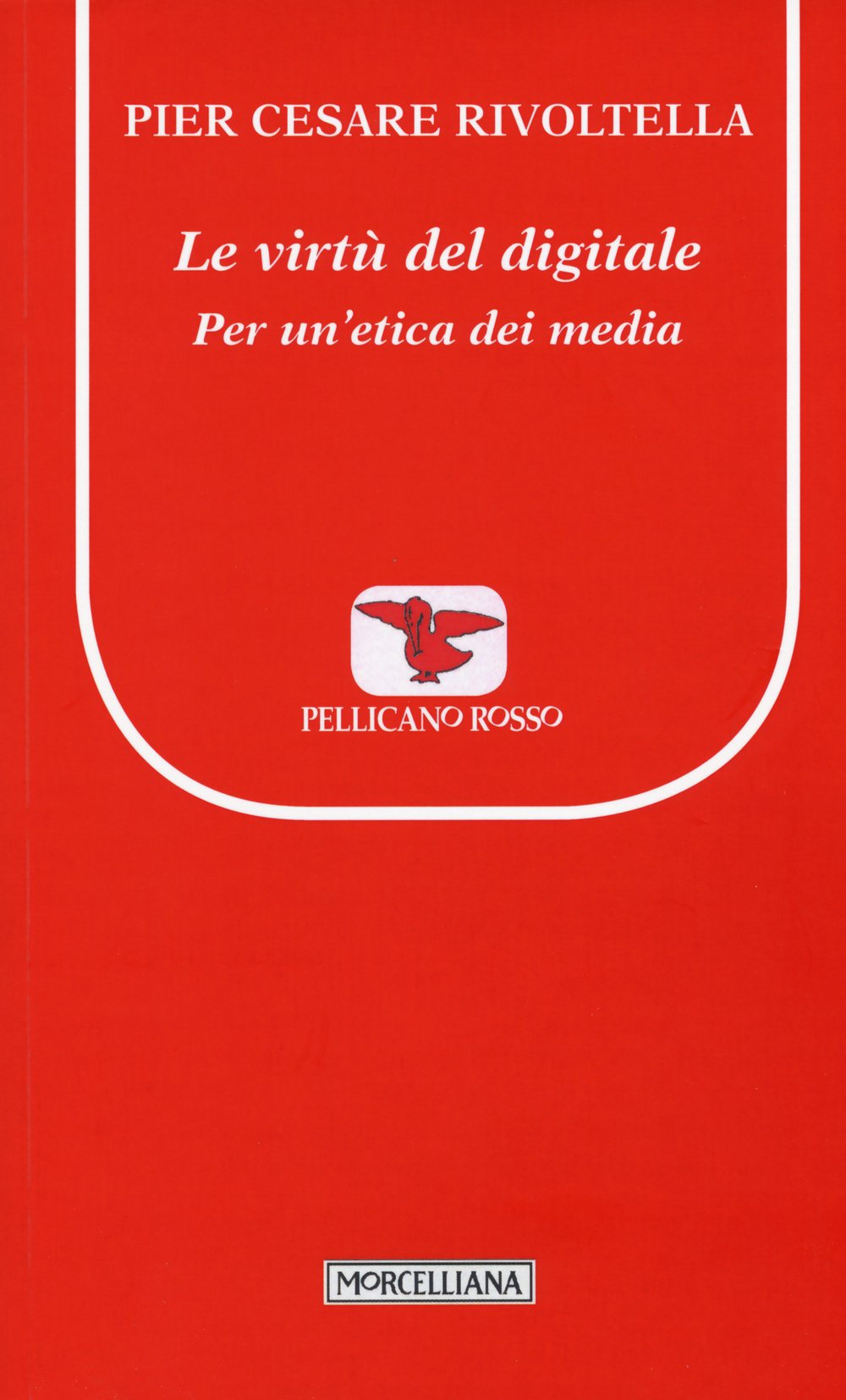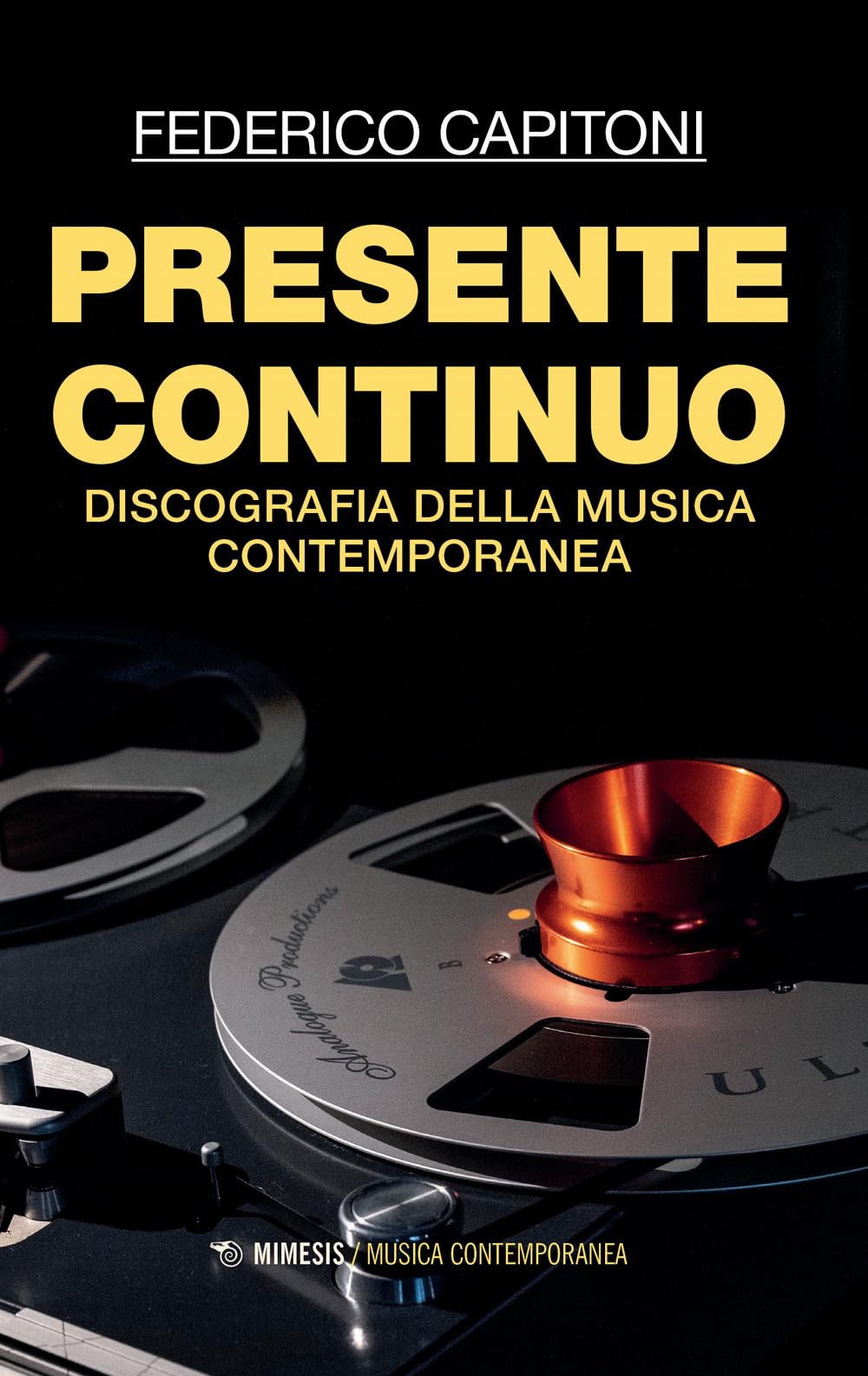Ma Amleto è o non è?
Dice il saggio
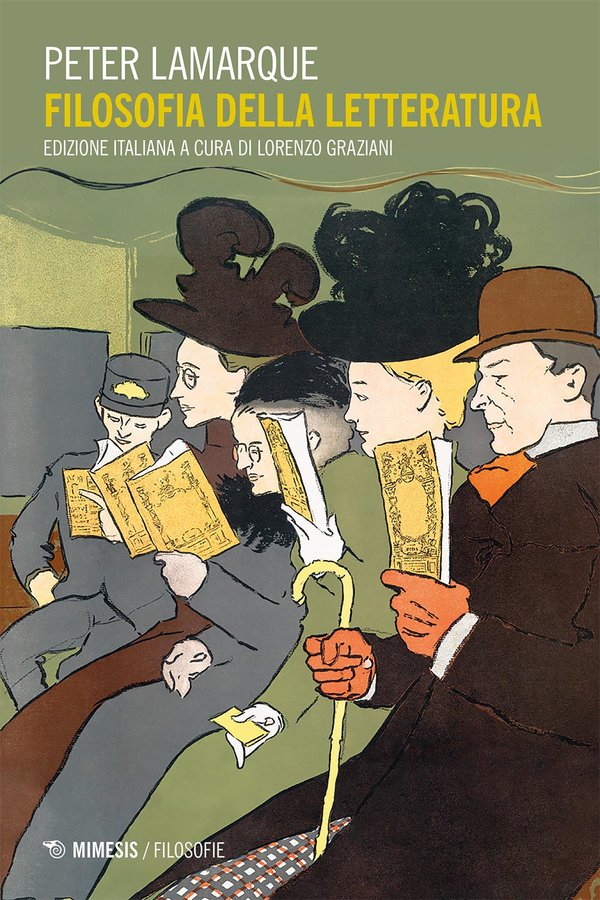
Peter Lamarque
Filosofia della letteratura
Mimesis, 2024, pp. 486
€ 35
Peter Lamarque, professore di Filosofia presso l’Università di York, è un esponente dell’estetica analitica contemporanea. Il suo libro “Filosofia della letteratura”, finalmente pubblicato in Italia da Mimesis, risale al 2009 e fa parte della serie sulla Fondazione della Filosofia dell’Arte. L’opera si presenta come un’introduzione ampia, ma accessibile, a una serie di questioni fondamentali della filosofia della letteratura, esplorando le profonde relazioni tra arte, filosofia e letteratura, abbracciando le complessità dell’estetica filosofica.
Lamarque invita i lettori a riflettere sul significato profondo dell’esperienza letteraria, sfidandoli a considerare la letteratura non come un semplice mezzo di trasmissione di idee, ma come un’arte che esplora l’umano in modo unico e irriducibile.
Lamarque si rivolge a un pubblico eterogeneo, composto non solo da filosofi, ma anche da critici, autori e lettori, per comunicare interrogativi filosofici fondamentali sulla letteratura come forma d’arte. L’autore adotta un approccio analitico ma include anche prospettive continentali, citando Barthes e Foucault tra gli altri, dimostrando una sensibilità per approcci filosofici diversi.
Un elemento centrale della filosofia di Lamarque è l’enfasi sull’autonomia della letteratura. Quest’ultima non deve essere subordinata a scopi morali, religiosi, politici o cognitivi. Lamarque sostiene che la letteratura mira all’universale e si distingue per l’indivisibilità tra forma e contenuto. La “forma” non è un mero veicolo per il significato, ma parte integrante dell’esperienza letteraria.
Il libro è organizzato in sette capitoli, ciascuno incentrato su un aspetto cruciale: arte, letteratura, autore, pratica, finzione, verità e valore. Lamarque sostiene che le opere letterarie non sono entità isolate ma artefatti istituzionali, dipendenti dal contesto storico e culturale e dalla partecipazione critica. La letteratura, dunque, non è semplicemente un insieme di parole, ma un sistema complesso che invita reazioni e valutazioni.
Le opere letterarie, secondo Lamarque, si caratterizzano per il tipo di apprezzamento che stimolano: un’esperienza che integra forma, contenuto e temi di interesse universale. I lettori, definiti “partecipanti competenti”, si aspettano coerenza, complessità e un’interazione profonda tra struttura e significato. L’arte letteraria offre un piacere estetico specifico, che Lamarque definisce come centrale per l’esperienza letteraria. La questione di cosa renda un testo “letteratura” è esplorata attraverso teorie essenzialiste e anti-essenzialiste.
Lamarque affronta anche l’ontologia delle opere letterarie, interrogandosi se queste siano oggetti fisici, entità mentali o tipi astratti. La sua analisi coinvolge il dibattito tra testualismo e contestualismo, esplorando le implicazioni delle intenzioni degli autori e delle convenzioni sociali nella definizione delle opere. Particolarmente significativo è il confronto tra un approccio intenzionalista, che valorizza le intenzioni dell’autore, e il suo opposto, che le considera irrilevanti per il significato di un’opera. Lamarque sostiene che il significato letterario emerge da un intreccio complesso di testo, autore e contesto culturale, respingendo visioni troppo semplicistiche.
L’interpretazione letteraria è un altro tema centrale del libro. Lamarque distingue tra testo e opera, sottolineando come l’interpretazione sia legata alla contestualizzazione e alle convenzioni istituzionali. Esplora l’idea che le opere letterarie siano costruite attraverso atti di lettura e interpretazione. Egli accetta che l’autore possa aver previsto più interpretazioni, evidenziando la flessibilità della lettura letteraria.
Il capitolo dedicato alla finzione esamina la metafisica dei personaggi e delle opere fittizie. Lamarque si chiede in quale senso entità come Amleto esistano e come possiamo attribuire proprietà a personaggi fittizi. Egli sottolinea che, sebbene la narrativa fittizia non fornisca dati reali, essa può contenere verità e stimolare emozioni autentiche. Questo porta alla discussione sulla verità letteraria: Lamarque esplora la possibilità che la letteratura offra una forma di verità distinta da quella scientifica o filosofica. Respinge l’idea che la validità di un’opera dipenda dalla verità delle sue proposizioni. La conoscenza derivata dalla letteratura è un effetto collaterale piuttosto che un obiettivo. L’interesse per temi universali e l’esplorazione di prospettive morali, tuttavia, restano aspetti fondamentali dell’apprezzamento letterario.
L’autore sottolinea che, pur essendo possibile apprendere dalla letteratura, il valore cognitivo non costituisce il nucleo centrale del valore letterario. Ciò che rende la letteratura unica è la sua capacità di presentare temi umanamente rilevanti attraverso un linguaggio immaginativo e strutture narrative che stimolano riflessione e coinvolgimento emotivo. Nonostante il suo scetticismo verso il valore cognitivo della letteratura, egli riconosce che alcune opere possono arricchire la comprensione umana attraverso componenti simili alla verità.
L’ultimo capitolo affronta il tema del valore letterario. Lamarque distingue tra valore intrinseco e strumentale, sostenendo che il valore della letteratura risiede nella sua capacità di suscitare risposte estetiche e intellettuali. Il concetto di “opacità narrativa” descrive come la letteratura non sia un mezzo trasparente per accedere a mondi immaginari, ma un artefatto, un vetro opaco, che invita i lettori a riflettere sulle modalità della sua presentazione e cattura l’attenzione per il modo in cui gli eventi, i personaggi e le idee sono proposti.