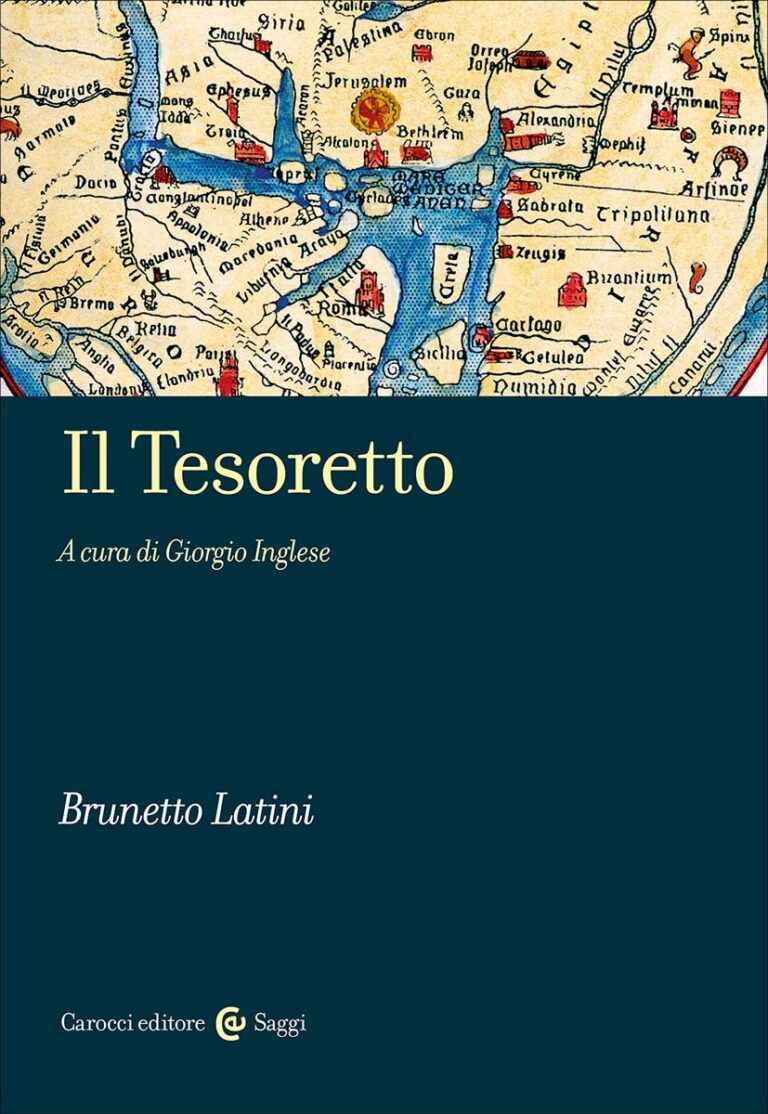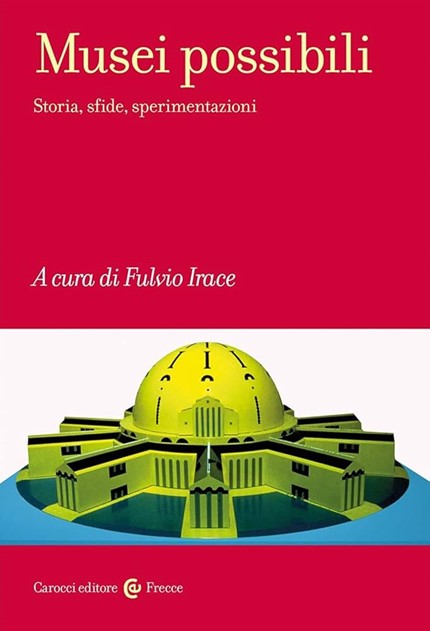Umanamente impossibile: la Vita
Critica letteraria

Peter Brooks
La lezione di Balzac
Carocci, 2025, pp. 123
€ 13
Tradurre in sintesi l’opera di Honoré De Balzac è quanto mai arduo se si intende dar conto dei suoi 137 scritti compresi nel ciclo de “La Comédie humaine”: 95 romanzi, novelle, saggi realistici, fantastici o filosofici, oltre a racconti e a 25 studi analitici, che, a vario titolo, hanno influenzato l’attività dei prosatori d’ogni nazionalità. Chiunque abbia pensato ad un romanzo si è dovuto inevitabilmente confrontare con lo stile ed i contenuti del tardo romantico di Tours, con il realismo della sua denuncia sociale, con la sua volontà di rappresentare una società complessa e amara in modo veridico, secondo quanto già osservato da Friedrich Engels che ebbe a dichiarare nella sua lettera a Margaret Harkness “di aver imparato più dal reazionario Balzac che da tutti gli economisti”. Un’analisi inconfutabile quella del filosofo tedesco, per certi versi similare a quella che compie in questo lucido saggio il critico letterario Peter Brooks, professore di Letterature Comparate all’Università di Yale, il quale è conseguenza delle riflessioni già pubblicate in “Sedotti dalle storie. Usi e abusi della narrazione” e “Vite di Balzac” (Carocci editore 2022 e 2023).
Chiamare “Lezione” quella dell’autore della Comédie di per sé costituisce un’aperta dichiarazione circa “la dinamicità di un mondo in fermento, sul punto di far ingresso nella modernità” e la chiarezza, anche spietata, dei ritratti di personaggi inquieti, talora balordi o insipienti, ingenui o crudeli, bizzarri avidi o spenti in uno stato vegetativo di fallimenti familiari, disamorati o appassionati, deboli o tormentati, inconsolabili quanto biechi e moralmente squilibrati, bizzarri e affannati, insomma ogni varianti possibile “per comprendere sia il mondo di allora sia, e forse soprattutto, quello di oggi”, così come nel corrotto provincialismo di “Eugénie Grandet”, nella tragica solitudine di “Le Père Goriot” o nel disincantato fallimento esistenziale di “Illusions perdues”. Grafomane ossessionato dalla pulsione iperdescrittiva o attento e magmatico testimone dell’incessante fare e disfare dell’uomo moderno? La soluzione del caso è nel “raggiungere una sorta di visione del mondo come Volontà e Rappresentazione, per riprendere l’espressione di Schopenhauer, che funziona solo quando noi lettori facciamo in modo di scivolare dentro una modalità visionaria”: lasciarsi andare e osservare la soluzione, come sempre quando si vuole entrare nell’anima di chi rappresenta e di chi è rappresentato.