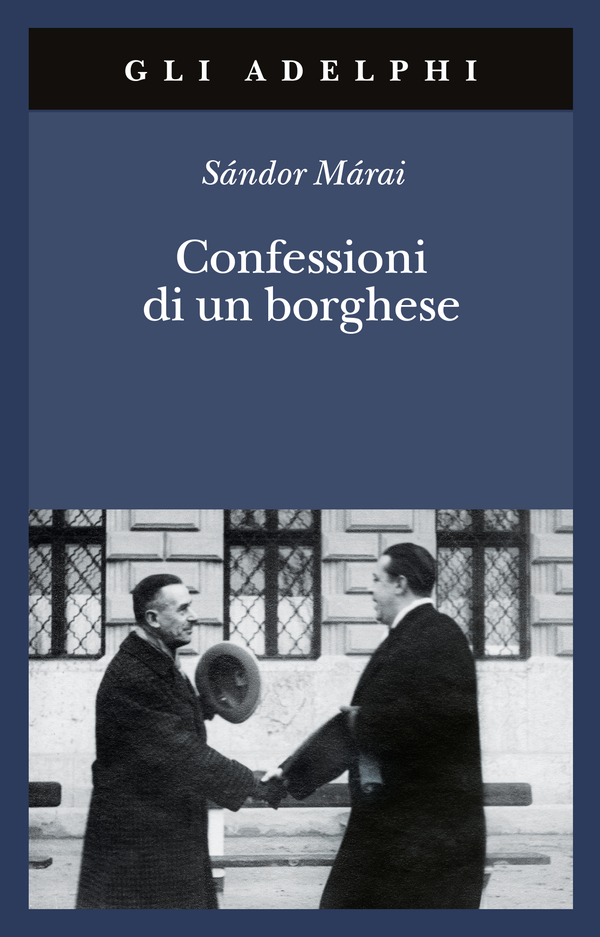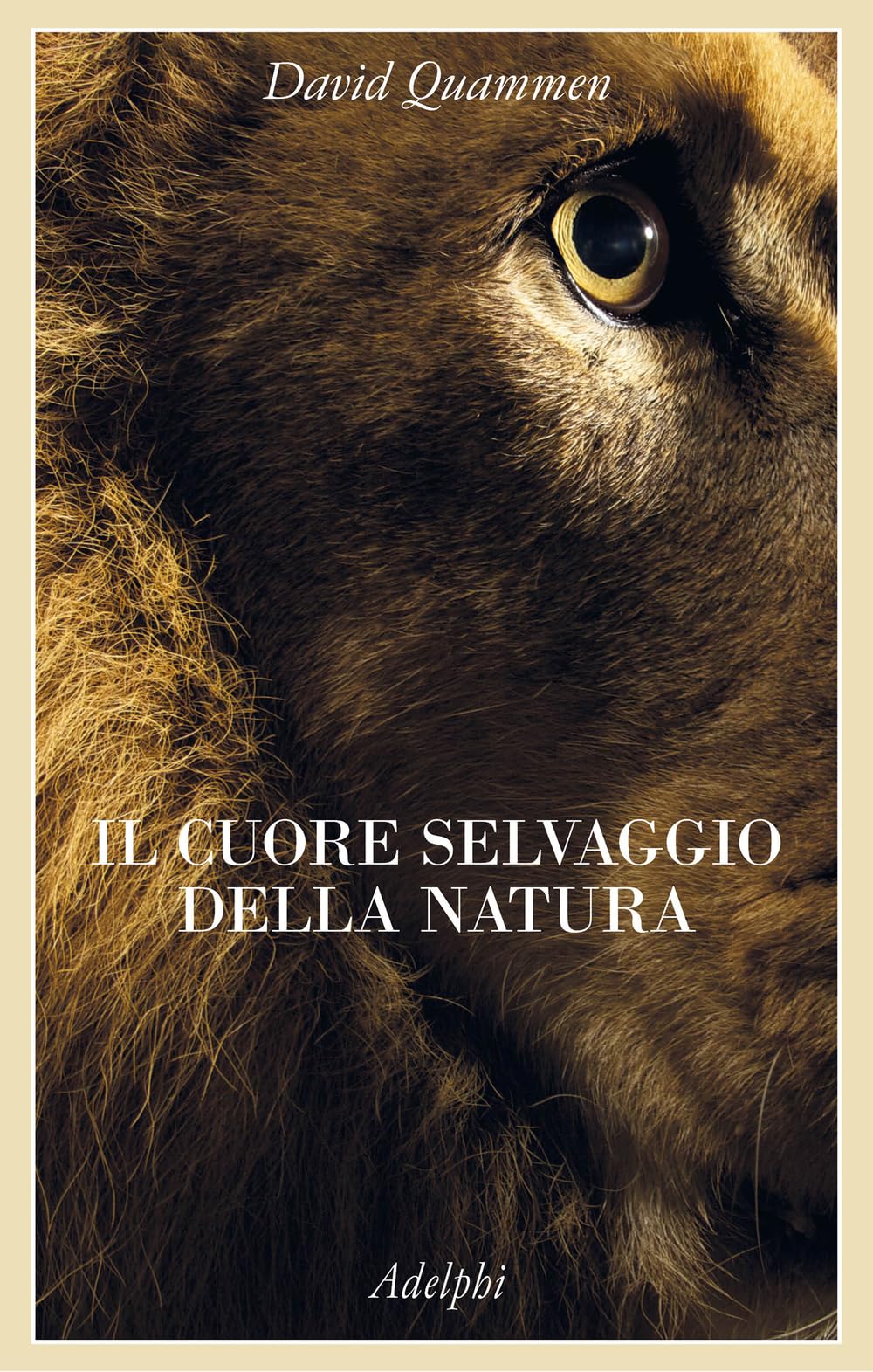Resistere pensando
Dice il saggio

Matteo Negro (a cura di)
Attualità di Hannah Arendt
Studium, 2025, pp. 176
€ 18
Il libro Attualità di Hannah Arendt, curato da Matteo Negro e pubblicato da Edizioni Studium nel 2025, si presenta come un’opera collettiva che esplora la rilevanza del pensiero arendtiano per affrontare le sfide del presente. Attraverso una serie di saggi firmati da studiosi di primo piano, il volume analizza i temi fondamentali della filosofia di Hannah Arendt, mettendo in evidenza la sua capacità di dialogare con il passato e con i problemi contemporanei.
Hannah Arendt è riconosciuta come una delle pensatrici più influenti del XX secolo, capace di affrontare con lucidità questioni complesse come il totalitarismo, la crisi della politica moderna e la responsabilità individuale. Il volume sottolinea come il suo pensiero continui a essere una guida imprescindibile per comprendere fenomeni attuali quali la polarizzazione politica, la disinformazione e le crisi democratiche.
Il libro raccoglie una serie di saggi che esplorano l’eredità filosofica e politica di Hannah Arendt, concentrandosi in particolare sulla sua opera “The Human Condition” (1958), pubblicato in italiano con il titolo di “Vita activa”. Il volume è una rielaborazione di una precedente raccolta pubblicata nel 2018 sulla rivista “Studium”, per il sessantesimo anniversario del testo arendtiano, arricchita da nuovi contributi e revisioni. I saggi analizzano la modernità, la crisi del politico, la condizione umana e le contraddizioni del mondo contemporaneo attraverso la lente del pensiero arendtiano, mettendo in luce la sua attualità e la sua critica radicale alle derive disumanizzanti della società moderna.
Nel saggio “Ripensare la condizione umana” Laura Boella si sofferma sulle grandi questioni teoretiche sollevate da “Vita Activa” e sull’influenza di Jan Patocka. Sottolinea come l’esperienza della Shoah e dell’esilio abbia spinto Arendt a ripensare la filosofia in chiave politica, difendendo la dimensione plurale dell’umanità. Boella evidenzia che “Vita Activa” reinterpreta il rapporto tra individuo e mondo di fronte alla distruzione della condizione politica, invitando a una responsabilità comune attraverso il pensiero e l’azione.
Nel contributo “L’agire umano come poter essere altrimenti e la sua ricorrente sostituzione col fare” Fabio Ciaramelli esplora la distinzione arendtiana tra “agire” (prassi) e “fare” (poiesis). Il concetto arendtiano di azione come “poter-essere-altrimenti” si contrappone alla tradizione occidentale che privilegia regole universali. L’azione umana è vista come imprevedibile e relazionale, capace di inaugurare nuovi inizi. L’agire, libero e imprevedibile, si contrappone al fare, subordinato a modelli predeterminati. Ciaramelli sottolinea che l’azione umana, nella sua plasticità, apre a un futuro non predeterminato, esigendo uno spazio simbolico del significato dove esercitare la libertà e resistere al totalitarismo.
In “La libertà in Vita Activa” Fabio Grasso analizza il nesso tra azione e potenzialità, evidenziando come l’azione ecceda il soggetto, configurandosi come “potenza allo stato puro”. Tuttavia, osserva che questa indeterminatezza rischia di rendere la libertà impolitica, indebolendone il ruolo fondativo per le forme di convivenza. La libertà emerge come capacità di agire insieme agli altri in uno spazio pubblico condiviso. L’amore per il mondo funziona da antidoto alla riduzione dell’uomo ad animal laborans, criticando lo sviluppo economico che distrugge la dimensione politica e comunitaria. Grasso critica anche la discontinuità arendtiana tra lavoro e opera, presente invece in Marx in modo più dialettico.
Nel saggio “Dal consumo alla cura del mondo: una fenomenologia della cultura” Letizia Konderak riflette sul concetto di “mondo” in Arendt e sui rischi della sua distruzione capitalistica. Il mondo, fulcro dell’identità umana e condizione per l’agire politico, è minacciato dalla logica del consumo. Konderak propone una fenomenologia della cultura basata sulla cura amorevole del mondo e sul rispetto della temporalità delle attività umane.
In “Natalità come appello di giustizia” Ferdinando Menga esplora la dimensione intergenerazionale della comunità politica in Arendt. La natalità, intesa come capacità di iniziare qualcosa di nuovo, è centrale per ripensare la responsabilità verso le generazioni future. Menga sottolinea che la comunità arendtiana, ispirata all’Atene periclea, trascende i limiti storici, fondandosi su un soggetto politico radicalmente esposto all’alterità e alla futurità. Analizzando i concetti di natalità e pluralità – intesi come capacità umana di iniziare qualcosa di nuovo – scaturisce un modello etico-politico orientato alla responsabilità verso le generazioni future, una sorta di giustizia intergenerazionale, sottolineando l’importanza di accogliere l’imprevedibilità del futuro come antidoto alle derive deterministiche della modernità. Arendt denuncia l’eccessiva fiducia nella scienza e nella tecnica, proponendo un ritorno alla politica come esperienza autentica dell’umano.
Nel saggio “La vita è il bene supremo?” Paola Ricci Sindoni affronta il paradosso della modernità: la glorificazione della vita biologica a scapito del mondo comune. Arendt critica la riduzione dell’uomo a “animal laborans”, privato della dimensione politica. Ricci Sindoni osserva che la vita diventa bene supremo solo quando la libertà si traduce in impegno per la res publica, restituendo senso all’esistenza collettiva.
In “Hannah Arendt e l’individualismo metodologico” Roberto Vignera critica l’approccio arendtiano alle scienze sociali, accusandola di ancorarsi a un individualismo etico-politico che trascura le macro-strutture sociali. Nonostante Arendt riconosca i vincoli normativi e simbolici dell’agire, Vignera sostiene che la sua prospettiva micro-analitica risulti insufficiente per comprendere appieno i processi storici e politici.
Il libro curato da Negro evidenzia l’attualità del pensiero di Arendt, capace di interrogare le contraddizioni della modernità, dalla crisi del linguaggio alla perdita del mondo comune. I saggi, pur nelle loro differenze, mostrano come la sua filosofia offra strumenti critici per affrontare le sfide del presente, dalla tecnocrazia alla frammentazione sociale, ribadendo l’urgenza di ripensare la politica come spazio di libertà, pluralità e responsabilità condivisa. Il volume dimostra chiaramente quanto il pensiero di Arendt sia indispensabile per affrontare le trasformazioni radicali del presente. Le sue riflessioni sulla libertà, sulla pluralità e sull’agire politico offrono strumenti critici per comprendere fenomeni come la crisi ecologica, le disuguaglianze globali e la perdita dello spazio pubblico nelle democrazie moderne.