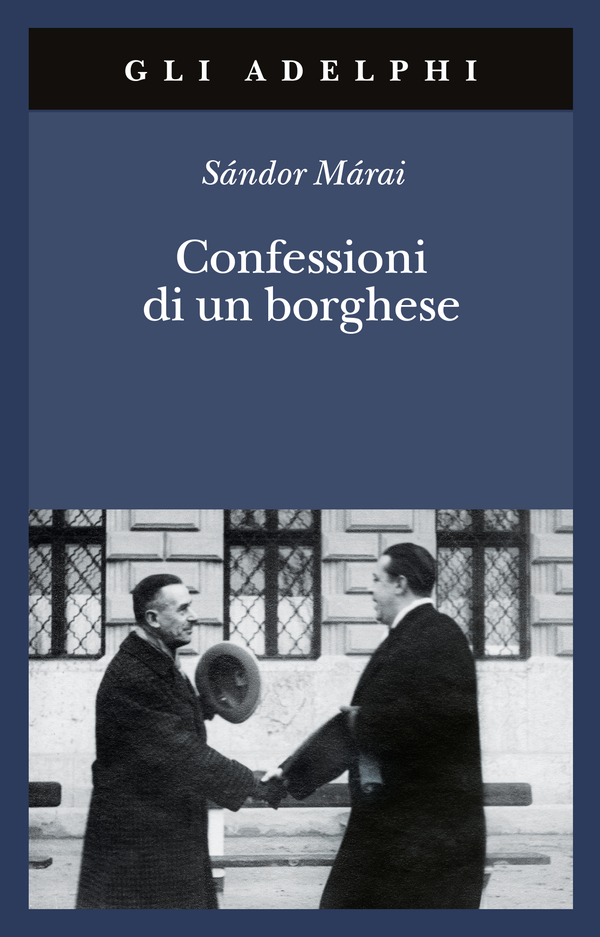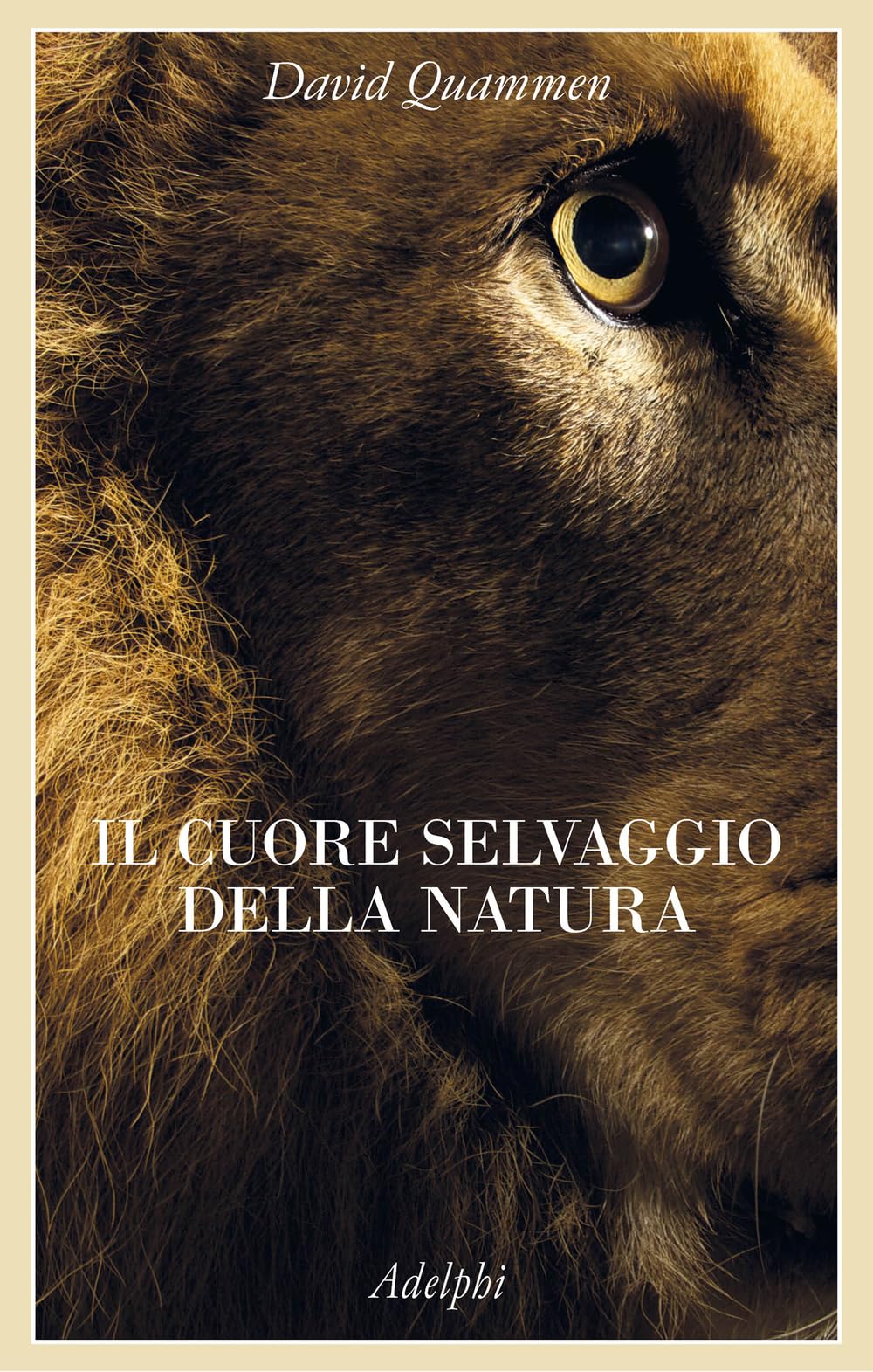Indagine su Sositeo
Classici

Marco Zanelli
I drammi di Sositeo
Testimonianze e frammenti
Vita e Pensiero, 2025, pp. 136
€ 15
Alessandria di Egitto, anno circa 250 A.C.
Verso la fine del suo regno, durato 40 anni, Tolomeo Secondo “Filadelfo”, grande appassionato di bellezza e cultura, riesce a fare, della metropoli sul Delta del Nilo, una seconda Atene, con una raffica di iniziative culturali e scientifiche quasi impressionanti.
Vengono chiamati a corte Letterati, Scienziati, Filosofi, Cartografi ecc.
Viene inaugurata la leggendaria Biblioteca e, cosa nota a pochi, vengono chiamati nella nuova capitale alessadrino/tolemaica, 70 “saggi” di Israele, per curare la Traduzione dall’Ebraico, in Greco Classico, del “Grande Libro sull’Unico Dio”, come dirà poi Sosigene a Cleopatra, nell’ anno 48 A.C. all’arrivo di Cesare e, ahimè, all’incendio di cui parlerà Plutarco.
Tra le glorie del momento, il Re Faraone di origine macedone, mette insieme un gruppo di sette letterati che formeranno, per alcuni decenni, la cosiddetta “Pleiade”. Uno staff di 7 dei migliori scrittori, che fanno parte del progetto di rivitalizzare il teatro Greco, mescolando Commedia (Aristofane) a Tragedia (Sofocle e, in misura maggiore Euripide).
Mi viene in mente il “Cenacolo” di Lorenzo il Magnifico, 17 secoli dopo, a Firenze, dove peraltro, il recupero del Mondo Greco Pagano, costituiva una delle colonne, sopra a tutto relativamente a letteratura e filosofia.
Ma così come a Tolomeo Secondo, la fortuna arride in mecenatismo, e sul fronte sentimentale, con una esistenza ricca di amori e passioni, non si può dire lo stesso sul piano politico militare, dagli esiti violentemente contrastanti.
In ogni modo, oramai la scelta è fatta, ed è irreversibile: i nuovi faraoni della 33ma Dinastia (da sola si porta dietro 3 secoli!), almeno per quanto riguarda la sfera pubblica e del Culto Pubblico, saranno a tutti gli effetti i continuatori della tradizione, che conta già la bellezza di 24 Secoli.
Purtroppo davanti a cifre smisurate come queste, la parentesi della “Pleiade” si riduce a una manciata di decenni. Scema progressivamente nel regno di Tolomeo Terzo. All’arrivo di Cesare in Egitto, sono rimasti pochi frammenti di tanti lavori. Che si assottiglieranno al minimo diciamo nella prima metà del Secondo Secolo D.C.
Il libro di Marco Zanelli si apprezza certo per la ricchezza di indagine e citazioni, opinioni e ipotesi di lavoro che abbracciano dalla Antichità fino alle più recenti ricerche.
Personalmente, ritengo che il novanta e passa per cento della trattazione, ruota intorno al più grande dei pochissimi frammenti rimasti, probabilmente il più affidabile e verisimile.
Per quanto sopravvive oltre al brano che riporto, ovviamente tradotto, si ha la sensazione che i dubbi soffochino non dico le certezze, ma anche le probabilità.
Sono convinto che quanto sopravvissuto, dia un carattere definito dell’autore, e forse anche del “revival” che il sovrano aveva progettato: quindi, la parola al testo: parla Litierse, raccontando in sintesi di Celene, la patria di Mida:
“Costui ha come patria Celene, l’antica città
del vecchio Mida, che con orecchie d’asino
regnava e con mente di uomo molto sciocco.
Questi è il suo figlio illegittimo e spurio,
di quale madre lo sa colei che lo partorì,
mangia pane, tre intere bestie da soma,
tre volte in un giorno breve; beve,
chiamandola una metreta, una giara da dieci anfore.
Lavora però velocemente, proporzionalmente(?) al cibo
mietendo il solco: e in un solo giorno
[…]e raccoglie insieme fino all’ultimo.
E quando giunga o sia di passaggio un forestiero,
suole dargli da mangiare, saziarlo per bene
e offrirgli da bere, più di quanto si faccia in estate:
teme infatti di negare qualcosa a quanti presto moriranno.
[portandolo poi nei campi?] di messi, irrigati
dalle correnti del Meandro con copioso liquido
miete il grano ad altezza d’uomo
con la falce affilata: e l’ospite, una volta decapitato
insieme al fascio di spighe, lo porta via privo di testa
ridendo d’aver dato la colazione a un mietitore senza cervello.” (vv. 1-21)
Si dice che Sositeo presentasse un originale miscela di crudeltà da tragedia, commista a toni da commedia. Certo, non fa assolutamente difetto la originalità creativa di questo “topos”.
Riflessione: questo compiacimento misto di sadismo, ironia e crudeltà, non dubito che avesse una presa, anche immediata, sul pubblico. Ma, a parte la complessa questione di quali altri modelli, precedenti rielaborati, e quanto rielaborati, la mia percezione è che dopo un po’ questa particolare ottica compositiva, fosse ripetitiva, e procurasse, se non indignazione, diciamo saturazione.
Forse una branca, un aspetto dell’Ellenismo, meno durevole, meno autorevole, più istrionicamente compiaciuto? Ovviamente restando al letterato trattato nello specifico. Una “Pleiade” splendente nei fatti … di breve vita.