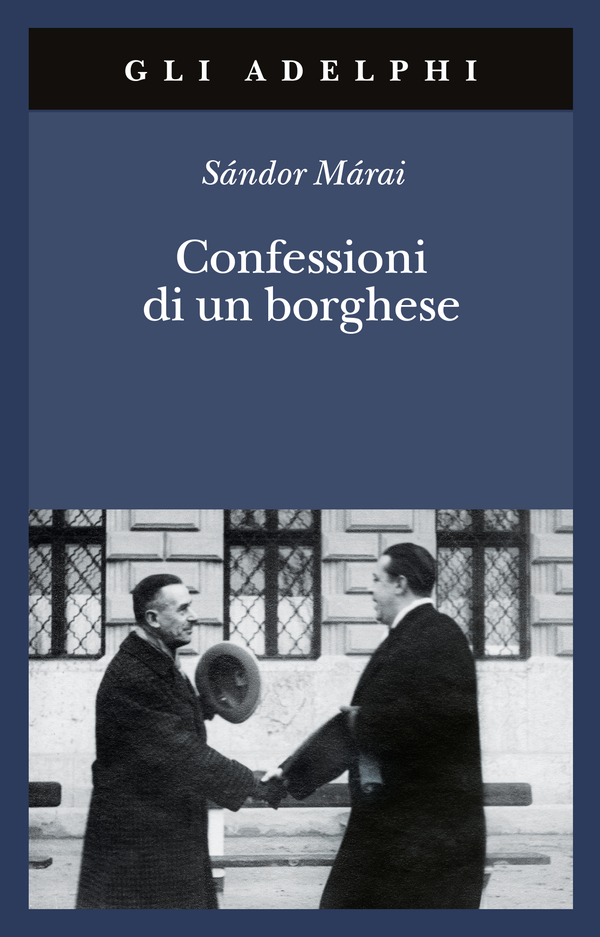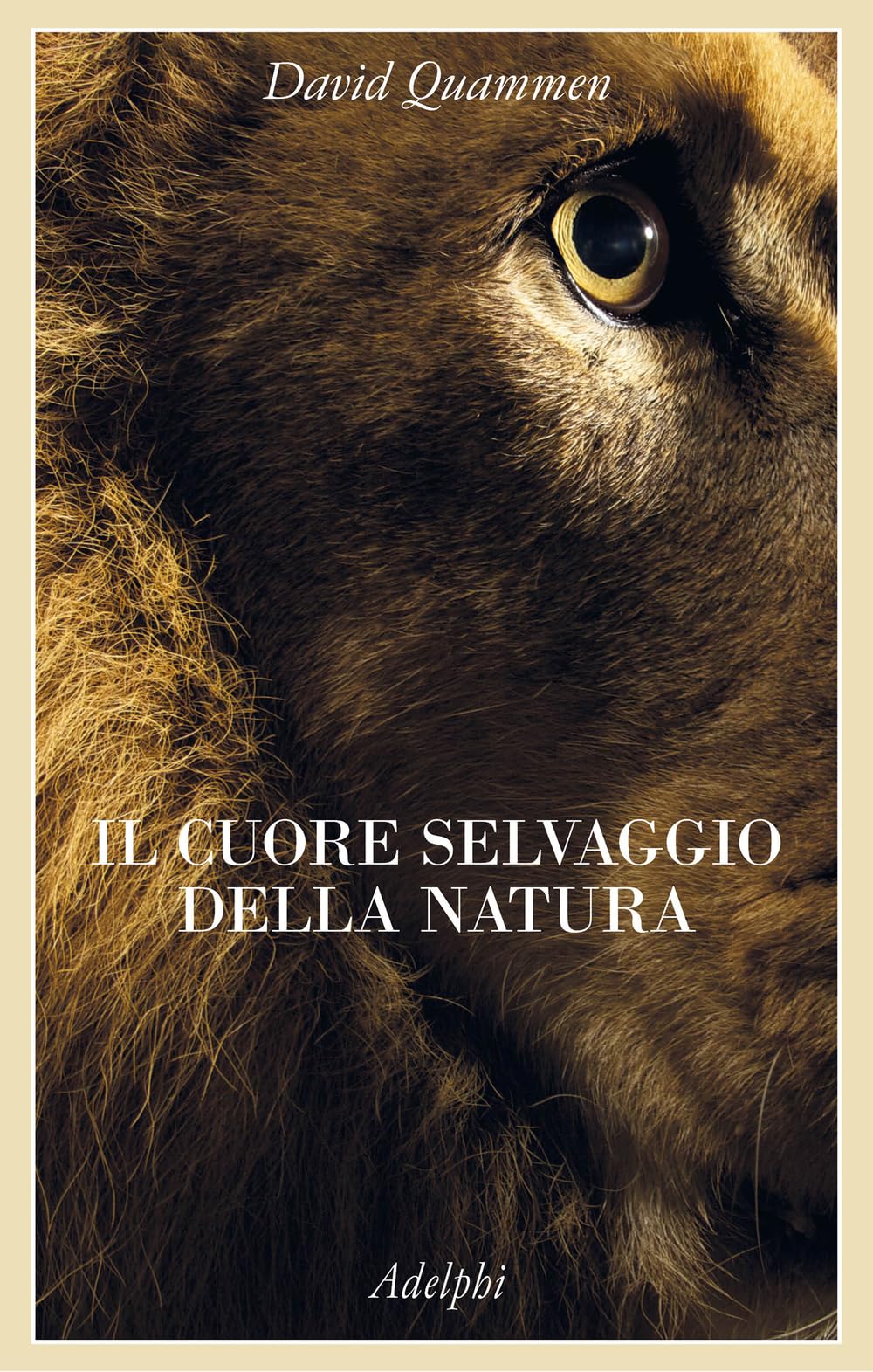Per un senso ulteriore
Il libro del mese
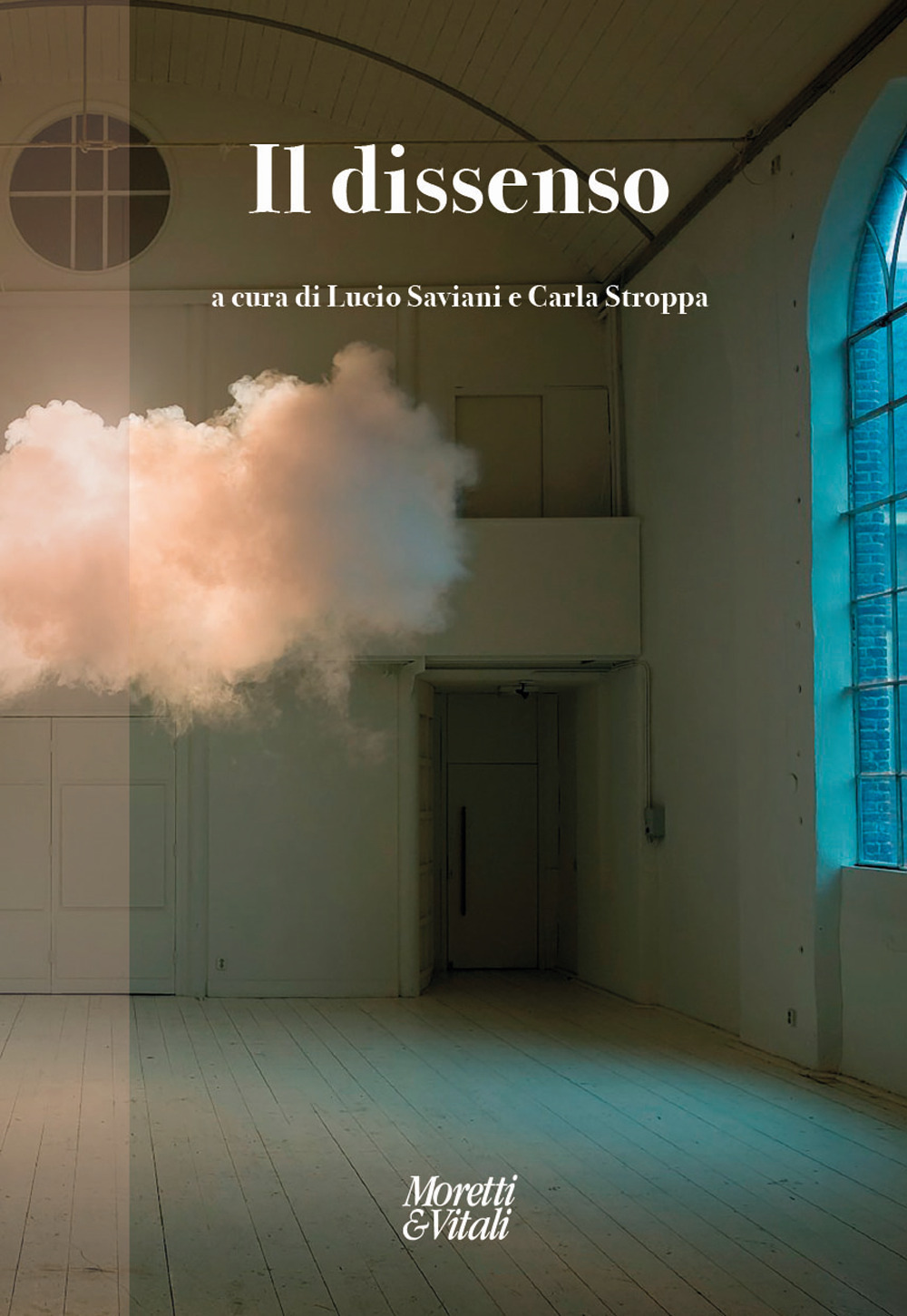
Lucio Saviani e Carla Stroppa (a cura di)
Il dissenso
Moretti&Vitali, 2025, pp. 161
€ 14
Non sono solo le diverse forme del dissenso che questo saggio va ad esplorare (dal dissenso in psicanalisi a quello politico, dal dissenso dell’esperienza mistica a quello dell’epistemologia) ma le condizioni stesse del dissenso, la possibilità che esso si dia e continui a darsi in un’epoca in cui sembra che dissentire sia diventata una moda e l’atto stesso di farlo si risolve in un compiacimento del significante a danno del significato.
Anzi, ancor prima dell’atto, è la potenza del dissenso che questo lavoro vuole salvaguardare come illustra il saggio iniziale di Lucio Saviani, filosofo ed esponente dell’ermeneutica che, con la psicanalista junghiana Carla Stroppa, ha curato il volume.
Le difficoltà che il dissenso in sé incontra “sta forse nel fatto che oggi tutti possono parlare perché non hanno niente da dire che sia davvero intollerabile”.
Ecco la provocazione lanciata da Saviani al pensiero unico, ai professionisti del dissenso, alla sua stanca ritualità, alla pratica apparentemente anarchica ma ampiamente prevedibile e normata di parlare contro questo o contro quello.
C’è ancora dissenso nel vedere ovunque occasioni per dissentire, e sennò crearsele artatamente? E c’è dissenso nell’immaginare nemici detronizzati da tempo o inesistenti? E creare un uomo di paglia o un pericolo di paglia da attaccare per confermarsi nel ruolo di dissenziente, anche quando non c’è nulla da contestare o l’oggetto della contestazione sta altrove?
Quanto più ampio e sfumato è l’obiettivo polemico tanto più generica diventa la pratica del polemos, del conflitto, dell’antagonismo.
Nel linguaggio comune si dice di una persona logorroica “non mi piace perché parla troppo” intendendo che il suo parlare sia gratuito, inconcludente, vuoto, un parlare per parlare, un flatus voci che non ascolta, non negozia, non costruisce, che stordisce soltanto.
Se è così vale anche il corrispettivo “non mi piace perché dissente troppo”, dissente a tal punto da distrarsi forse proprio in quelle situazioni in cui servirebbe davvero dissentire, dissente tanto per farlo, ma non in funzione di un accordo, di una sintesi superiore, di un senso ulteriore, di un’alternativa da indicare e da praticare al già stato.
Come l’abuso di parole svuota l’atto di parlare, appiattito sulla langue, sul già detto, sulla ripetizione, così l’abuso di dissenso indebolisce l’atto del dissentire al quale, sottratta la potenza eversiva, resta solo – come dicevamo – lo sterile rituale, il significante compiaciuto, l’arma spuntata, il gesto teatrale e parodistico.
Quindi, bisognerebbe paradossalmente dissentire dal dissenso. Il che non significa retrocedere verso la sua negazione ma mettersi nella condizione di anticipare, a partire da uno stato di dubbio e di incertezza, un dissenso futuro. Salvare in sostanza il dissenso da sé come quando si prova a salvare la parola con il silenzio.
Husserlianamente mettere il dissenso tra parentesi o, conclude Saviani, “prevedere un periodo di maggese” per il dissenso per “consentire al nuovo di essere”.
Ma questo non è il compito stesso della filosofia che ritorna perennemente su di sé per sperimentarsi, che si prende le sue pause riflessive per rilanciarsi, che si autoesamina prima ancora di esaminare il mondo?
E’ un libro di cui si aveva bisogno, questo, in grado di tracciare una via diversa sia dal dissenso “spettacolarizzato, talora caricaturale in nome di un mai meglio specificato pensiero ribelle ed esercitato in eventi per lo più estivi” sia dal dissenso pensato “come finto contraltare di una stabile autoreferenzialità accademica”. Sia – aggiungiamo – dal dissenso, spesso artificiale, del web.