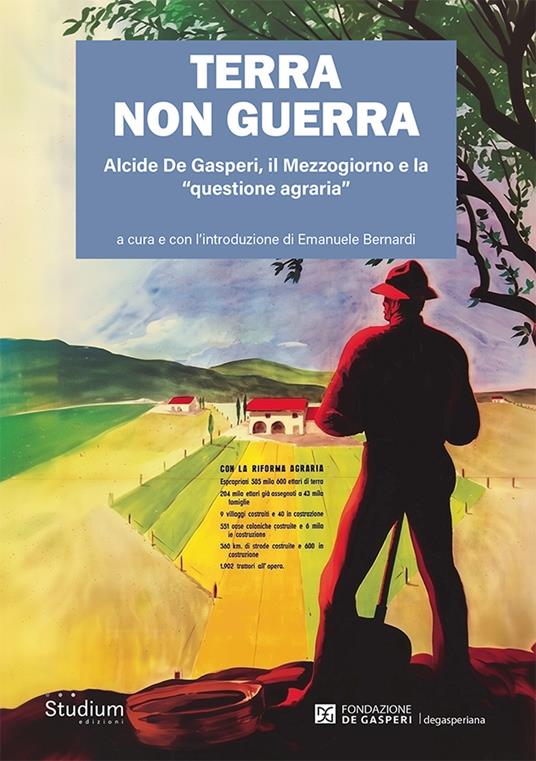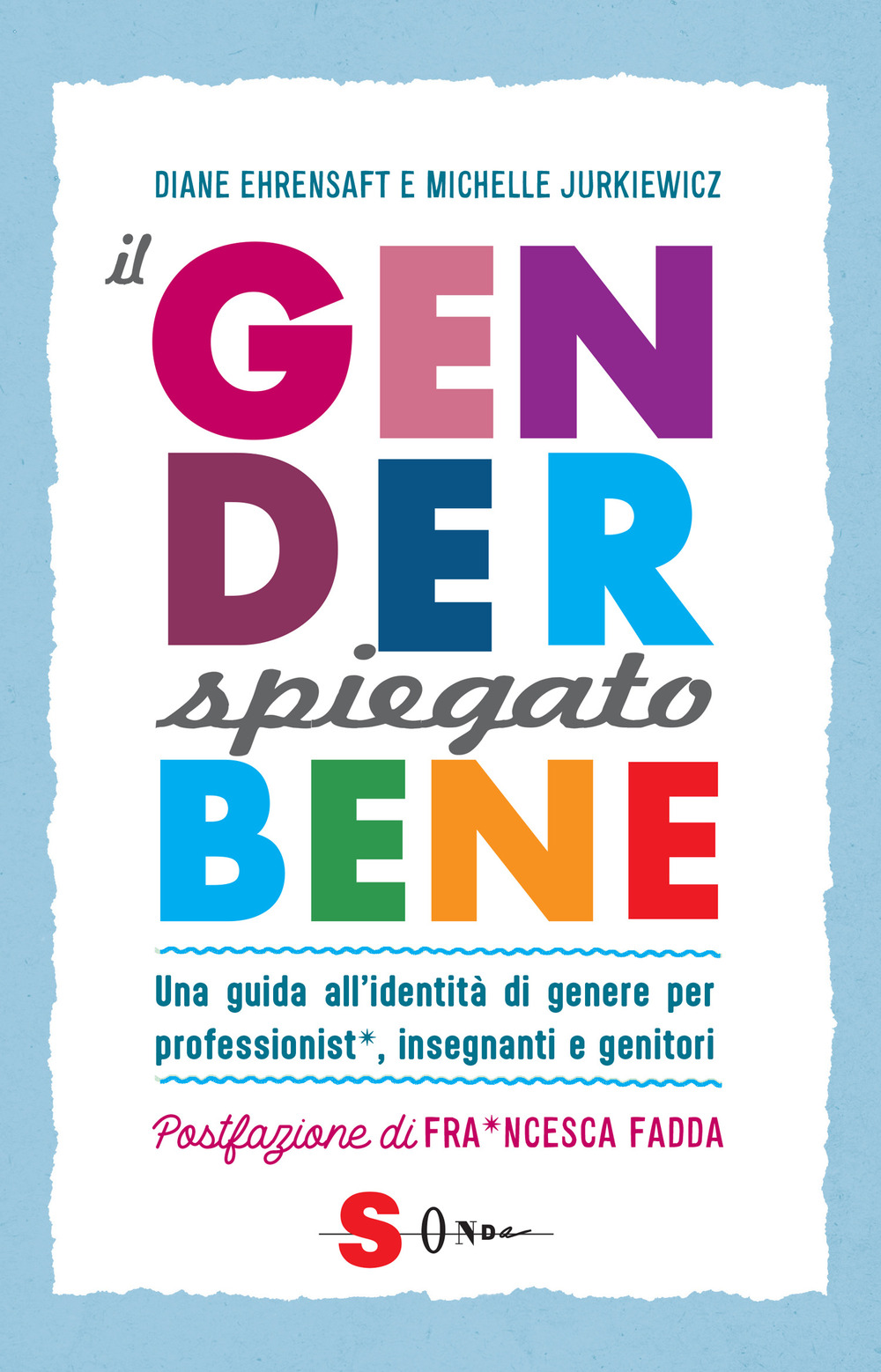Dentro (e dietro) l’anello del nibelungo
Che spettacolo!
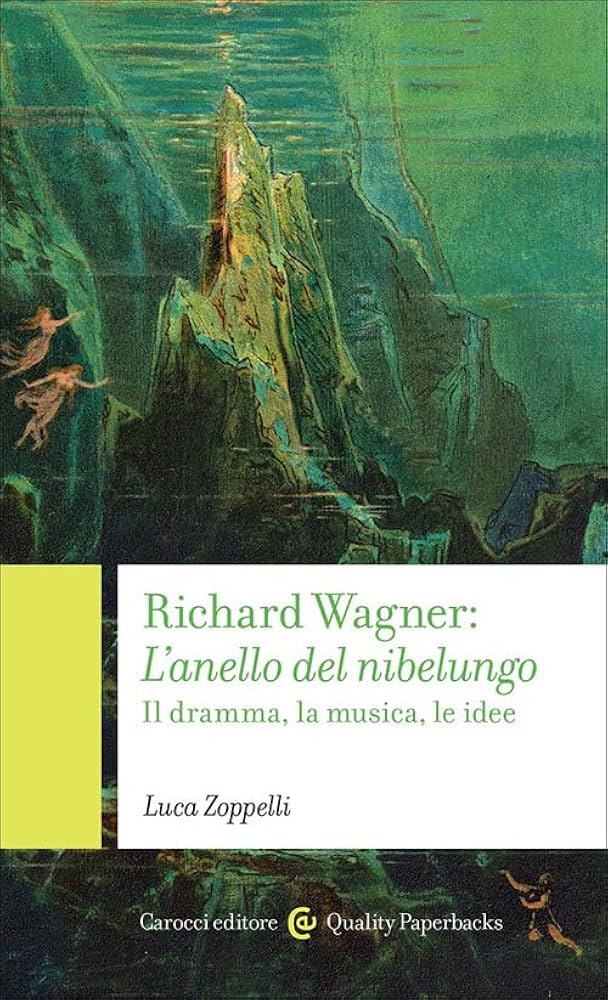
Luca Zoppelli
Richard Wagner
L’anello del nibelungo
Il dramma, la musica, le idee
Carocci, 2025, pp. 244
€ 22
Credo che siano davvero pochissimi gli autori italiani che, come in questo caso, mostrino una conoscenza così approfondita e analitica, del colossale impianto della Tetralogia wagneriana (il “Ring”, in tedesco).
E a ciò si aggiunga una notevole capacità comunicativa, pur all’interno di tematiche dense e multistrato, con ricchi riferimenti agli spartiti, e molte pagine desunte dagli stessi, con decine e decine di esempi musicali.
A 17 anni, 1973, il marito di mia zia, mi regala, in musicassette, il riversamento del leggendario Ring della Decca, 1958/1963, con la Filarmonica di Vienna e Georg Solti, oltre a un cast non di rado superbo, e una registrazione che anche nelle ultimissime rimasterizzazioni mostra che John Culshaw & Co, la produzione, realizza qualcosa nell’analogico celeberrimo FFSS (Full Frequency Stereophonic Sound), che resta una (starei quasi per dire “La”) pietra miliare, certamente dal punto di vista tecnico, di questo colossale lavoro.
Nel 1978 sentii al Covent Garden tutto il Ring, con la trasparenza paramozartiana di Colin Davis; e nel 1992 mi feci una full immersion a Bayreuth del modernissimo e diversissimo allestimento di Harry Kupfer e Daniel Barenboim sul podio.
Come dico agli amici Wagner è l’equivalente del mio ventricolo di destra, Verdi quello di sinistra. Ci sta poi un posto tutto speciale per Bellini: e la constatazione che Mozart, ovunque, è pura musica.
La cosa che rendeva unico il Ring di Solti, era un cofanetto aggiuntivo di 3 Lp, dove il produttore, con la collaborazione del maestro e dei Wiener Philharmoniker, faceva una sorta di “mega-spelling”, di tutti i Leit-Motiv wagneriani, e tutte le loro rielaborazioni sparpagliate, nelle 4 opere di questa creazione.
Certo, in un formato più ridotto, è quanto si legge nelle ultime pagine del libro. Potrebbe essere stato il frutto di un ascolto integrale del megalavoro Decca.
Molto interessante anche la parte iniziale del libro di Carocci, una specie di sintesi della vita di Wagner, pubblica e privata, con annotazioni spesso davvero acute e puntuali: forse, per voler stringere e condensare decenni così intensi, a cavallo di metà Ottocento, a tratti il racconto un po’ si ingorga, nel fiume di agganci e riferimenti; sempre centrati, ma forse un po’ “in overdose”.
Le pagine stesse sono davvero piene, con 40 righe e almeno 70 battute per riga.
La parte delle interpretazioni, particolarmente dal 1951 (“Neue Bayreuth”), sostanzialmente mi pare giusta, facendo emergere le vene “liriche” delle interpretazioni di Karajan (invero non così rivoluzionarie), e la potenza cruda e dissacrante dell’allestimento Chereau/Boulez 1976/1980: al primo anno furiosamente contestato (sentire certi audio su Youtube), e nell’ultimo osannato, tanto da convincere la Philips a farne LP e VHS, proprio nell’anno di congiunzione tra Analogico e Digitale, 1980.
Pure se sempre tutto anticipato, per le grandi label commerciali, al solito, da Decca (Concerto di Capodanno da Vienna 1/1/1979 Wiener Philharmoniker Willi Boskovsky)!
Davvero perla rarissima. Un italiano con grande competenza in Wagner.
Prima della guerra furono, a Bayreuth, Toscanini e de Sabata: dopo, parliamo di Bayreuth, ci sta Sinopoli: e, per me, farebbero grandi cose sia Pappano che, forse una nuance oltre, Gatti.
Wagner non chiede mezze misure. Aggancio alleggerente, ma collegato. Ricordate “Pretty Woman”? Gere che porta la Roberts sul jet privato a San Francisco a vedere “Traviata”. Cosa le dice? A proposito della Lirica? “Se la ami (e la “senti”, dentro) la amerai per sempre… altrimenti sarà sempre qualcosa che, per quanto ti sforzi, non ti dirà mai nulla”.
Wagner, Verdi, Bellini, Mozart: o sono per sempre; o sono e resteranno, sempre, lettera morta.