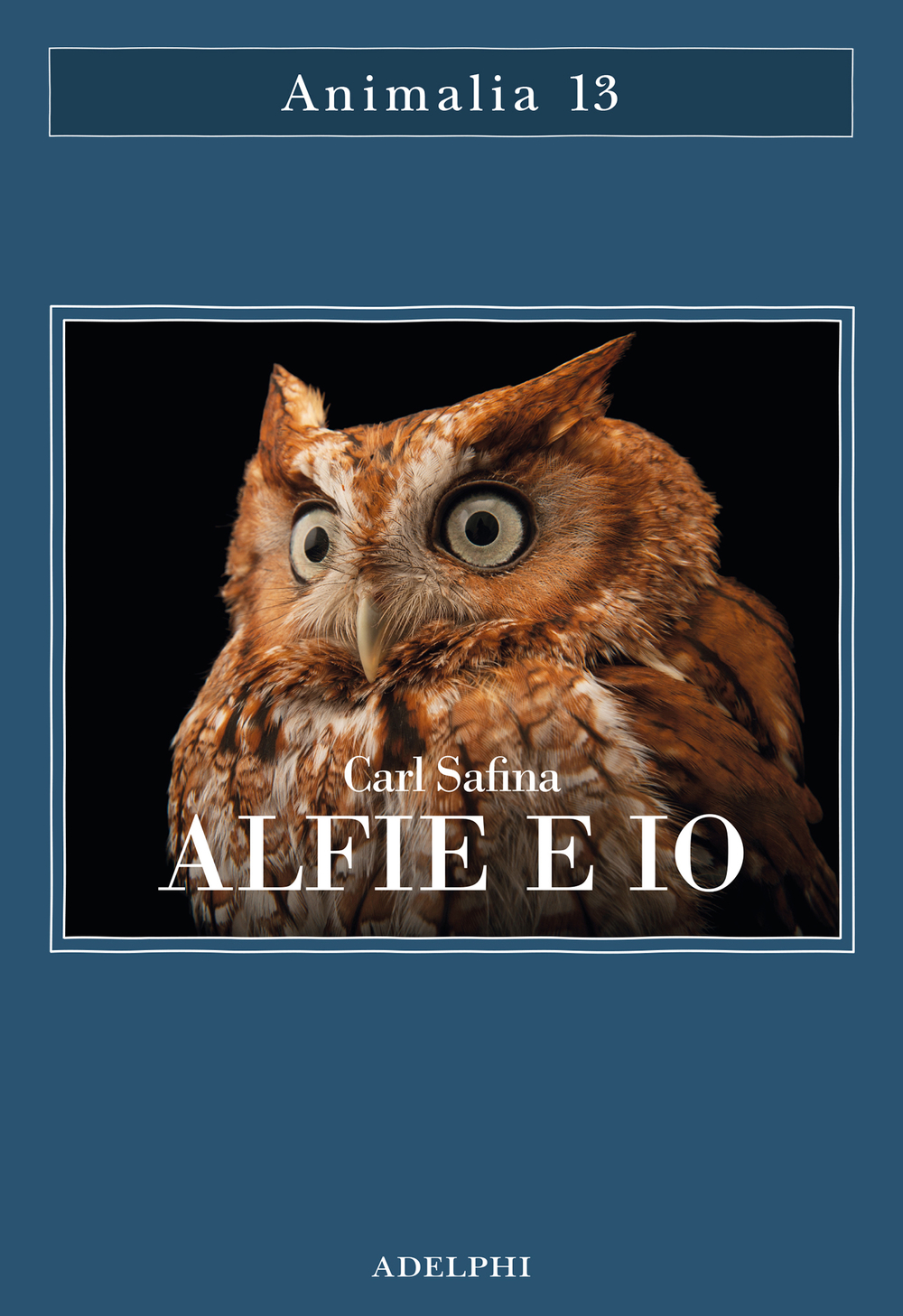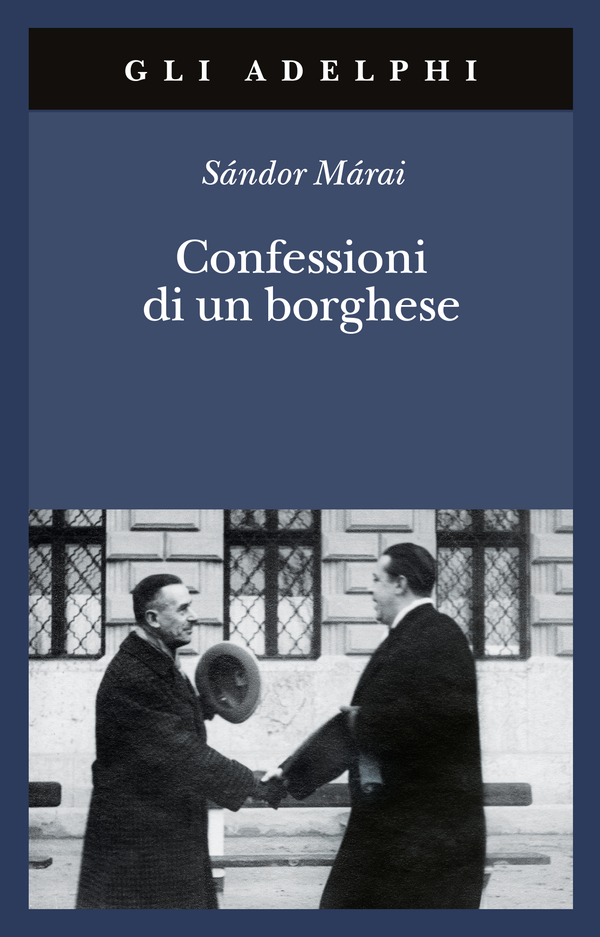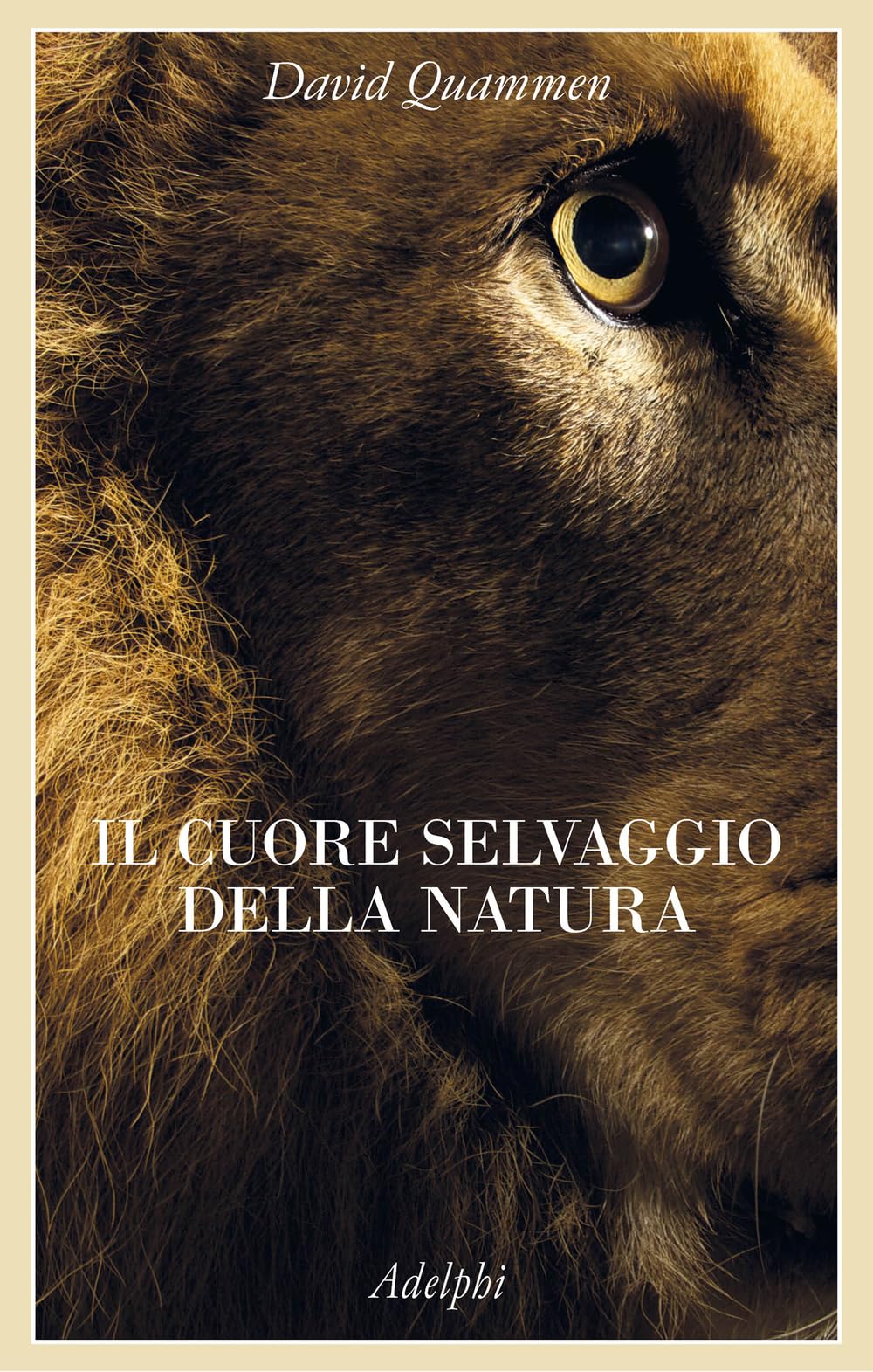Specchi, sogni, labirinti
Tante storie
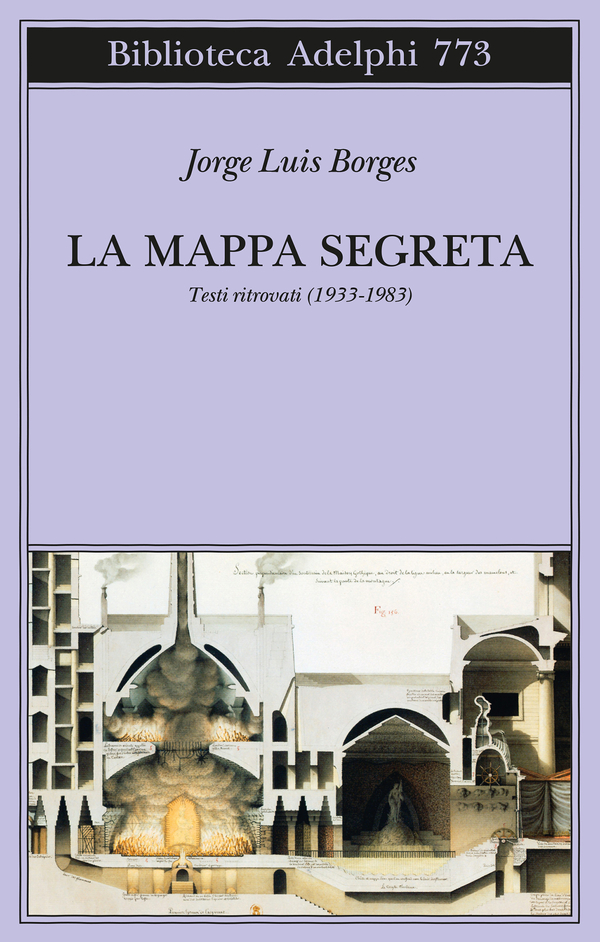
Jorge Luis Borges
La mappa segreta. Testi ritrovati (1933-1983)
A cura di Tommaso Scarano, traduzione di Rodja Bernardoni
Adelphi, 2025, pp. 285
€ 22
A quasi quarant’anni dalla morte di Jorge Luis Borges, Adelphi prosegue la sua monumentale impresa editoriale con La mappa segreta, selezione di testi dal secondo e terzo volume dei Testi ritrovati, relativa al cinquantennio 1933-1983. Il libro, curato dallo studioso Tommaso Scarano, già voce autorevole della borgesiana italiana, raccoglie più di cinquanta testi del grande scrittore argentino, molti dei quali inediti in Italia, dispersi fra giornali, riviste e conferenze, selezionati con il criterio – dichiarato – di privilegiare ciò che aiuti a comprendere Borges stesso, più che una panoramica filologica completa.
Come suggerisce il titolo, si tratta di una mappa – segreta, appunto – che guida lettrici e lettori in territori familiari del cosmo borgesiano, ma da angolature sorprendenti, talora illuminanti: saggi, articoli, note, omaggi e brevi esercizi di riflessione in cui il pensiero di Borges, già nella sua maturità, si dispone in trame cristalline o sottili, facendo della brevità uno strumento di densità, della digressione un’arte. Lungo le 285 pagine di questa silloge si muove un autore che, pur ormai celebre e celebrato, non ha smesso di interrogare il tempo, la letteratura, l’identità e l’ombra.
Il titolo scelto per questa raccolta – La mappa segreta – sfrutta quello di uno dei racconti ivi contenuti ma ne estende il significato in senso programmatico. I testi qui raccolti non sono mere curiosità filologiche, ma vere e proprie mappe del pensiero e dell’immaginario borgesiano. Sono percorsi segreti che attraversano cinquant’anni di scrittura e testimoniano una coerenza interiore impressionante. Borges non cambia idea, semmai la affina. Non si contraddice, ma si approfondisce. Non si ripete, ma si varia all’infinito.
Uno degli assi portanti della raccolta è l’inesausta curiosità intellettuale dell’autore. In Borges, leggere significa decifrare l’universo. Che si tratti di Dante, Poe, Kafka, Whitman, Shakespeare, Nietzsche o Montaigne, lo sguardo dell’argentino è sempre fondato su una domanda profonda: che cosa ci dice questo autore su ciò che siamo?
Un altro asse portante della riflessione borgesiana è il tempo. Non come semplice dimensione cronologica, ma come sostanza stessa dell’essere. Borges, lettore attento di Schopenhauer e Nietzsche, assimila la dottrina dell’eterno ritorno, ne coglie i riflessi in Platone e in Eliot, la modella in figure letterarie e la dissemina nei suoi racconti come nei suoi saggi. La sua idea di tempo è simultaneamente ciclica e labirintica, carica di nostalgia e di possibilità, fatta di specchi e biforcazioni.
Nel saggio Il mio primo incontro con Dante, Borges racconta con tono intimo come a trentun anni, sul tram che lo portava ad Almagro, scoprì per caso la Commedia e ne fu conquistato per sempre. È uno dei rari momenti in cui l’autore confessa una personale rivelazione estetica, elevando l’esperienza di lettura a momento trasformativo. Non c’è, per Borges, un’ultima lettura di Dante: «una volta scoperto, continua ad accompagnarci fino alla fine», come una città che non si finisce mai di esplorare.
Nel contributo su T.S. Eliot, Borges riflette su un’idea che farà sua: ogni scrittore, nel tempo, rilegge e modifica i testi del passato, influenzandoli retroattivamente. Così, l’opera di un autore del Novecento può riscrivere la percezione che abbiamo di Omero. La letteratura, in questa prospettiva, non è una linea retta, ma una rete di corrispondenze e specchi infiniti.
Altri testi mettono in campo la riflessione ontologica e metafisica tipica del Borges più filosofico. In Gli incubi e Franz Kafka, lo scrittore interpreta l’opera dell’autore praghese come un sogno continuo, una letteratura che nasce nella semicoscienza, che si muove fra allucinazione e allusione. Kafka – insieme a Poe, Beckford, Swedenborg e Blake – diventa uno dei grandi sognatori della modernità.
Il sogno e il suo riflesso letterario – l’incubo – sono per Borges non mere fughe dalla realtà, ma esplorazioni dell’essenza stessa della condizione umana. Borges individua nella scrittura kafkiana una realtà onirica più autentica del reale: “una costruzione mentale così perfetta da essere indistinguibile dalla veglia”. Il sogno, infatti, si rivela come uno strumento conoscitivo, una mappa cifrata per orientarsi nel caos.
Questa affinità tra sogno e letteratura porta Borges a un’altra conclusione radicale: che ogni narrazione sia in fondo un sogno condiviso. Ecco allora che la narrativa poliziesca, con le sue regole ferree e la sua logica inesorabile, diventa per lui una delle forme più alte di letteratura. In Leggi della narrazione poliziesca, saggio del 1933, Borges ne delinea la natura duale: essa risponde simultaneamente al nostro bisogno di mistero e al nostro desiderio di ordine. È, a suo modo, un’utopia narrativa.
E poi, naturalmente, c’è il tema dell’identità. Nel brillante saggio Voler essere un altro, Borges destruttura la pretesa banalità dell’anelito a “essere un altro”, smascherando le illusioni che la lingua cela sotto la sintassi. Con logica tagliente mostra che ogni desiderio di essere qualcun altro – sia esso Goethe, Alvear o Joan Crawford – si infrange sul paradosso dell’io: se davvero B diventasse N, nessuno dei due ne sarebbe consapevole. L’identità si rivela, come spesso in Borges, un fantasma, una costruzione senza centro.
In La mappa segreta, discorso pronunciato nel 1956 a Buenos Aires, emerge un altro tema fondamentale: quello del paesaggio e della memoria. La geografia sentimentale di Borges è innanzitutto urbana, e la città che più di ogni altra incarna la sua mitologia è Buenos Aires. Borges ritorna alla sua città dopo sette anni in Europa e tenta, attraverso la scrittura, di riappropriarsene. Non si tratta della Buenos Aires reale, ma di una città trasfigurata dalla letteratura, dalla nostalgia, dalla mitopoiesi personale. “Per cogliere integralmente l’anima – immaginaria – del paesaggio”, scrive, “bisogna scegliere una di quelle ore orfane che vivono come spaventate dagli altri e delle quali nessuno si cura”. La città diventa una mappa dell’anima, un luogo irreale che può essere descritto solo «per allusioni e simboli». L’identità, qui, si confonde con la geografia personale.
In questa topografia interiore, il gaucho assume una posizione centrale. Figura liminale tra barbarie e civiltà, tra mito e storia, il gaucho è per Borges non solo un archetipo nazionale, ma un simbolo esistenziale: è l’eroe che sfida il tempo e l’oblio, la voce di una terra destinata alla trasformazione perpetua.
Ciò che emerge con forza è anche il Borges ermeneuta, che legge la cultura come un gioco di riflessi. Nella Nota sull’Ulisse in spagnolo, per esempio, afferma la modernità di Joyce, ma ne critica l’eccessiva verbosità. Il romanzo, a suo avviso, è un genere che rischia di perdersi in dettagli superflui, mentre il racconto – breve, preciso – può contenere tutta la complessità dell’esistenza. È una dichiarazione di poetica implicita: Borges ha sempre prediletto l’essenzialità.
Nel testo su Apollinaire, sottolinea come il contesto alteri il significato di un’espressione: dire che la guerra è meravigliosa, in bocca a un poeta come Apollinaire, può significare tante cose diverse, dalla nostalgia per l’epica alla più cupa adesione all’orrore. Borges smonta così ogni idea di verità assoluta del linguaggio, insistendo sulla natura proteiforme dei segni.
In Il concetto di accademia e i Celti o in Difesa del 1900, Borges ironizza, riflette, si difende e rilancia: l’identità culturale è una costruzione, la tradizione un mosaico che ogni scrittore deve avere il diritto di rimontare a piacimento. Per questo può dire che «la nostra tradizione è l’intera cultura occidentale» e che un argentino ha il diritto – forse più di un europeo – di trattare Shakespeare, Dante o Kafka con «un’irriverenza che può avere e ha avuto conseguenze felici».
Anche nei testi apparentemente più estemporanei – brevi note, discorsi, commemorazioni – la scrittura di Borges è sempre intrisa di riflessione. Il tono varia: può essere commosso (Omaggio a Xul Solar, Norah), divertito (Due antichi problemi), affilato (Il paradosso di Apollinaire), ma non perde mai la precisione di un pensiero che ha scelto di farsi letteratura.
A colpire, nei testi raccolti, è anche la forza della struttura: ogni pezzo è un piccolo meccanismo perfettamente architettato, dove nulla è lasciato al caso. Borges riesce a toccare, in poche pagine, idee che potrebbero occupare interi volumi. Così, dietro a un aneddoto sul barbiere del fratello di Al Capone o su un passo del Don Chisciotte, si apre un’intera cosmologia.