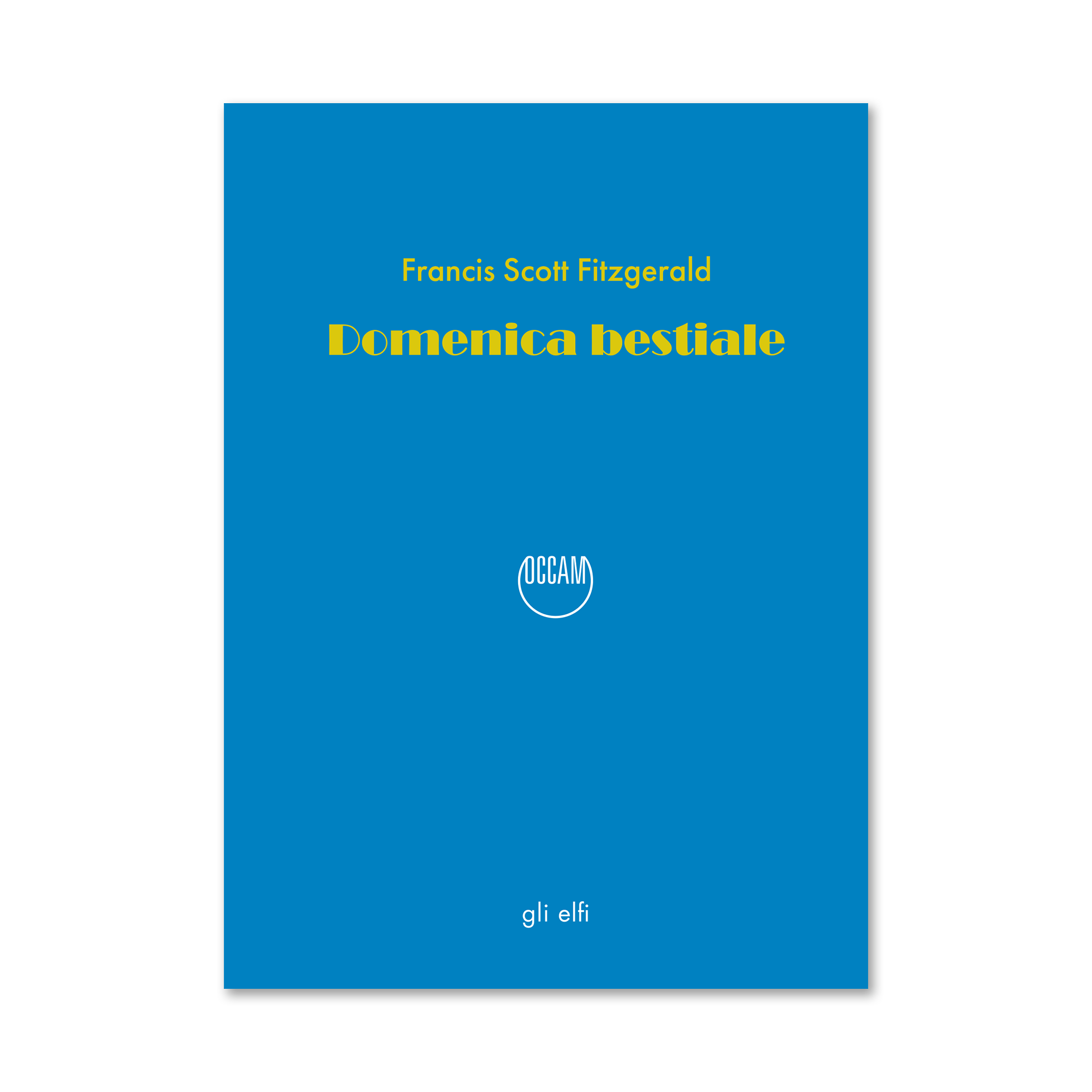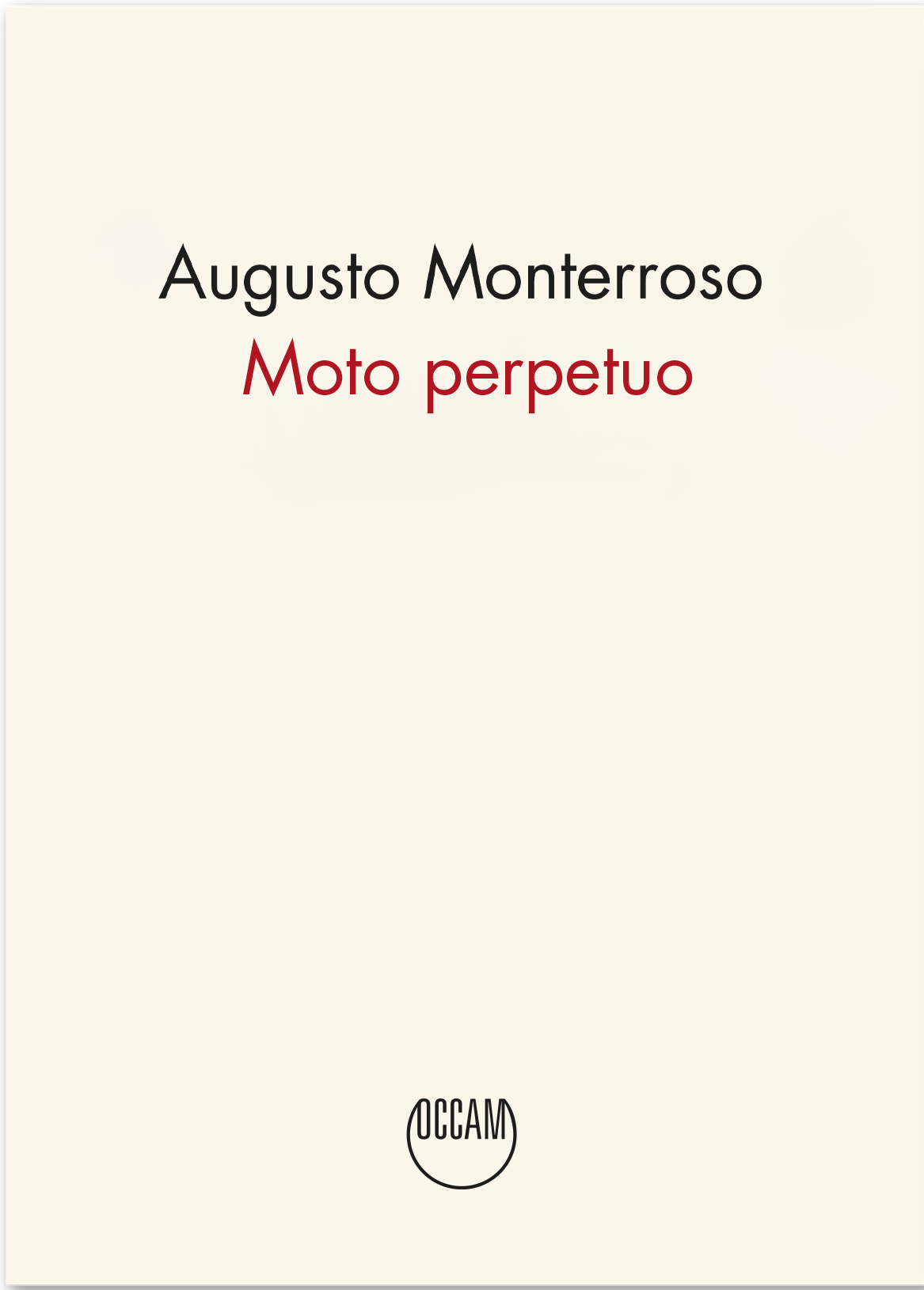Malinconia dell’assurdo
Tante storie
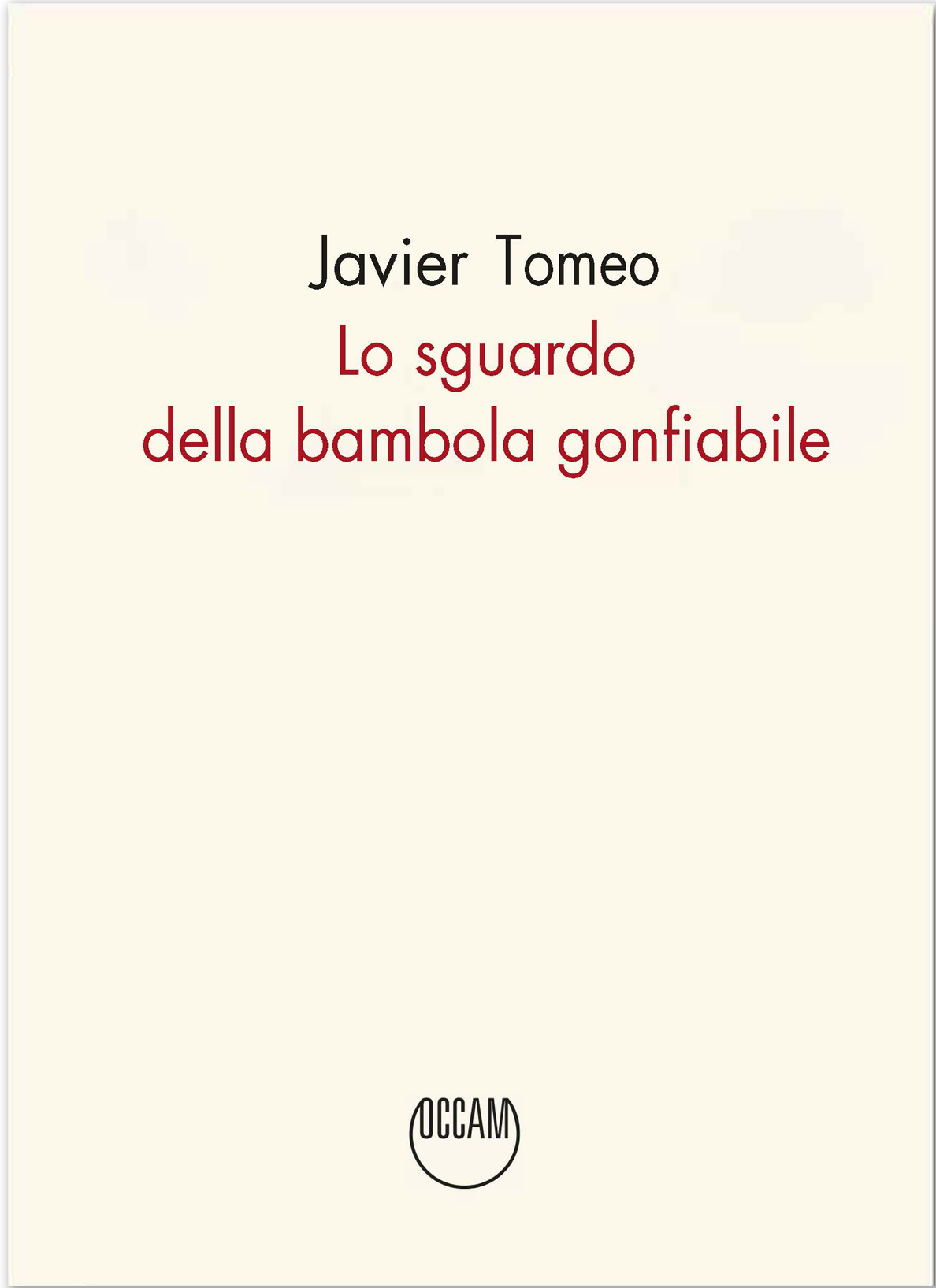
Javier Tomeo
Lo sguardo della bambola gonfiabile
Occam, 2025, pp. 161
€ 16
L’opera di Javier Tomeo (1932-2013), scrittore e drammaturgo spagnolo, è caratterizzata da uno stile minimalista e da una visione grottesca dell’esistenza. La sua fama letteraria, sebbene non sempre accompagnata da un successo commerciale, è cresciuta nel tempo, soprattutto all’estero, dove le sue opere sono state tradotte in diverse lingue e rappresentate in teatro. Autore prolifico, ha pubblicato numerosi romanzi, racconti e opere teatrali, molti dei quali ruotano attorno a personaggi solitari e disadattati. Lo sguardo della bambola gonfiabile, uscito originariamente nel 2003 e ora tradotto in italiano da Occam, è un esempio emblematico del suo genio narrativo, oscillando tra la riflessione filosofica e una commedia nera.
Il romanzo ruota attorno a Juan P, un uomo solo che condivide la sua vita con una bambola gonfiabile, Dorotea, e con un amico dalle orecchie enormi, Torcuato, con il quale condivide un rapporto ambiguo, fatto di complicità grottesche e silenzi minacciosi. Attorno a loro si muovono altri personaggi eccentrici: una coppia di anziani invidiosi dell’amore altrui, un maître sospettato di servire funghi velenosi, una nobildonna e una portinaia ciascuna con le loro ossessioni. Questi individui, uniti dalla convinzione che l’intelligenza sia un’illusione, incarnano una galleria di ritratti grotteschi.
La voce narrante, Juan P, si rivela un personaggio intrigante, un osservatore attento dei dettagli più minuti della sua esistenza e dell’ambiente che lo circonda, ma anche un individuo che sembra oscillare tra il reale e l’immaginario, tra il passato e un presente che appare costantemente sospeso nel tempo. La descrizione che dà di sé stesso, delle sue piccole manie, delle sue abitudini quotidiane e delle sue osservazioni sui vicini, rappresenta un microcosmo di una realtà che potrebbe sembrare insignificante, ma che in realtà cela una profondità e un senso più ampio. La narrazione si sviluppa attraverso una serie di dettagli apparentemente banali, come il conteggio delle ciminiere o la descrizione delle persone che passano in strada, che assumono un valore simbolico e metaforico, rivelando le ansie, le paure e i desideri di un individuo che cerca di trovare un senso nel caos del mondo esterno.
Tomeo costruisce un mondo sospeso tra malinconia e assurdo, dove la stupidità viene elevata a virtù quasi rilassante, un ideale a cui l’uomo aspira con tutte le sue forze. La trama è assente in senso tradizionale: non ci sono eventi concatenati, ma una situazione drammatica prolungata che si dipana in un flusso di azioni e dialoghi surreali. Juan P trascorre le sue giornate tra monologhi con la bambola, passeggiate urbane con Torcuato e visioni televisive di suicidi di balene o accoppiamenti mostruosi. La sua routine è scandita da gesti ripetitivi mentre la città attorno a lui sembra animarsi di vita propria. Le macchie sul soffitto, che si allungano e si restringono come se fossero vive, sono il simbolo di questa ricerca di senso, di questa tensione tra il reale e l’immaginario che permea tutto il romanzo, della percezione soggettiva del tempo e dello spazio, e del modo in cui l’individuo interpreta e si confronta con il mondo esterno.
Le sequenze in cui il protagonista percepisce il tempo che si muove all’indietro, o le sue conversazioni immaginarie con la madre, sono esempi di come l’autore giochi con le percezioni e le emozioni, inducendo a interrogarci sulla natura della realtà e sulla soggettività. La scena in cui Juan P si immagina di tornare indietro nel tempo, di essere più giovane, o di vedere le lancette dell’orologio che camminano all’indietro, sono simboli di una nostalgia verso un passato che forse non è mai esistito, o di un desiderio di fuga dalla realtà presente. La presenza della musica, con un violinista che suona nel condominio, introduce un elemento di poesia e di contemplazione.
Il romanzo riesce a rappresentare metaforicamente il disorientamento collettivo e individuale della società contemporanea. Juan P incarna questa condizione: la sua solitudine è mitigata solo da oggetti inanimati – la bambola, il televisore, le ciminiere – che assumono un ruolo quasi umano, diventando compagni di una quotidianità altrimenti vuota. La mancanza di comunicazione reale è sostituita da un dialogo immaginario con ciò che non può rispondere, in un gioco di proiezioni che rivela la disperazione silenziosa del protagonista.
Tomeo, con la sua prosa asciutta e cartesiana, trasforma l’assurdo in poesia. La sua scrittura, pur nella sua apparente semplicità, è carica di una “luce interiore” che illumina le profondità dell’animo umano. I personaggi, spesso ai margini della realtà, sono ritratti con una miscela di ironia e compassione, mentre la trama – o meglio, la sua assenza – diventa un pretesto per esplorare le ossessioni e le paure che abitano l’uomo moderno.