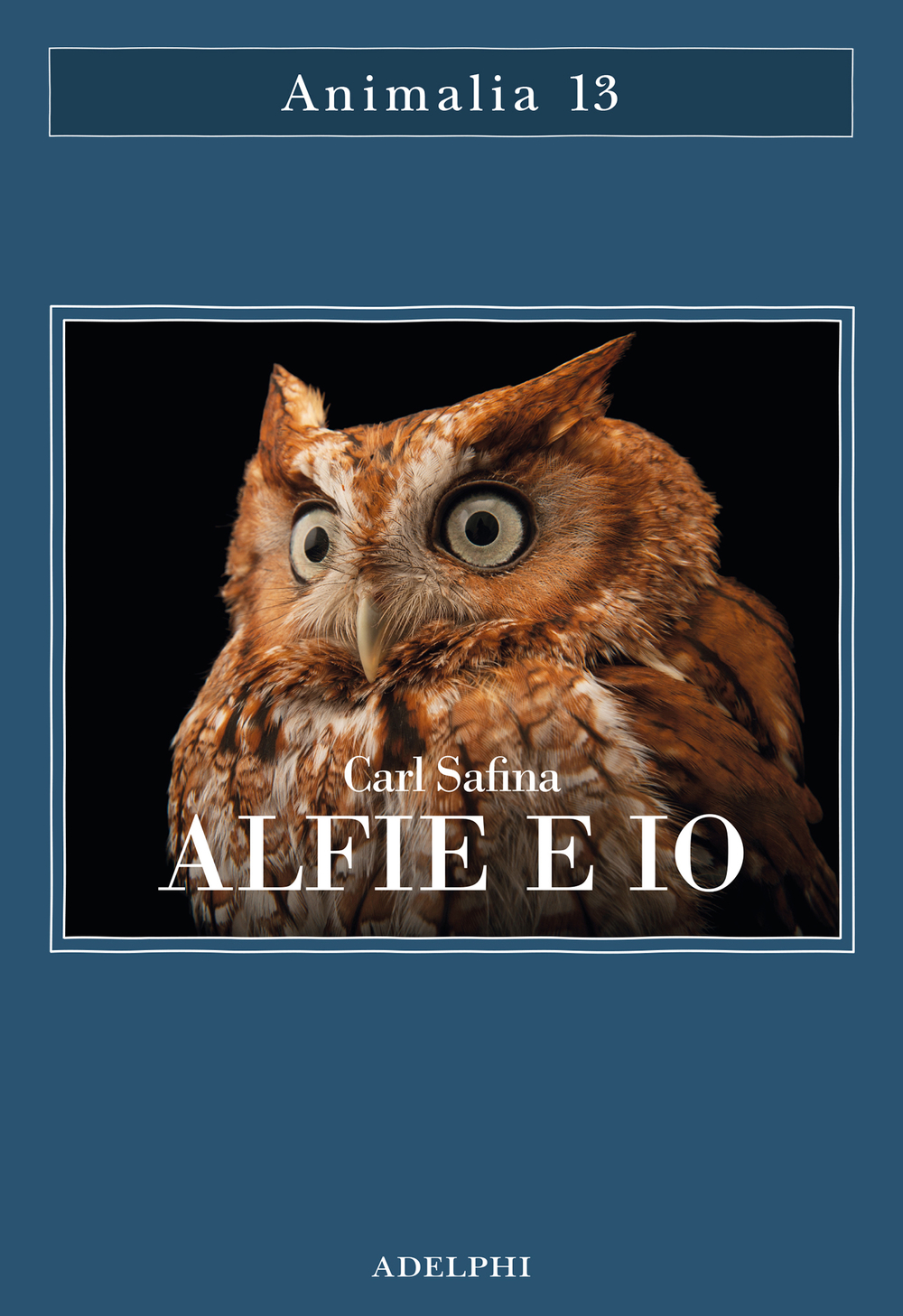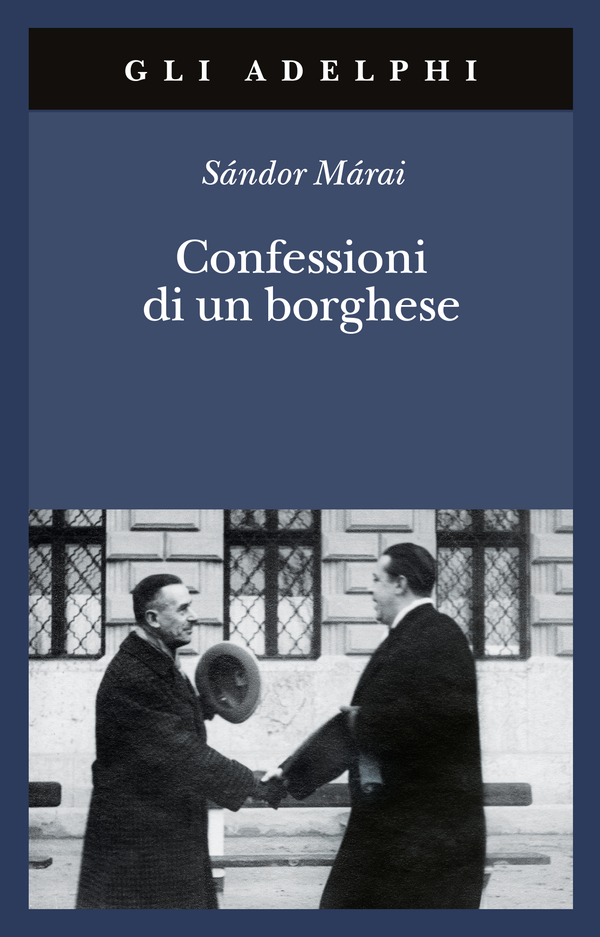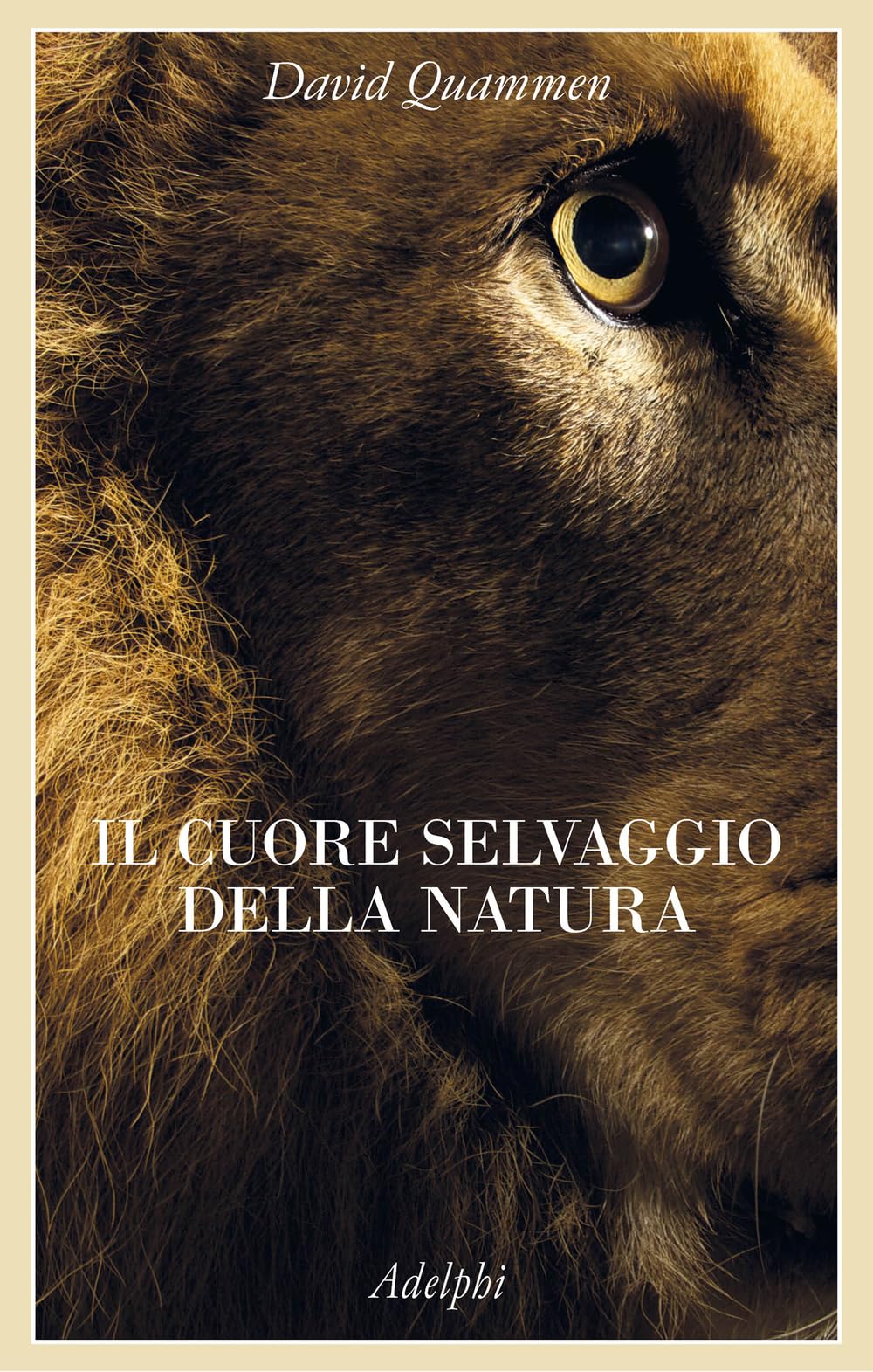L’arte di raccontare
Dice il saggio

Isaac Bashevis Singer
A che cosa serve la letteratura?
A cura di David Stromberg
Adelphi, 2025, pp. 210
€ 19
“A che cosa serve la letteratura?” di Isaac Bashevis Singer, pubblicato da Adelphi con la curatela di David Stromberg e traduzione di Marina Morpurgo, è una raccolta di saggi che offre un accesso privilegiato al pensiero letterario e filosofico di uno degli autori più significativi del XX secolo. Il libro è arricchito da un saggio conclusivo del curatore, che fornisce un’analisi illuminante sulla poetica di Singer e sul suo rapporto con la scrittura.
Singer è universalmente noto come maestro della narrazione, ma il suo ruolo di saggista è stato a lungo trascurato. Questo volume raccoglie testi che spaziano dalla riflessione sulla letteratura all’indagine sulla cultura yiddish ebraica, fino a questioni filosofiche e autobiografiche. La suddivisione in tre sezioni – Le arti letterarie, Yiddish e vita ebraica e Scritti personali e filosofia – facilita l’approccio al pensiero dell’autore.
Nella prima sezione, Singer affronta questioni fondamentali sul ruolo della letteratura nella società contemporanea. Il saggio A che cosa serve la letteratura? pone le basi della sua poetica, rifiutando l’idea della letteratura come strumento di propaganda o analisi sociologica. Per Singer, lo scrittore è prima di tutto un narratore, un intrattenitore che deve rimanere fedele alla verità dell’esistenza umana. Egli diffida delle mode letterarie, denunciando il pericolo di una cultura che privilegia il messaggio politico o ideologico a scapito della qualità narrativa.
L’autore si oppone alla censura in ogni sua forma (Perché la censura letteraria è dannosa), critica il giornalismo per la sua tendenza alla superficialità (Giornalismo e letteratura) e difende il valore della narrazione tradizionale (Narrazione e letteratura). Un aspetto centrale della sua riflessione è la distinzione tra vecchie verità e nuovi cliché: Singer ammonisce contro la tendenza della modernità a sostituire principi consolidati con idee effimere, prive di autenticità e profondità.
La seconda sezione del volume è dedicata allo yiddish e alla cultura ebraica, elementi centrali nell’opera di Singer. In Yiddish, lingua dell’esilio, l’autore riflette sul destino della lingua yiddish, che definisce come “una lingua senza Stato, ma con un’anima immortale”. La sua difesa dello yiddish non è soltanto una rivendicazione linguistica, ma un atto di resistenza culturale contro l’assimilazione e l’oblio.
La Qabbalah e il pensiero mistico occupano un posto significativo nella sua riflessione, come emerge nel saggio La Qabbalah e i tempi moderni. Singer non aderisce a una visione dogmatica della religione, ma è affascinato dalle tensioni tra libero arbitrio e destino, bene e male, elementi che ritornano nei suoi romanzi più celebri. I Dieci Comandamenti e la critica moderna offre invece una riflessione ironica e provocatoria su come la modernità abbia svuotato i precetti religiosi della loro valenza etica e spirituale.
L’ultima parte del libro raccoglie saggi più personali, in cui Singer racconta il suo rapporto con la scrittura e la spiritualità. Perché scrivo come scrivo è un testo rivelatore, in cui l’autore spiega la sua scelta di non seguire le mode letterarie, rimanendo fedele alla propria visione. Egli rifiuta il realismo psicologico dominante nella letteratura del suo tempo, preferendo un approccio narrativo più libero e intuitivo. In Un concetto personale di religione Singer definisce la fede non come adesione dogmatica, ma come una ricerca continua di significato. Egli descrive Dio come un autore che scrive la storia dell’umanità, lasciando però agli uomini la possibilità di contribuire alla narrazione. Questa visione emerge anche nel saggio conclusivo del curatore, Gli scrittori non scrivono per il cassetto, che ricostruisce il complesso rapporto di Singer con la pubblicazione dei suoi saggi. Il lavoro di curatela di David Stromberg è prezioso, poiché ricostruisce nelle note finali il contesto storico e editoriale in cui questi saggi furono scritti e pubblicati.