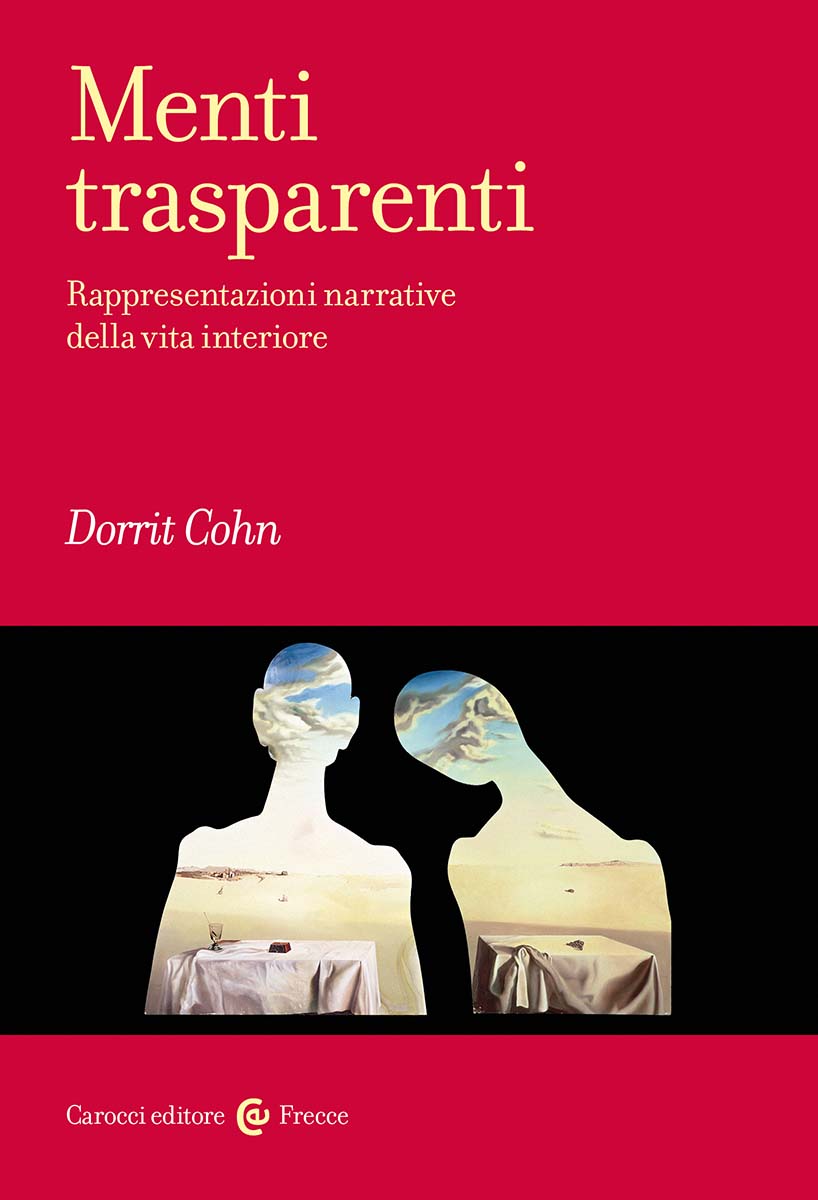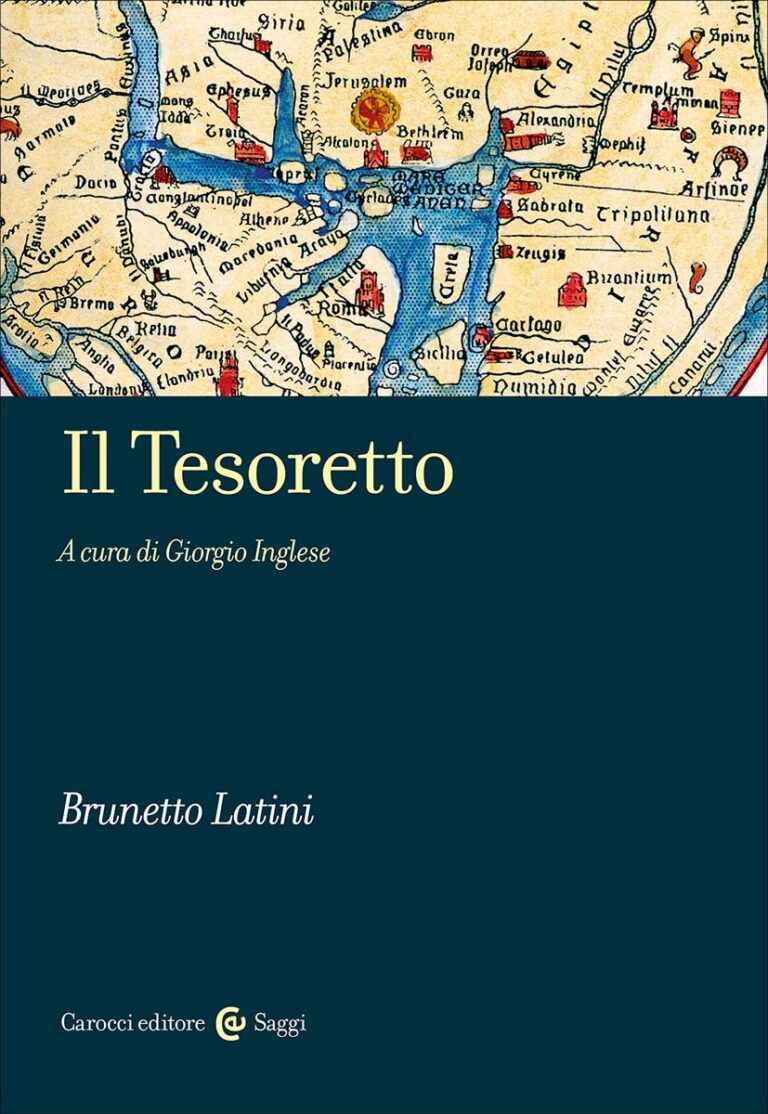Logge, potere e dittatura
Dice il saggio
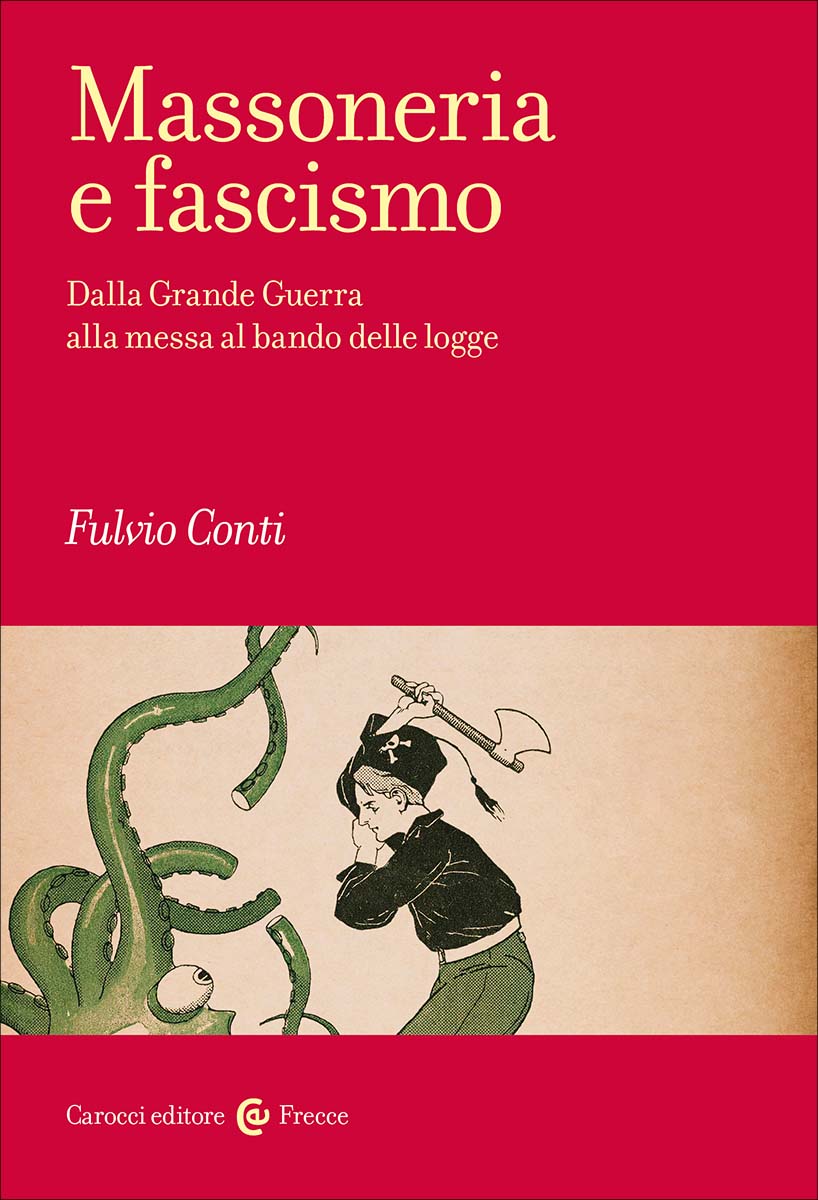
Fulvio Conti
Massoneria e fascismo
Dalla Grande Guerra alla messa al bando delle logge
Carocci, 2025, pp. 320
€ 29
Fulvio Conti, professore ordinario di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Firenze, è un autorevole studioso della storia sociale e politica dell’Ottocento e del Novecento, con un’attenzione particolare per la massoneria. Tra le sue pubblicazioni più significative sul tema spiccano Storia della massoneria italiana. Dal Risorgimento al fascismo (Il Mulino, 2006), Massoneria e religioni civili (Il Mulino, 2008), La massoneria italiana da Giolitti a Mussolini. Il gran maestro Domizio Torrigiani (Viella, 2014) e I fratelli e i profani. La massoneria nello spazio pubblico (Pacini, 2020).
Con Massoneria e fascismo. Dalla Grande Guerra alla messa al bando delle logge (Carocci, 2025), Conti offre un contributo fondamentale per comprendere uno degli aspetti più controversi e meno esplorati della storia italiana del primo Novecento: il rapporto tra la massoneria e il regime fascista, dall’ascesa di Mussolini alla repressione delle logge nel 1925.
Il libro si distingue per un approccio metodologico rigoroso, basato su un’ampia documentazione archivistica, tra cui verbali degli organi direttivi del Grande Oriente d’Italia, circolari dei gran maestri, carteggi e articoli di riviste massoniche. Conti evita interpretazioni univoche o semplificazioni, preferendo far emergere la complessità e le contraddizioni di un rapporto che attraversa diverse fasi: dall’ostilità iniziale di Mussolini socialista verso la massoneria, alla temporanea convergenza di interessi durante il biennio rosso, fino alla rottura definitiva con la messa al bando delle logge. L’autore ricostruisce con precisione come la massoneria, istituzione radicata nella classe dirigente sin dal Risorgimento e dall’Unità d’Italia, abbia inizialmente visto nel fascismo un possibile baluardo contro il bolscevismo e il l’impegno popolare cattolico, salvo poi diventare una delle prime vittime della svolta autoritaria del regime.
Uno dei meriti principali del libro è quello di restituire voce ai protagonisti dell’epoca, mostrando come le decisioni della massoneria non fossero monolitiche, ma frutto di dibattiti interni spesso conflittuali. Ad esempio, Conti analizza le divergenze tra il Grande Oriente d’Italia, guidato da Domizio Torrigiani, e la Gran Loggia d’Italia di Piazza del Gesù, più vicina al fascismo. Emerge così un quadro in cui i massoni, pur condividendo valori laici e anticlericali, si trovarono divisi tra chi sosteneva Mussolini e chi, come Giovanni Amendola, finì per opporsi al regime. La ricostruzione degli eventi chiave, come il congresso socialista di Ancona del 1914, la marcia su Roma del 1922 e l’assassinio di Matteotti del 1924, è arricchita da dettagli inediti che gettano luce sul ruolo ambiguo della massoneria, talvolta alleata, talvolta avversaria del fascismo.
Particolarmente interessante è l’analisi del cospicuo finanziamento massonico al fascismo, già per la Marcia su Roma, documentato da lettere e carte d’archivio che rivelano come alcune logge abbiano contribuito economicamente all’ascesa di Mussolini, illudendosi di poterlo controllare. Tuttavia, come dimostra Conti, questa illusione si infranse rapidamente: già nel 1923, il Gran Consiglio del Fascismo, a sua volta composto da numerosi massoni, impose l’incompatibilità tra appartenenza al partito e affiliazione massonica, e nel 1925, con la legge contro le associazioni segrete, le logge furono definitivamente sciolte. L’autore sottolinea come questa repressione non fosse dettata solo da ragioni ideologiche – tra cui l’antica avversione personale di Mussolini per la massoneria – ma anche da una precisa scelta politica. Il regime, infatti, optò per un’alleanza strategica con i nazionalisti e con il Vaticano, entrambi tradizionalmente ostili alla massoneria. Mussolini, pur consapevole del sostegno che molti massoni avevano dato al fascismo nelle sue fasi iniziali, valutò più opportuno schierarsi con forze più influenti e consolidate per l’affermazione del regime, come la Chiesa cattolica e i circoli nazionalisti, sacrificando così i legami con la libera muratoria.
Il libro si conclude con una riflessione sul declino della massoneria come attore politico e sulla sua eredità nella storia italiana. Conti evidenzia come, nonostante la messa al bando, molti massoni continuarono a operare clandestinamente o in esilio, partecipando attivamente alla resistenza antifascista. Inoltre, l’autore ricorda come figure chiave del 25 luglio 1943, come Dino Grandi, fossero legate alla massoneria, suggerendo un’influenza indiretta di questa istituzione nella caduta di Mussolini, sebbene senza attribuirle un ruolo preponderante.
Massoneria e fascismo colma una lacuna negli studi sul periodo. Conti combina erudizione e chiarezza espositiva, offrendo una narrazione avvincente e ben documentata. Il libro non solo approfondisce un tema trascurato dalla storiografia tradizionale, ma invita anche a ripensare criticamente le dinamiche del potere nell’Italia liberale e fascista, mostrando come la scelta antisocialista e antimassonica del regime rispondesse a calcoli politici ben precisi, ancor prima che a motivazioni ideologiche.