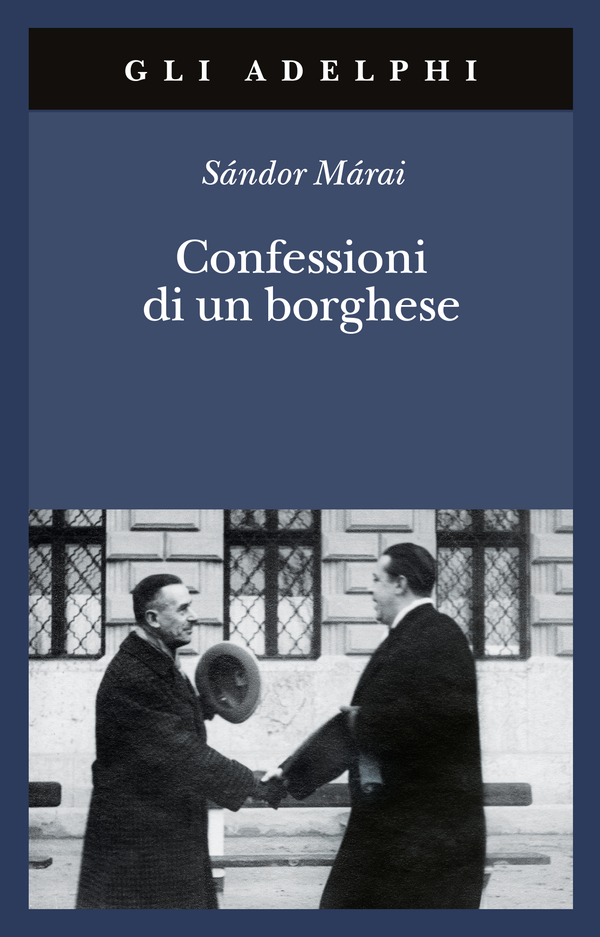Cattolicesimo italiano senza voce
Dice il saggio
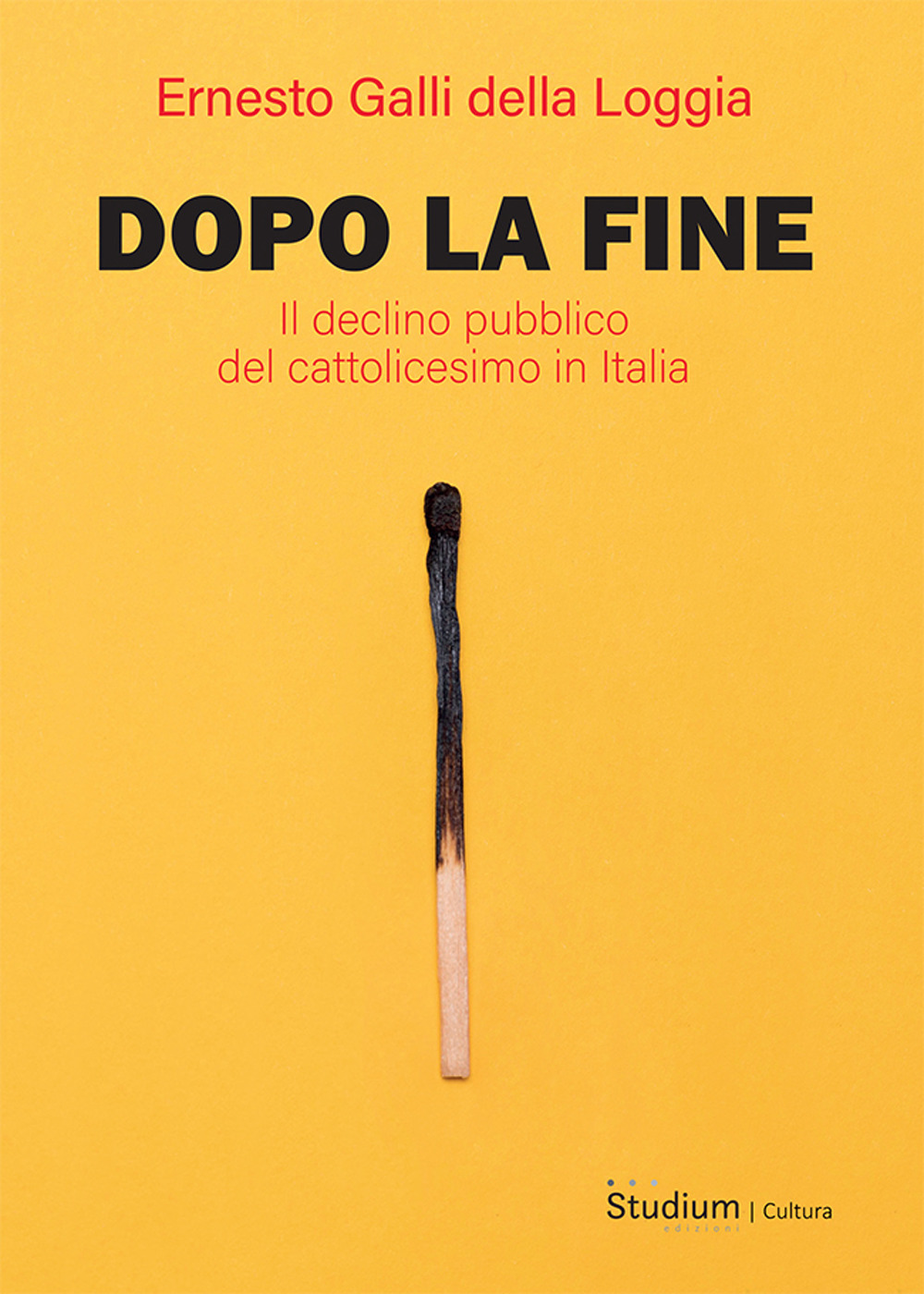
Ernesto Galli della Loggia
Dopo la fine
Il declino pubblico del cattolicesimo in Italia
Studium, 2025, pp. 192
€ 19
Parolin? Pizzaballa? Zuppi? La recente elezione del nuovo Papa, che ha visto la scelta del cardinale statunitense Prevost, ha smentito le attese di chi sperava in un pontefice italiano. È quasi da mezzo secolo, con quattro pontificati, che al soglio di Pietro non sale un membro della Chiesa cattolica italiana. Tale evento rappresenta un ulteriore segnale del ridimensionamento dell’influenza cattolica italiana nel mondo ecclesiale globale. Un tempo cuore pulsante della cristianità, l’Italia oggi assiste alla marginalizzazione della propria voce non solo nella politica nazionale, ma anche nei grandi processi decisionali della Chiesa universale. Una conferma, ancora una volta, della crisi profonda e strutturale che attraversa il cattolicesimo italiano.
Ernesto Galli della Loggia, storico e editorialista di spicco, nel suo volume “Dopo la fine. Il declino pubblico del cattolicesimo in Italia” (Studium, 2025) – dato alle stampe prima dell’elezione di Leone XIV – , riassume una diagnosi severa ma lucida della condizione attuale del cattolicesimo nella vita pubblica italiana su cui l’editorialista del Corriere insiste da circa quaranta anni, riproponendo qui una selezione di suoi scritti sul tema: trentacinque articoli dal 1988 al 2022 da cui emerge la lettura che i cattolici, un tempo protagonisti della scena politica e culturale nazionale, siano oggi relegati a una posizione di irrilevanza sia politica sia culturale.
Galli della Loggia affronta con lucidità e spirito critico il tema del progressivo smarrimento dell’influenza politica e culturale del cattolicesimo in Italia. Nell’introduzione delinea il quadro generale della sua riflessione. Il libro ruota attorno alle vicende del cattolicesimo politico italiano e della Chiesa cattolica, ma non si limita a questo: l’autore esplora anche il ruolo del cosiddetto “pensiero laico”, che ha spesso agito come antagonista o avversario del cattolicesimo. Egli stesso si definisce un “cosiddetto laico”, sottolineando come in Italia, paese di antica tradizione cattolica, esistano molteplici interpretazioni sia del laicismo sia del cattolicesimo stesso.
L’autore riconosce di essere culturalmente e spiritualmente legato al cristianesimo cattolico, pur mantenendo un rapporto critico con la Chiesa istituzionale, che giudica troppo distante dal suo ruolo storico. Secondo Galli della Loggia, la Chiesa ha abbandonato la sua missione di guida spirituale e culturale dell’Occidente, preferendo adottare un approccio “mondialista” che la avvicina a organizzazioni come le Nazioni Unite, ma che rischia di svuotarla di significato.
Anche se l’approccio da storico consente a Galli della Loggia di spaziare dagli elementi di crisi che risalgono addirittura alla Riforma protestante del XVI secolo e poi più avanti nel tempo alla “questione romana” post-unitaria, uno dei temi centrali del libro è la crisi del cattolicesimo politico a cavallo dell’inizio del nuovo millennio, dopo la fine della Democrazia Cristiana (DC), partito che per decenni ha dominato la scena politica italiana. Galli della Loggia critica la mancanza di una riflessione autocritica da parte del mondo cattolico dopo lo scioglimento della DC, avvenuto negli anni ’90 a seguito degli scandali di Tangentopoli. Mentre i post-comunisti seppero reinventarsi e mantenere un ruolo significativo nella politica italiana, i cattolici si dispersero in formazioni minori, incapaci di proporre una visione unitaria e innovativa.
L’autore attribuisce questo fallimento a due errori strategici: da un lato la scelta di schierarsi prevalentemente con il centrosinistra, abbandonando la tradizione centrista della DC – probabilmente la più significativa e storicamente valida secondo Galli della Loggia – e diventando subalterni al Partito Democratico; dall’altro l’incapacità di aprirsi a nuove culture politiche, restando chiusi in un’autoreferenzialità che li ha resi irrilevanti.
Galli della Loggia osserva come la secolarizzazione abbia trasformato l’Europa in un continente sempre più scristianizzato, mentre altre religioni, come l’islam, vivono una fase di rinvigorimento. La Chiesa cattolica, invece, sembra incapace di leggere i “segni dei tempi” e di offrire una risposta efficace a questa sfida. L’autore critica l’approccio “irenico-democratico” del post-Concilio Vaticano II, giudicato troppo ottimista e inadatto a confrontarsi con la drammaticità della realtà contemporanea.
Nonostante il tono critico, l’approccio laico e il posizionamento liberal-conservatore che contraddistinguono l’autore, Galli della Loggia auspica che il cattolicesimo non scompaia dalla scena pubblica italiana, anzi la critica sollevata nel volume mira proprio a invertire la crisi perdurante, o almeno fornire elementi utili a tale scopo. Tuttavia, affinché i cattolici tornino a contare, secondo Galli della Loggia, devono accettare di liberarsi dalla tutela della gerarchia ecclesiastica, agendo in autonomia nel campo politico e al contempo rinunciare all’ambizione di rappresentare un “mondo cattolico” unitario, accettando di essere una parte tra le altre, sia di destra che di sinistra, e collaborando con chi condivide valori compatibili.