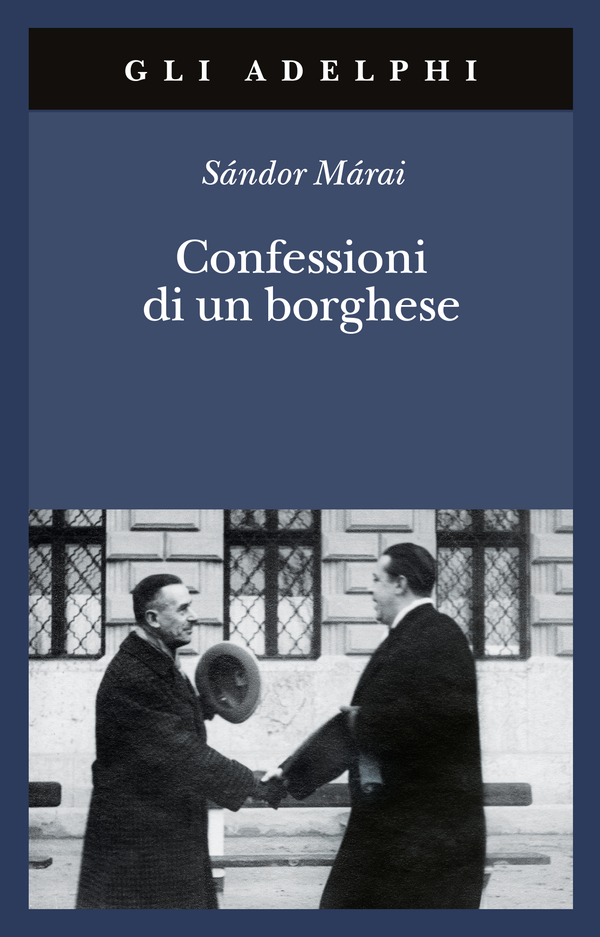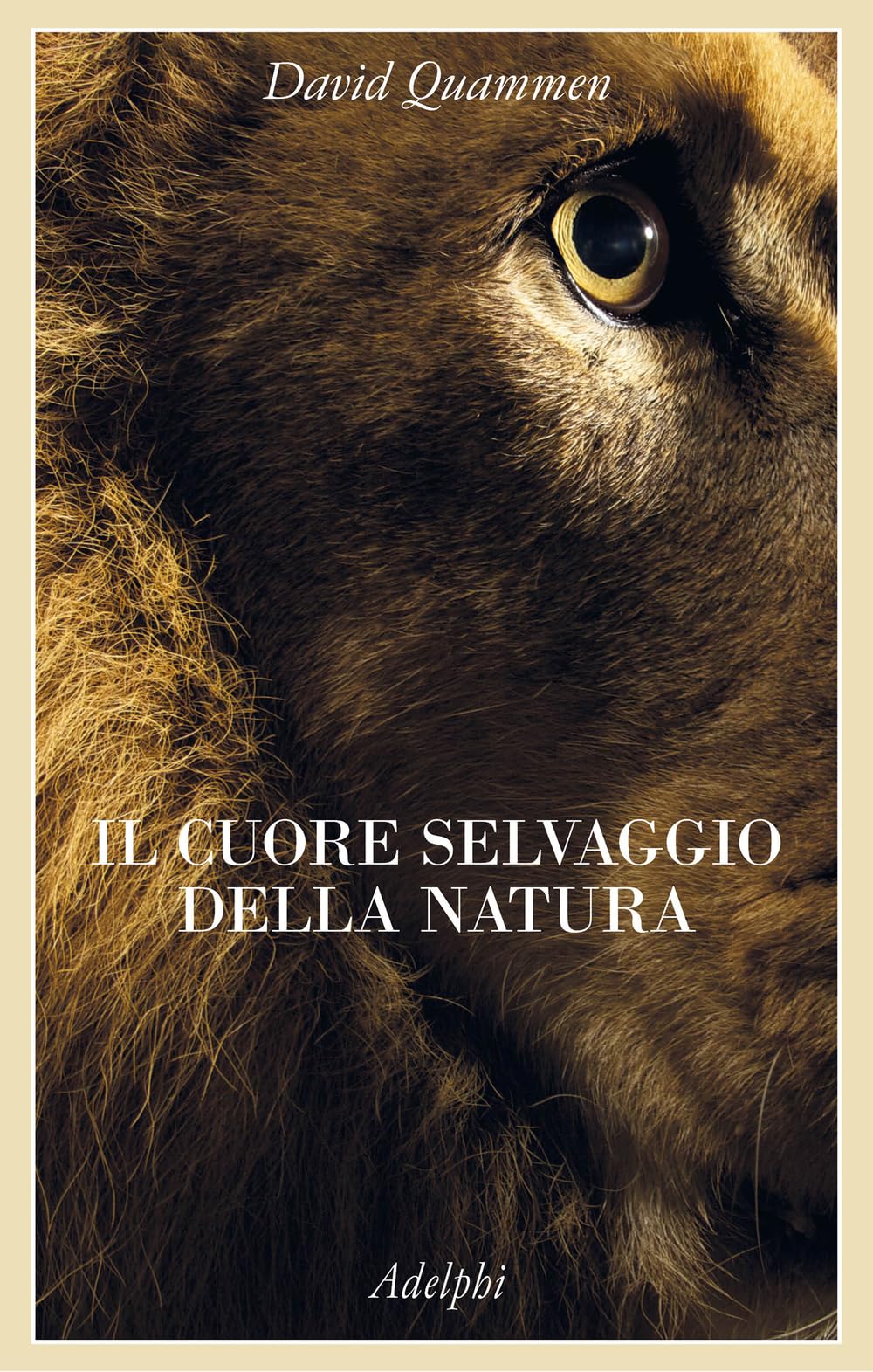Media, immagini, mondo
Dice il saggio
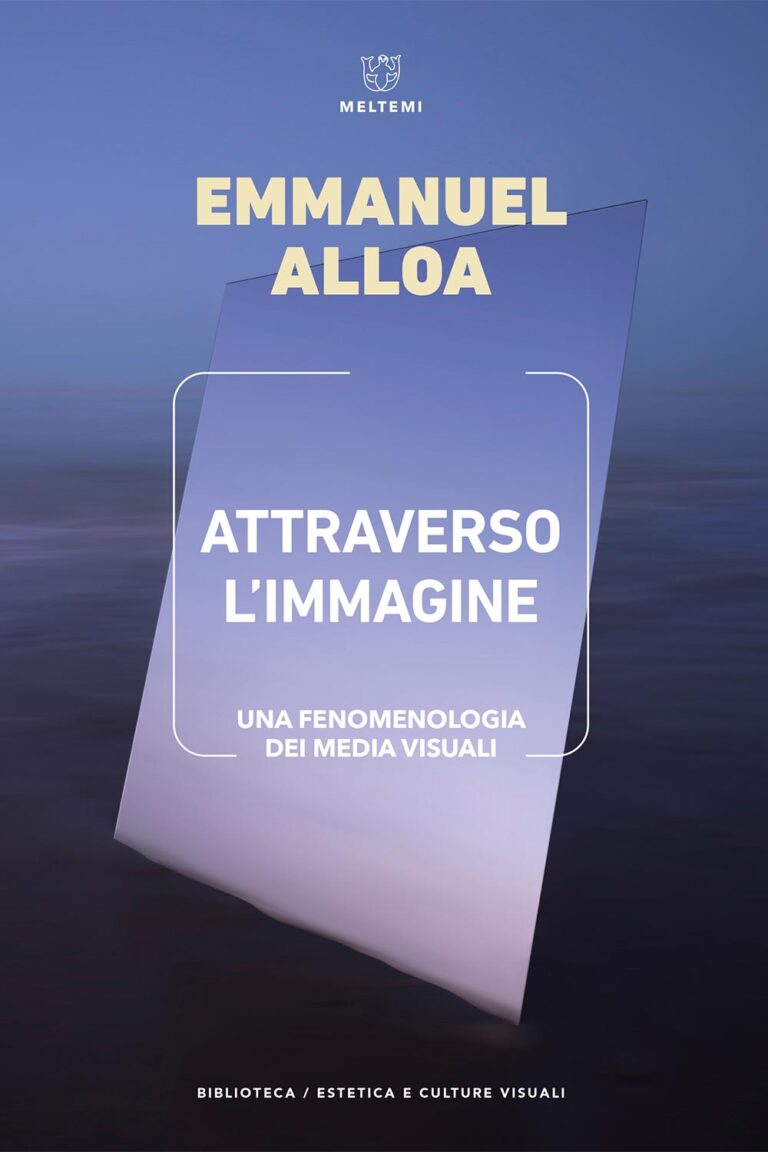
Emmanuel Alloa
Attraverso l’immagine
Una fenomenologia dei media visuali
Meltemi, 2025, pp. 522
€ 28
Attraverso l’immagine. Una fenomenologia dei media visuali di Emmanuel Alloa, pubblicato da Meltemi nel 2025, si inserisce nel filone degli studi visivi e della filosofia dell’immagine. Tradotto dall’originale tedesco del 2011 che costituiva la tesi di dottorato dell’autore, il libro offre una riflessione approfondita sulla natura delle immagini, proponendo una “fenomenologia mediale” che supera le tradizionali dicotomie tra trasparenza e opacità, tra immagine come rappresentazione e immagine come oggetto materiale.
Il volume si articola in cinque capitoli, ciascuno composto da dieci sezioni, una scelta strutturale che riflette l’origine dell’opera come tesi dottorale. Alloa conduce il lettore attraverso un percorso storico-filosofico che parte dalla Grecia antica, con Platone e Aristotele, per arrivare alla fenomenologia del Novecento di Husserl, Sartre e Merleau-Ponty, fino a proporre una teoria originale dell’iconicità.
Nei primi capitoli dedicati all’antica Grecia Alloa analizza le radici dell’iconofobia filosofica che sorge dal dibattito sull’ontologia delle immagini nella filosofia antica. Platone inaugurò una tradizione di sospetto verso le immagini, ridotte a mere copie del reale. Alloa individua qui le origini della “trasparenza” (l’immagine come finestra sul mondo) e dell’”opacità” (l’immagine come superficie materiale), paradigmi che hanno dominato il pensiero occidentale.
Con Aristotele nasce la teoria del medium: Alloa recupera la nozione aristotelica di “diafano” (il mezzo attraverso cui la luce permette la visione) come primo esempio di teoria mediale. Aristotele, a differenza di Platone, riconosce che la percezione è sempre mediata, anticipando così l’idea che le immagini non sono né pure rappresentazioni né semplici oggetti, ma “media” che strutturano la nostra esperienza visiva.
Successivamente si assiste a una progressiva marginalizzazione del concetto di diafano nella storia della filosofia, da Plotino a Berkeley, mostrando come il dibattito successivo abbia perso di vista la mediazione costitutiva della percezione, fino ad arrivare al XX secolo e all’approccio fenomenologico, analizzando come Husserl, Sartre e Merleau-Ponty abbiano affrontato il tema delle immagini. Alloa critica l’approccio eidetico di Husserl, preferendo la “fenomenologia genetica” di Merleau-Ponty, che enfatizza il ruolo attivo del corpo nella costituzione del visibile.
Il quinto capitolo, cuore del libro, presenta la proposta originale di Alloa: una “fenomenologia mediale” che concepisce le immagini come “media diafani”, né trasparenti né opachi, ma capaci di far apparire il mondo in modi altrimenti inaccessibili. Qui l’autore introduce una “sintomatologia” dell’immagine, elencando dieci caratteristiche (come “ellissi”, “cornice”, “figuralità”) che definiscono l’iconicità senza ridurla a una definizione essenzialista.
Alloa dimostra una padronanza notevole della storia della filosofia, collegando autori e periodi spesso considerati separatamente. La sua rilettura di Aristotele è particolarmente innovativa, offrendo una base teorica solida per ripensare le immagini come media. Sorprende la mancanza nella rassegna di un filosofo come Spinoza che pure ha contribuito in maniera significativa alla riflessione su come le immagini e i segni influenzino la nostra percezione e comprensione del mondo. Il libro di Alloa si pone come critica ai paradigmi filosofici dominanti smantellando efficacemente le opposizioni tradizionali (trasparenza/opacità, contenuto/forma), proponendo un approccio più sfumato che valorizza la materialità delle immagini senza ridurle a mere superfici. La proposta di una “fenomenologia mediale” rappresenta un contributo originale per gli studi visivi e per la filosofia della percezione, collocandosi nel filone di ricerca su come i media plasmino la nostra esperienza.