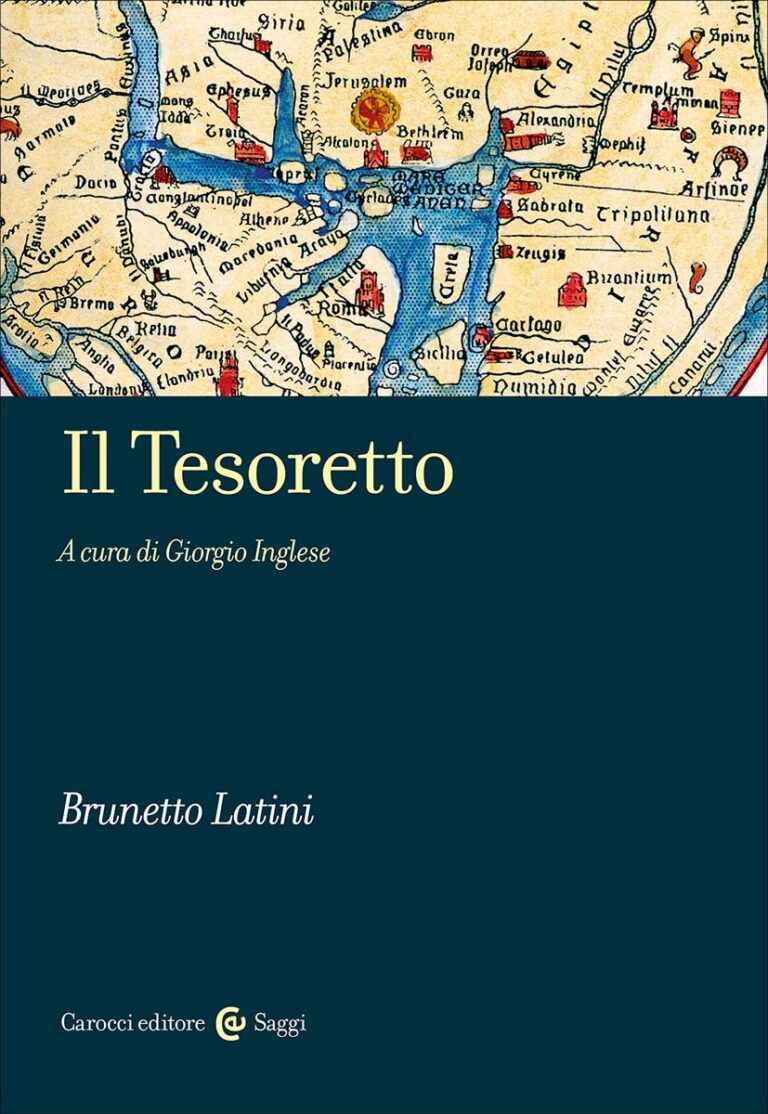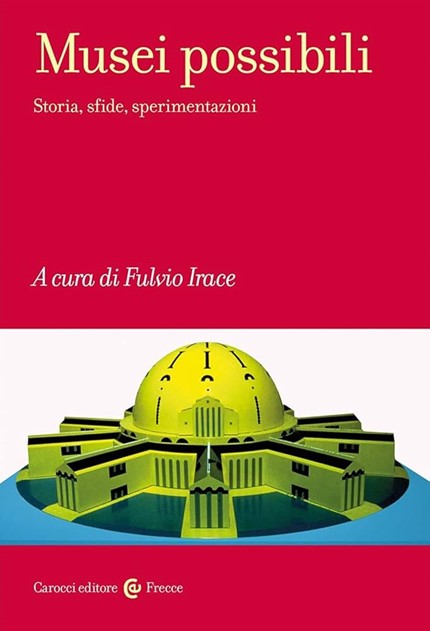Narrativa della coscienza
Dice il saggio
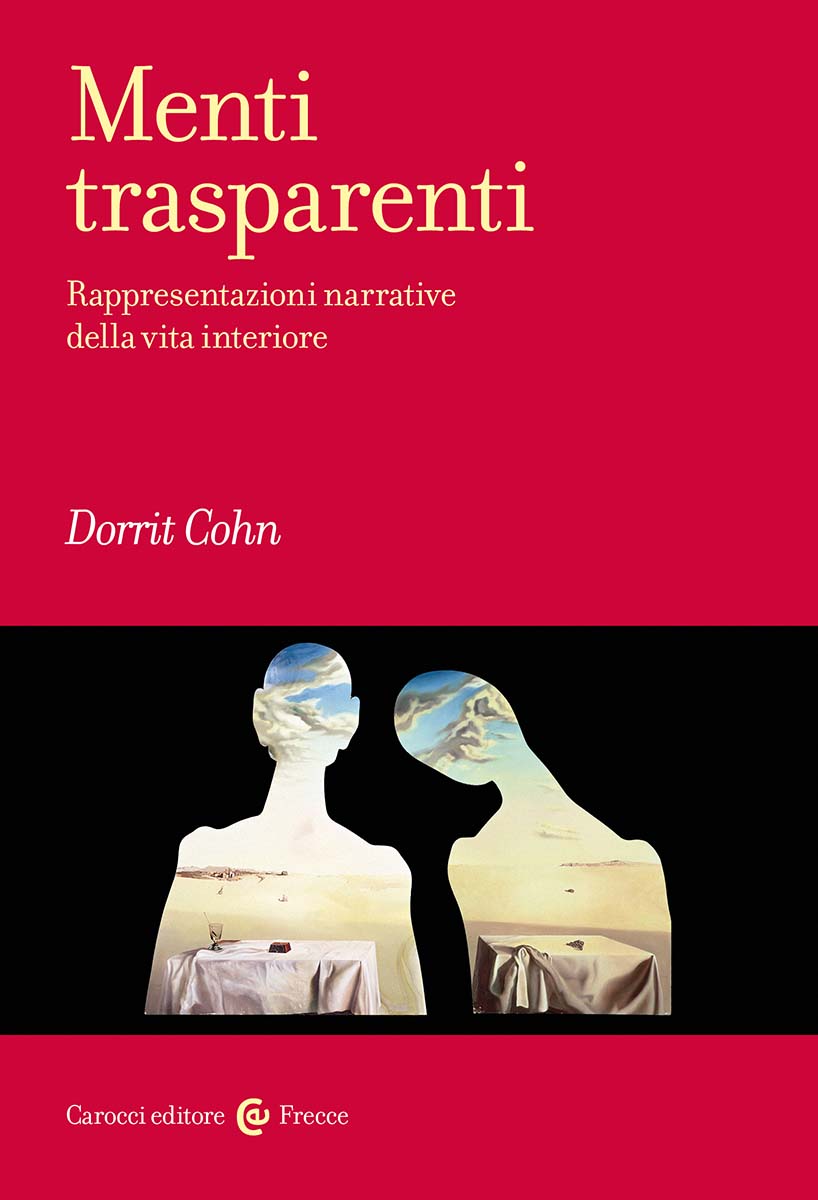
Dorrit Cohn
Menti trasparenti
Rappresentazioni narrative della vita interiore
Carrocci, 2025, pp. 336
€ 34
Con l’uscita dell’edizione italiana completa di Menti trasparenti per Carrocci (2025), si colma finalmente una lacuna che durava da quasi cinquant’anni. Pubblicato per la prima volta nel 1978, Transparent Minds di Dorrit Cohn è uno dei capisaldi della narratologia novecentesca, un’opera che, pur considerata tra le più influenti nel campo degli studi narrativi a livello internazionale, era rimasta finora conosciuta in Italia solo in forma frammentaria. Grazie alla traduzione integrale, il pubblico italiano può ora apprezzare un lavoro che non ha soltanto sistematizzato le tecniche della rappresentazione della coscienza nella narrativa, ma ha anche influenzato profondamente il modo in cui studiamo, leggiamo e interpretiamo i romanzi moderni.
Dorrit Cohn (1924–2012) è stata una delle più importanti studiose della narratologia del XX secolo. Nata a Vienna, emigrò negli Stati Uniti poco prima dell’Anschluss nazista, laureandosi a Radcliffe College e poi a Stanford, dove conseguì il dottorato in letteratura tedesca. Dopo aver insegnato a lungo presso l’Università di Harvard come una delle prime donne ad ottenere una cattedra nella Faculty of Arts and Sciences, si dedicò allo studio comparato della narrativa europea e americana, intrecciando germanistica, studi narratologici e interesse per Freud e la teoria della finzione. Tra i suoi lavori più noti, oltre a Menti trasparenti, ricordiamo The Sleepwalkers (1966) su Hermann Broch e The Distinction of Fiction (1999).
Cohn dialoga costantemente con grandi nomi come Gérard Genette e Franz Stanzel, ma, come osserva giustamente Riccardo Castellana nella presentazione all’edizione Carrocci, senza aver mai goduto della stessa notorietà, almeno fino a tempi recenti. Il suo approccio, rigoroso ma anche estremamente chiaro, si distingue per la capacità di coniugare analisi formale e sensibilità interpretativa, rendendo Menti trasparenti un’opera tanto tecnica quanto appassionante.
Menti trasparenti si propone di indagare l’intero spettro delle tecniche narrative utilizzate per rappresentare la coscienza dei personaggi, ponendosi come una risposta alle questioni fondamentali che attraversano tutta la storia del romanzo: come rendere visibile l’invisibile? Come raccontare ciò che, per sua natura, sfugge alla percezione esterna?
Cohn classifica in modo preciso le principali strategie adottate dai narratori, distinguendo tre modalità in terza persona. Nella psiconarrazione il narratore racconta i pensieri del personaggio, spesso interpretandoli o condensandoli; con il monologo citato i pensieri sono riportati direttamente, senza mediazione narrativa; nel monologo narrato, un misto dei due, la voce narrativa assume le cadenze e i colori della coscienza del personaggio.
A queste si aggiungono, nella seconda parte del libro, le modalità proprie della narrazione in prima persona, tra cui l’autonarrazione, il monologo autocitato e il monologo autonomo, culminando nell’analisi di esperienze letterarie estreme come il celebre monologo di Molly Bloom in Ulysses di James Joyce.
Attraverso esempi tratti da Austen, Dostoevskij, Mann, Kafka, Joyce, Woolf e Proust, l’autrice dimostra come il romanzo moderno si sia progressivamente emancipato dalla semplice rappresentazione esterna dei comportamenti per avventurarsi nei territori più fluidi e complessi della soggettività.
Uno dei meriti maggiori di Menti trasparenti è la chiarezza metodologica. A differenza di altri studiosi che rischiano di perdersi in un lessico ipertecnico, Cohn coniuga precisione teorica e comprensibilità, costruendo una vera tipologia delle tecniche narrative della coscienza.
La mancata traduzione italiana fino ad oggi aveva contribuito a una sottovalutazione dell’opera di Cohn in Italia, diversamente da quanto avvenuto in Francia, dove il volume (La Transparence intérieure) circolava già dagli anni Ottanta, influenzando pensatori come Paul Ricœur.
Questa nuova edizione Carrocci — tradotta con cura e accompagnata da una prefazione di Riccardo Castellana e una postfazione di Gloria Scarfone — è tanto più significativa perché presenta finalmente il testo nella sua interezza. Non solo i celebri capitoli sui modi di rappresentare la coscienza, ma anche la riflessione conclusiva sul rapporto tra narrazione, teatro e lirica, dove Cohn individua nella narrativa moderna la capacità unica di “mostrare” il pensiero senza interruzioni o distorsioni.