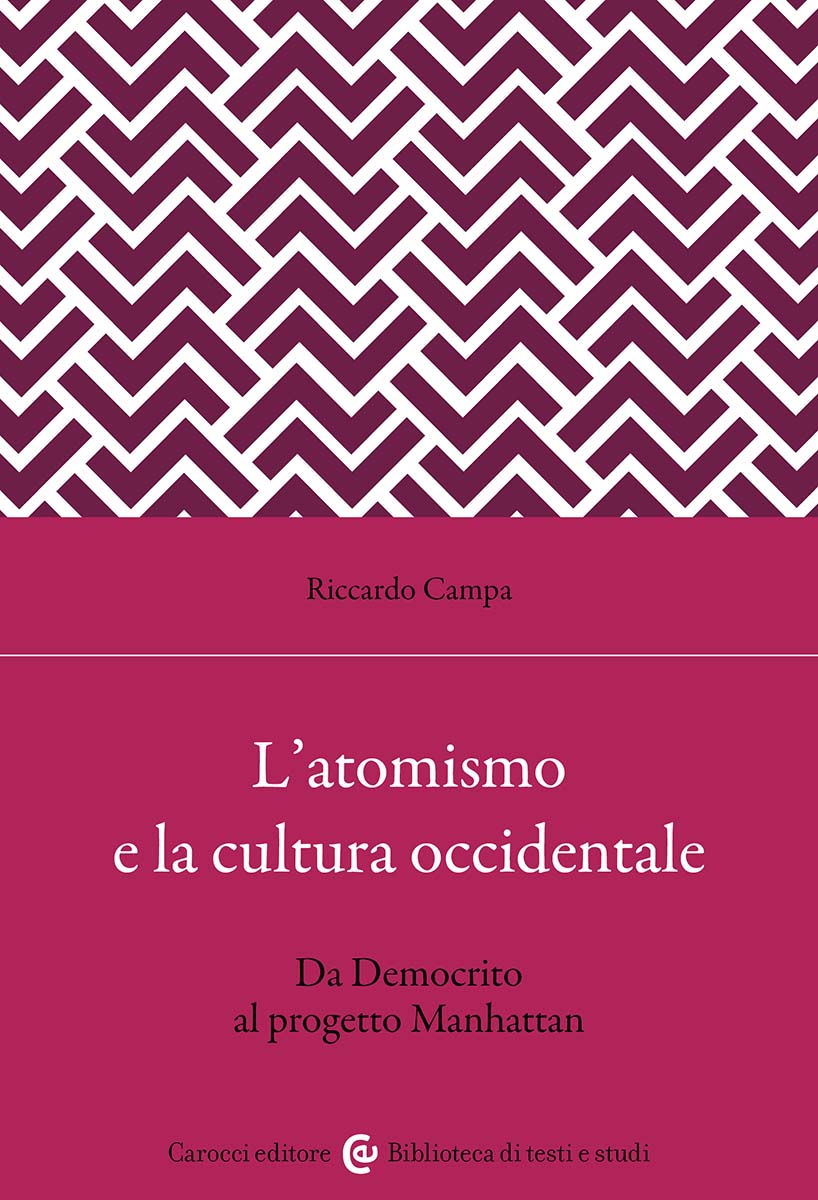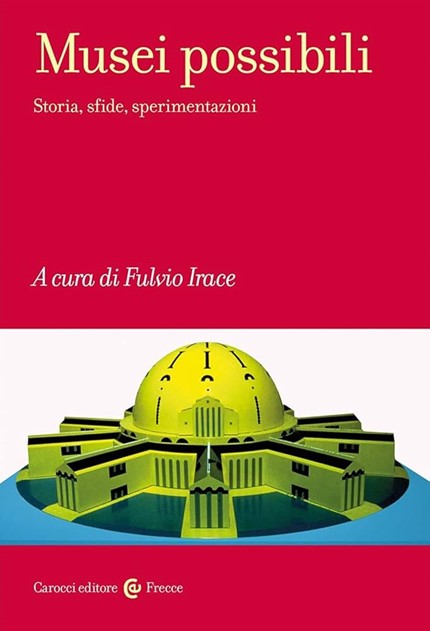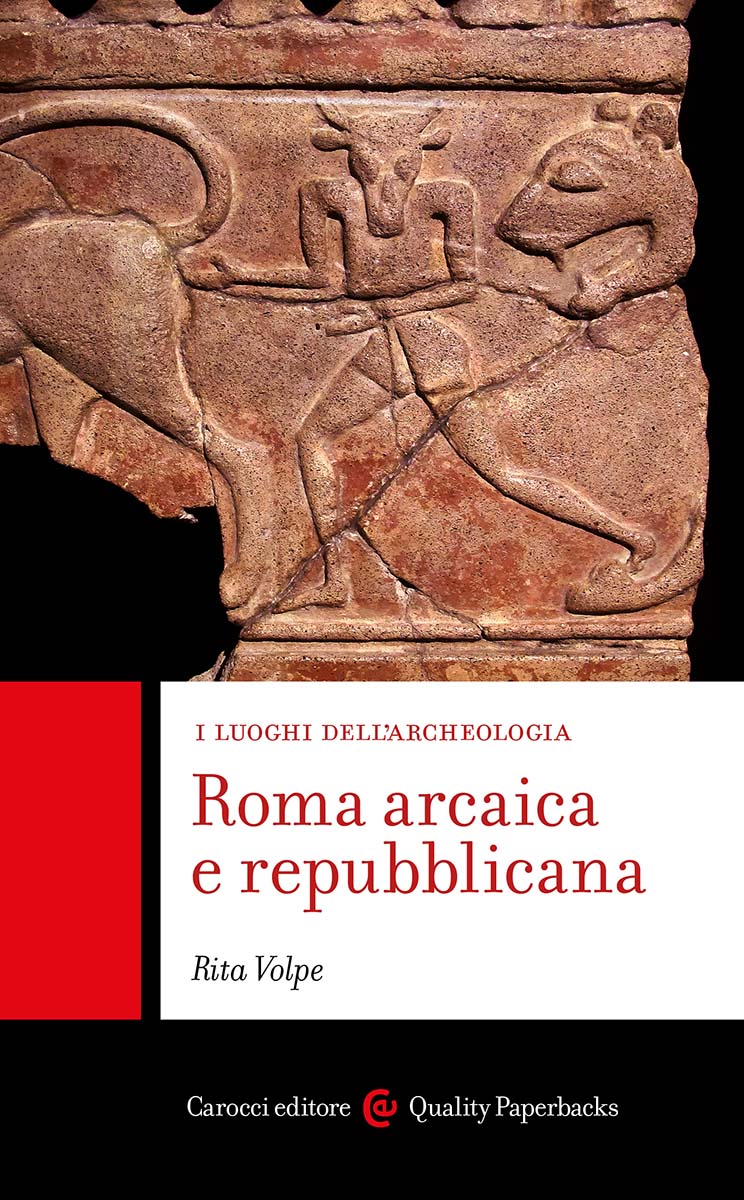Il Messere di Filosofia, di Poesia e di Visioni
Classici
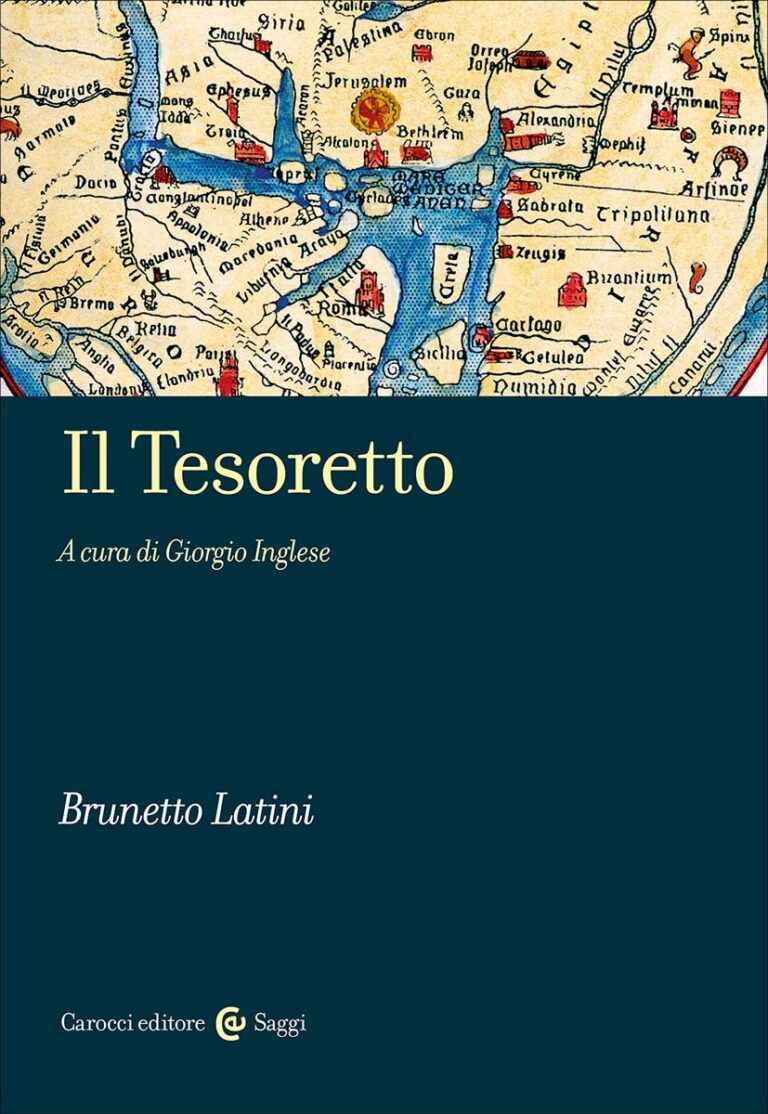
Brunetto Latini
Il Tesoretto
a cura di Giorgio Inglese
Carocci Editore, 2024, pp.204
€ 21
Tra gli intellettuali che intesero cercare l’Immenso della Conoscenza in ambito medievale la figura di Ser Brunetto Latini assume un ruolo fondamentale per chi voglia saperne di più e meglio. L’autore, Giorgio Inglese, docente di Letteratura Italiana all’Università “La Sapienza” di Roma e noto dantista, dà vita ad un’attenta ricostruzione filologica del testo del guelfo fiorentino, un’edizione critica corredata da chiare notazioni e introdotta da una meticolosa biografia nella quale è possibile rintracciare ogni irrisolto/irrisolvibile dubbio circa la vita e l’opera dell’autore del Tesoretto, opera incompiuta ma che nei suoi 2944 settenari concede al lettore di entrare nel complesso universo medievale del Visionario Allegorico poi magnificato dalla Commedia di Dante, che volle con fermezza chiamare “Maestro” il protagonista del suo sonetto “Messer Brunetto”, pur ponendolo per “divina giustizia” nel XV canto dell’Inferno quale sodomita “violento contro la Natura”; come ben sappiamo nulla di superiore al parere del Dio inflessibile, come nei passi dedicati con passione a Paolo e Francesca, Ulisse, Farinata degli Uberti, Pier Della Vigna, Cavalcante dei Cavalcanti, il Conte Ugolino ed altri.
Il “grande e savio”, particolarmente impegnato nella vita pubblica, fu guida di chiunque avesse voluto accostarsi alla Retorica e compose il “Livres dou tresor” in Francia e nel relativo patois riconoscendone il ruolo di lingua internazionale, testo poi tradotto in Castigliano, Catalano, Latino, Siciliano e Volgare Toscano. Egli intese produrre una sorta d’Enciclopedia sul modello di quella, preziosa, di Isidoro di Siviglia e di quella di Vincenzo di Beauvais, strutturando il testo secondo tre “libri” (teologia, creazione del mondo, geografia e animali; vizi e virtù, Logica e Morale; insegnamenti sul parlare e sul “come si deve governare la gente”, con osservazioni poi riprese da Niccolò Machiavelli).
Nonostante l’opera s’interrompa alquanto bruscamente, Inglese afferma acutamente come “il Tesoretto non possa considerarsi opera incompiuta… semmai frutto di una scrittura veloce, forse episodica”, senza dubbio ispiratrice della Commedia dantesca, sia “per il taglio narrativo-allegorico” che per l’Alfa dello “smarrimento del gran cammino” sia per l’Omega dell’ascesa “sull’Olimpo Tolomeo” secondo quello stile borghese che rese “gentile” il fare ed il dire del ceto cavalleresco, invitato a moderare “ardore e violenza, promuovendo l’autocontrollo e la prudenza”.
Nell’opera il Tutto appare legato al Tutto, secondo una mentalità tipicamente prerinascimentale (quanto ne ebbe Baudelaire nelle sue “Corrispondenze”?), rivelata da un Viaggio che, non sorretto dall’entusiasmo della Fede dantesca, non giunge alla somma contemplazione dell’«Amor che move il Sole e l’altre stelle» e si ferma all’incontro con l’astronomo greco Tolomeo, “mastro di storlomia e di filosofia”. Non è dato sapere come il Latini avrebbe potuto concludere, ma poco importa poiché, se immaginare può esser lecito, davvero toglierebbe il fascino dell’Enigma ad un’epoca nella quale il Mistero fu elemento centrale dell’Immaginazione, del Pathos e del “popolare dionisiaco” in una proiezione nel Futuro ancora di grande attualità.