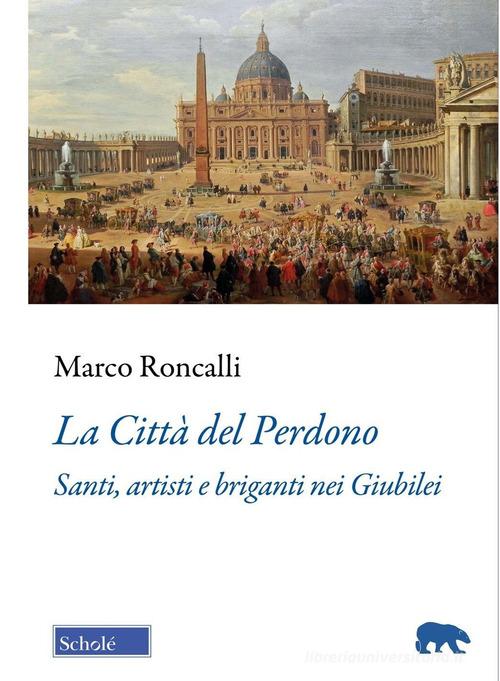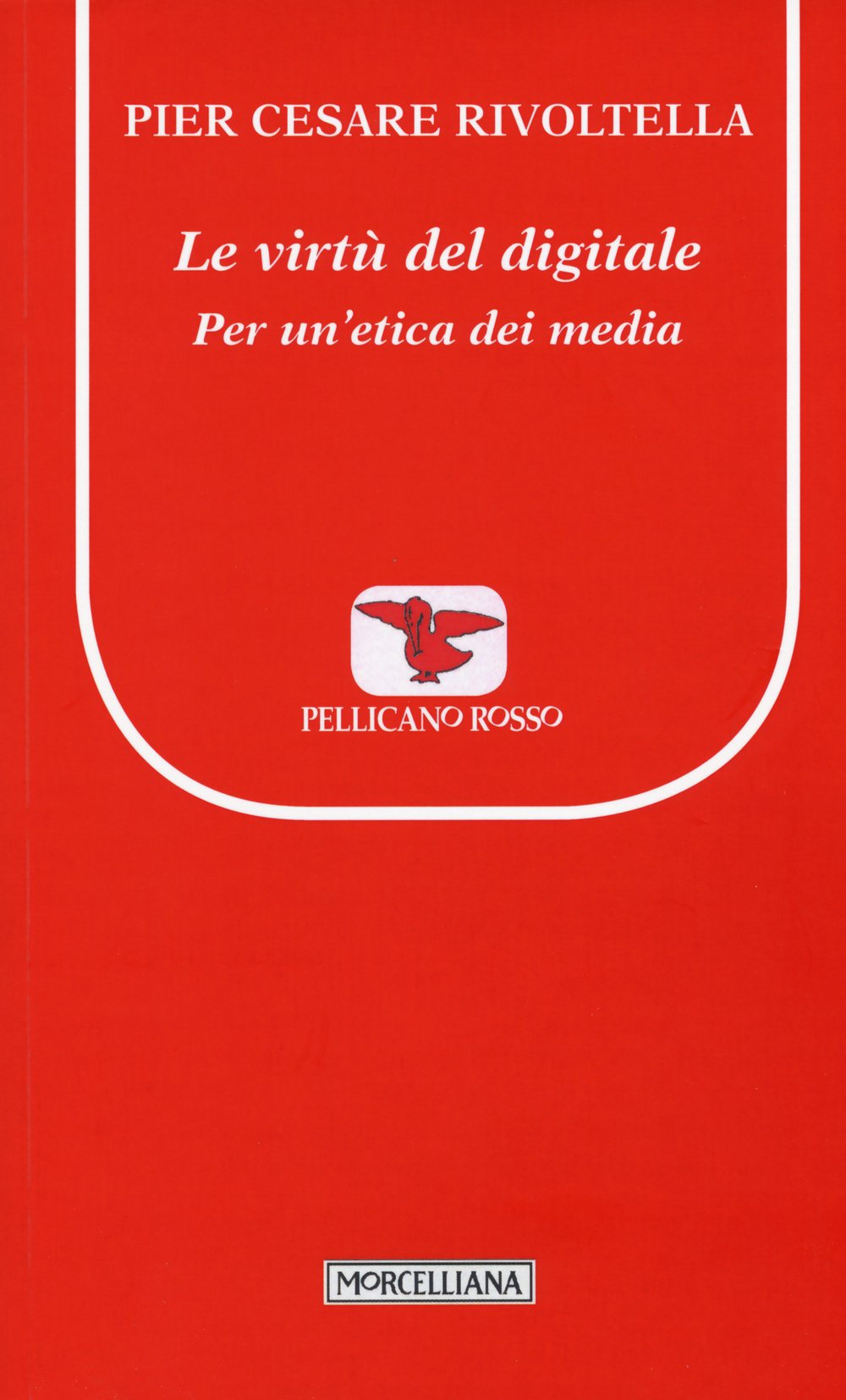Fare i conti con i miracoli
Dice il saggio
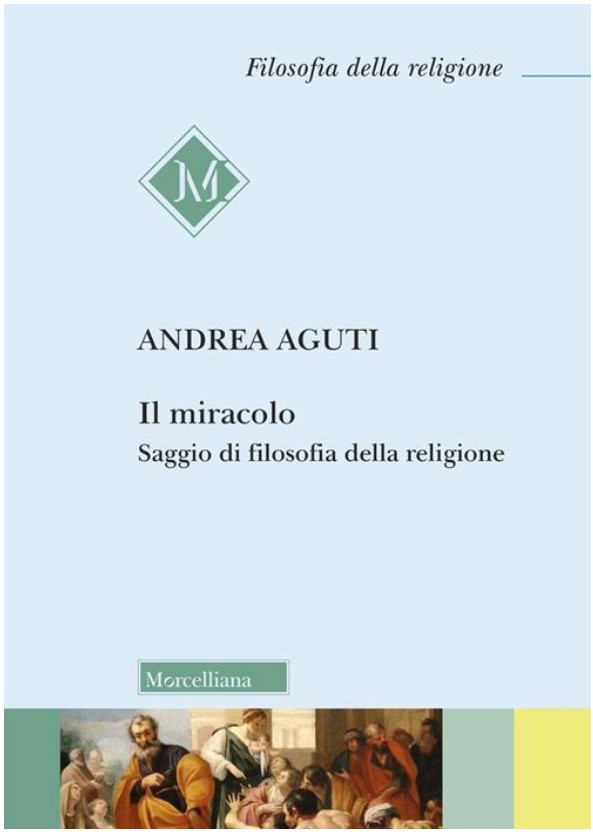
Andrea Aguti
Il miracolo
Saggio di filosofia della religione
Morcelliana, 2025, pp. 224
€ 20
Andrea Aguti, professore ordinario di Filosofia morale all’Università di Urbino Carlo Bo e autore di numerosi saggi tra cui “Morale e religione. Per una visione teistica” (2021) e “Filosofia della religione. Storia, temi, problemi” (2022), affronta nel suo ultimo lavoro un tema tanto spinoso quanto affascinante: il miracolo. Pubblicato da Morcelliana nel 2025, questo saggio di 224 pagine rappresenta un contributo al dibattito filosofico-teologico contemporaneo, riportando al centro della discussione un argomento che molti consideravano ormai superato o imbarazzante. Aguti dimostra invece come il miracolo continui a porre interrogativi fondamentali che toccano il cuore stesso del rapporto tra fede e ragione, tra scienza e religione, tra natura e soprannaturale.
Il libro si apre con una constatazione tanto semplice quanto provocatoria: il miracolo è diventato un tabù intellettuale. Da un lato i filosofi, soprattutto dopo l’illuminismo e le critiche di Hume, hanno cercato di liquidarlo come superstizione o impossibilità logica; dall’altro i teologi, timorosi di apparire retrogradi o antiscientifici, lo hanno progressivamente marginalizzato. Eppure, come nota Aguti, il miracolo rimane un elemento centrale nell’esperienza religiosa di milioni di persone e continua a sollevare questioni filosofiche ineludibili. Qual è il suo vero significato religioso? Come distinguerlo da fenomeni come la magia o il paranormale? Quale valore attribuire alle testimonianze miracolose? E soprattutto: come conciliare l’idea di un Dio che interviene nel mondo sospendendo quelle stesse leggi naturali che avrebbe lui stesso stabilito?
L’autore sviluppa la sua analisi attraverso un percorso articolato che combina approccio storico e riflessione sistematica. Nella prima parte del volume, Aguti ricostruisce l’evoluzione del concetto di miracolo nel pensiero occidentale, a partire dal teismo classico di Agostino e Tommaso d’Aquino. Per questi autori, il miracolo non rappresenta una contraddizione dell’ordine naturale, ma piuttosto la sua trascendenza: Dio agisce “oltre” la natura, mostrando così la sua libertà e sovranità. Tommaso in particolare distingue tra miracoli “supra naturam” (che superano le capacità della natura), “contra naturam” (che producono effetti contrari alle tendenze naturali) e “praeter naturam” (che agiscono al di fuori dei normali processi naturali), una classificazione che Aguti riprende e attualizza nel dibattito contemporaneo.
La svolta critica avviene con la modernità, quando pensatori come Spinoza e Hume pongono le basi per una decostruzione razionalista del miracolo. Spinoza lo considera un’assurdità ontologica, poiché le leggi di natura riflettono gli immutabili decreti divini; Hume invece lo attacca su un piano epistemologico, sostenendo che nessuna testimonianza potrebbe mai rendere credibile un evento che viola le regolarità naturali confermate da innumerevoli osservazioni. Aguti analizza l’argomento humeano, mostrando come la stessa nozione di “legge di natura” sia problematica: se intesa come semplice generalizzazione induttiva, lascia spazio a possibili eccezioni; se concepita come necessità metafisica, rischia di diventare dogmatica. L’autore dedica particolare attenzione alle reazioni dell’apologetica cattolica a queste critiche, esaminando autori come Blaise Pascal, Maurice Blondel e Romano Guardini, e mostrando come il miracolo sia stato progressivamente emarginato nella teologia fondamentale contemporanea.
Nella seconda parte del libro, Aguti passa a una discussione delle questioni filosofiche sollevate dal miracolo. Uno dei punti più interessanti riguarda la definizione stessa di miracolo come “violazione delle leggi di natura”. L’autore prende in esame le posizioni di filosofi contemporanei come Richard Swinburne, che difende questa concezione tradizionale, e le obiezioni di pensatori come John Mackie e David Basinger, secondo i quali non potremmo mai essere certi di trovarci di fronte a una vera violazione delle leggi naturali anziché a un fenomeno ancora inspiegato. Aguti critica anche le alternative proposte da autori come Clive S. Lewis e Robert Larmer, che cercano di concepire il miracolo come un’aggiunta alla natura piuttosto che una violazione, dimostrando come queste soluzioni finiscano comunque per implicare una qualche forma di interferenza con le leggi naturali.
Particolarmente stimolante è la discussione sul valore apologetico del miracolo. Aguti sostiene che, contrariamente a quanto affermano molti teologi moderni, il miracolo può ancora svolgere una funzione importante come “segno” che invita alla riflessione e alla fede, senza per questo volersi imporre come prova coercitiva. L’autore esamina il problema della testimonianza miracolosa, riconoscendone i limiti ma anche la possibile validità in contesti appropriati, e affronta l’obiezione morale: se Dio è onnipotente e infinitamente buono, perché interviene solo in casi eccezionali, lasciando che la maggior parte del male nel mondo rimanga senza risposta? La risposta di Aguti, ispirata alla tradizione tomista, insiste sulla misteriosità dei disegni divini e sulla differenza tra la prospettiva limitata dell’uomo e quella onnicomprensiva di Dio.
Aguti tiene insieme approcci filosofici diversi, dal metodo analitico alla fenomenologia, mostrando come il tema del miracolo richieda una riflessione pluridisciplinare. L’autore dialoga con autori classici come Kant e Leibniz, ma anche con pensatori contemporanei come Alvin Plantinga e William Lane Craig, dimostrando una padronanza della letteratura internazionale. Al tempo stesso, il libro non cade in un tecnicismo eccessivo, mantenendo chiaro il filo del discorso e il legame con le questioni fondamentali che rendono il miracolo un problema filosofico vivo e attuale.
Un limite del lavoro di Aguti lo si può forse attribuire a una certa focalizzazione sul contesto cristiano, con relativamente poco spazio dedicato al miracolo in altre tradizioni religiose. Inoltre, alcune delle soluzioni proposte da Aguti, specialmente riguardo al problema morale del miracolo, potrebbero apparire troppo legate a presupposti teistici per convincere un lettore scettico.
Nel complesso, tuttavia, Andrea Aguti dimostra che il miracolo, lungi dall’essere un residuo superstizioso del passato, continua a porre domande radicali sulla natura della realtà, sui limiti della conoscenza scientifica e sul rapporto tra Dio e il mondo. Scritto con chiarezza e rigore, ricco di riferimenti bibliografici e di analisi penetranti, il libro si rivolge non solo a filosofi e teologi, ma a chiunque sia interessato a comprendere una delle questioni più affascinanti e dibattute nel dialogo tra fede e ragione: il miracolo come invito a pensare, come segno che non si impone alla ragione ma la stimola a interrogarsi sul mistero ultimo della realtà.