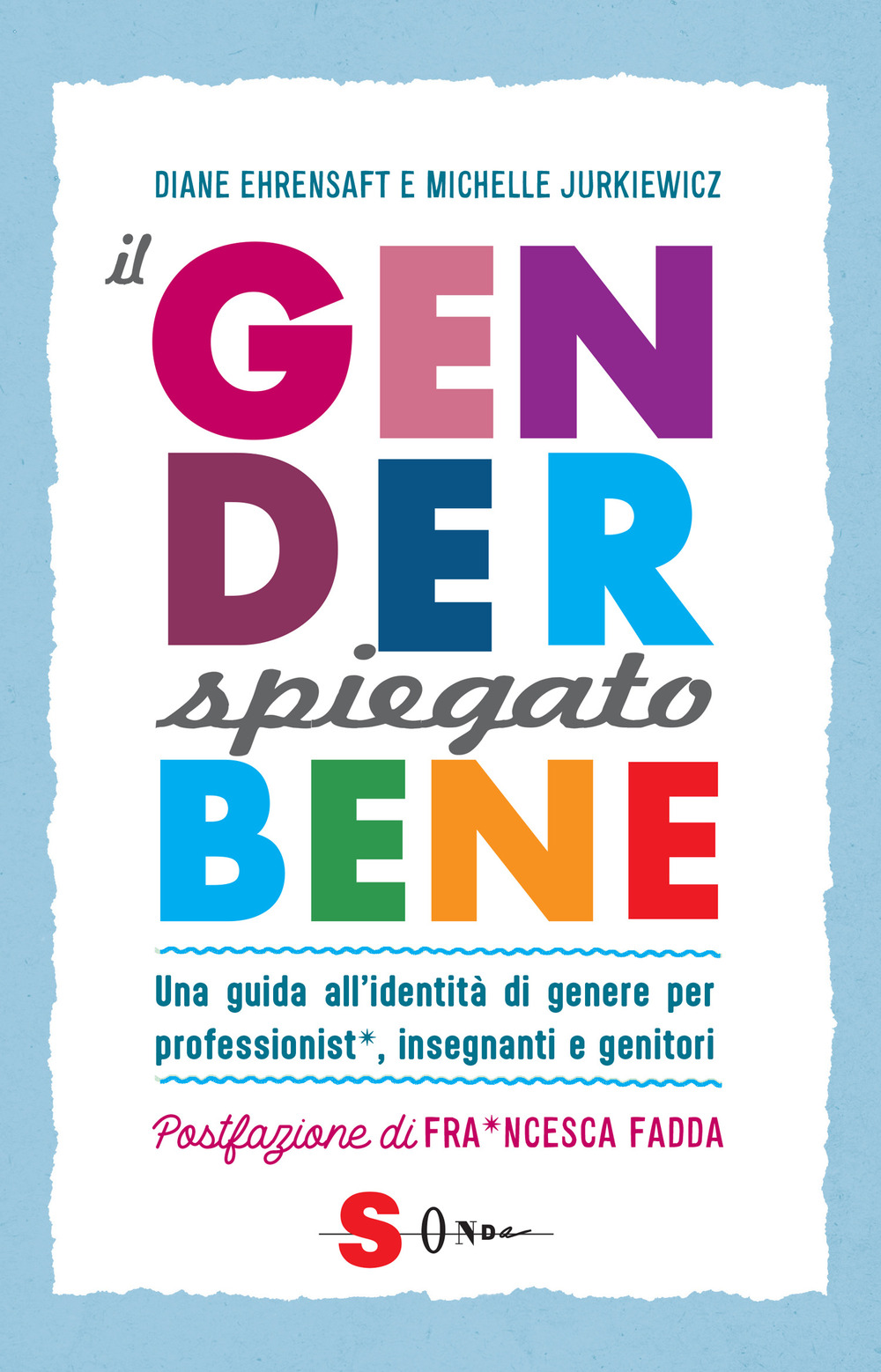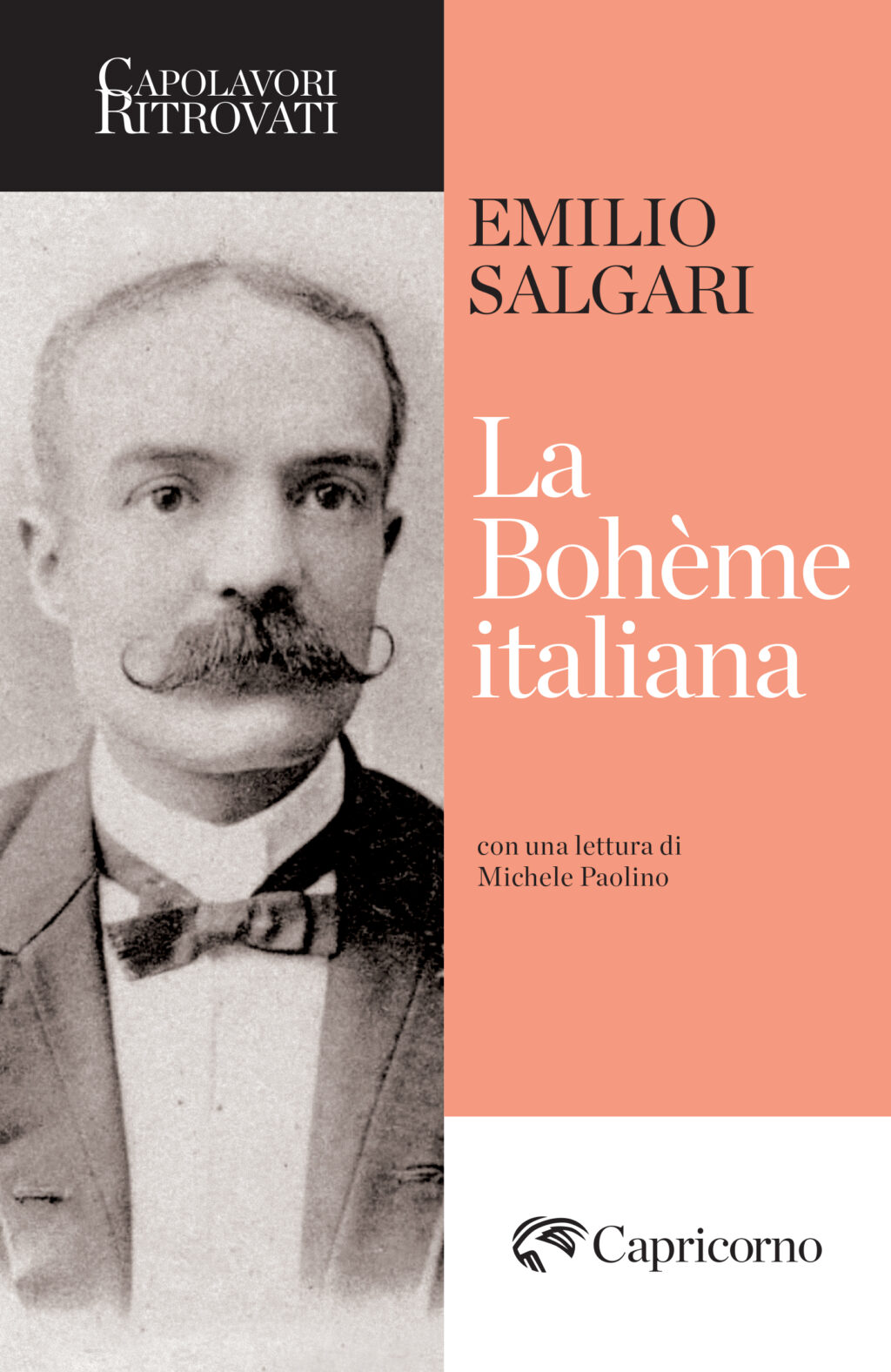L’humus della Repubblica
Storia
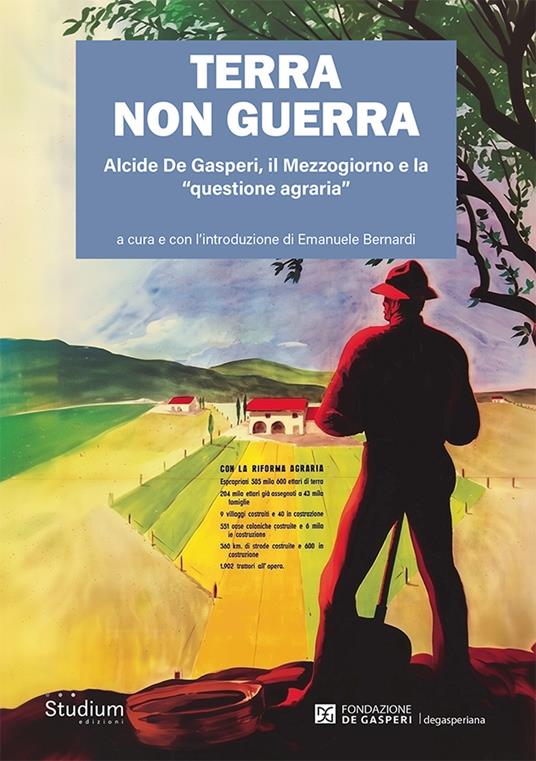
Alcide De Gasperi
Terra non guerra
Alcide De Gasperi, il Mezzogiorno e la “questione agraria”
a cura e con l’introduzione di Emanuele Bernardi
Studium, 2025, pp. 192
€ 19
Nel volume Terra non guerra. Alcide De Gasperi, il Mezzogiorno e la “questione agraria”, curato da Emanuele Bernardi per i tipi di Studium (collana “Degasperiana” della Fondazione Alcide De Gasperi), emerge una figura di De Gasperi tutt’altro che cristallizzata in formule storiografiche convenzionali. I testi qui raccolti – una selezione di discorsi e messaggi datati tra il 1946 e il 1954, alcuni editi, altri finora inediti – restituiscono l’immagine di uno statista capace di coniugare idealismo e pragmatismo, profondamente radicato nella propria esperienza personale e culturale e allo stesso tempo proiettato su uno scenario globale, attento alle trasformazioni del dopoguerra, al ruolo geopolitico dell’Italia e al futuro dell’Europa.
Il titolo del libro, Terra non guerra, racchiude con efficacia la tensione etica e politica che attraversa questi testi: in un’Italia alle prese con la ricostruzione e con le pressioni del riarmo imposte dal contesto della guerra fredda, De Gasperi sceglie la via delle riforme strutturali, concentrandosi sul tema della terra come spazio di coesione sociale e occasione di rinnovamento economico e civile. A guidarlo è la convinzione che la modernizzazione dell’agricoltura e lo sviluppo del Mezzogiorno rappresentino non solo una priorità economica, ma anche un cardine dell’equilibrio democratico e della pacificazione nazionale.
Attraverso le parole di De Gasperi si snoda un pensiero che rifugge ogni rigida classificazione ideologica. Né conservatore né rivoluzionario, il leader democristiano si presenta piuttosto come un uomo del limite: dei limiti ambientali, economici e sociali da riconoscere e gestire; dei limiti della tecnica senza l’etica; dei limiti dell’interclassismo senza giustizia sociale. A emergere è una concezione della democrazia come pratica dell’equilibrio difficile, fondata su un’idea di sviluppo compatibile con la stabilità, la legalità fiscale, la coesione nazionale e la dignità del lavoro. La sua visione economica – spesso liquidata come priva di sistematicità – mostra invece una chiara coerenza: una forma di “economia mista” fondata sull’adattamento ai contesti, sulla sinergia tra pubblico e privato, sullo Stato come garante degli investimenti e della solidarietà tra le aree del Paese.
Particolarmente rilevante è l’attenzione riservata al Mezzogiorno. Le visite nelle regioni meridionali, i discorsi tenuti in occasione di gravi crisi come quella di Melissa, le parole spese per la riforma agraria e per la Cassa per il Mezzogiorno delineano una strategia organica, che cerca nel radicamento contadino e nella piccola proprietà un argine alla deriva collettivistica e al tempo stesso una base per la rinascita nazionale. In queste pagine, la “questione meridionale” non è mai affrontata come un’emergenza da tamponare, bensì come una sfida strutturale che richiede politiche pluriennali, strumenti innovativi (come gli investimenti pubblici di lungo periodo), alleanze larghe, apertura all’Europa e all’America, ma anche un’etica del servizio che coinvolga cittadini, istituzioni e corpi intermedi.
Bernardi, nella sua introduzione, suggerisce di rinunciare a interpretare De Gasperi in una prospettiva meramente agiografica o oppositiva. Ne coglie invece la complessità, evitando la trappola delle etichette: De Gasperi non è solo “liberale” o “cristiano sociale”, ma incarna un pensiero della mediazione e della gradualità, nutrito da una profonda cultura contadina, dal rispetto per l’ambiente e per le diversità territoriali, da una costante ricerca di equilibrio tra le ragioni dell’efficienza e quelle della giustizia.
Il linguaggio dei discorsi è attraversato da immagini e metafore rurali, espressione non solo di un retroterra biografico – la Trento natia, la montagna, l’umiltà del lavoro agricolo – ma anche di una visione filosofica della democrazia che affonda le sue radici nell’“humus” della civiltà romana e cristiana. Il riferimento a Raffaello, alla FAO, a David Lubin, alla cooperazione tecnica internazionale, testimonia inoltre una sorprendente capacità di collegare la dimensione agricola a quella artistica e geopolitica, allargando il campo semantico della terra fino a farne una categoria strategica della ricostruzione morale ed economica dell’Italia repubblicana.
Il volume si segnala anche per l’attenzione riservata al contesto storico: la dialettica tra De Gasperi e le sinistre, ma anche con la destra post-fascista; l’uso del termine “guerra fredda” nel 1950; il ruolo del Piano Marshall e delle riforme agrarie come strumenti di una guerra a bassa intensità combattuta con i mezzi della politica, della propaganda e della giustizia sociale; il tentativo di costruire una democrazia centrata, aperta alla collaborazione tra tendenze diverse, ma ferma nei suoi valori costituzionali. Tutto ciò mostra un De Gasperi profondamente immerso nel suo tempo, ma anche capace di guardare oltre, verso un’Europa unita e un’Italia moderna.
Terra non guerra invita a ripensare la figura di Alcide De Gasperi al di là degli stereotipi, a leggere la sua politica come un’azione di cucitura e di progetto, in cui l’amore per la terra si intreccia con il senso dello Stato, la concretezza amministrativa con la passione etica, la conoscenza dei bisogni popolari con la tensione all’universalità. Un De Gasperi, in definitiva, da rileggere non solo come padre della Repubblica, ma come punto di riferimento per un’idea di politica che sappia ancora oggi coniugare realismo e speranza.