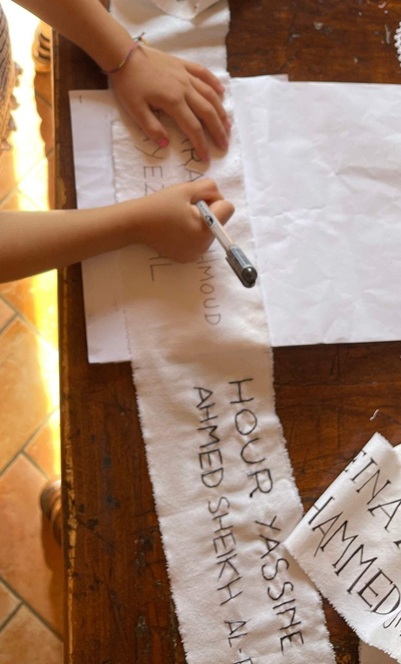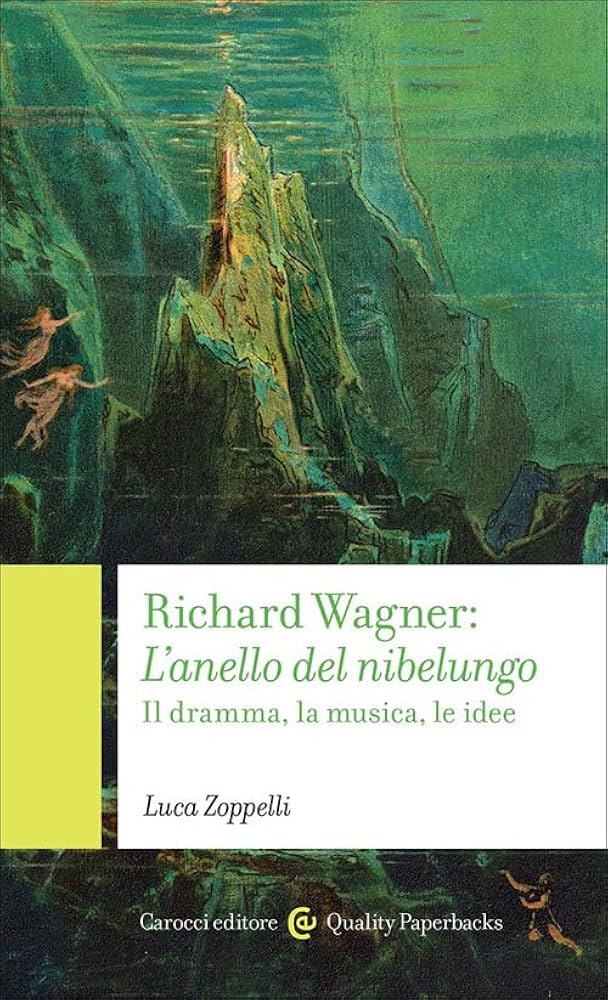Flashback – La terra

Volendosi fermare alla pura sinossi, La terra (Zemlja, 1930), capolavoro di Aleksandr Dovžénko, rientra nella categoria dei film di propaganda, prodotti a centinaia nell’ambito di quella che Lenin definì l’arte più importante, indispensabile per la sua natura visiva a trasmettere i principi rivoluzionari a una platea di analfabeti. Racconta infatti gli inizi della riforma agraria e la nascita delle fattorie collettive denominate kolchoz, che determinò la reazione dei kulak, i proprietari che venivano espropriati. L’eroe è il giovane Vasilij, che riesce a fondare una cooperativa nonostante l’opposizione paterna. Momento chiave dell’impresa è l’acquisizione di un trattore, la cosiddetta vacca di ferro, destinato a cambiare radicalmente le tecniche di coltivazione. Euforico dopo l’incontro d’amore con Natal’ja, Vasilij, rientrando a casa nella notte, si produce in una danza interrotta dal colpo di fucile di un kulak suo coetaneo. La complessa sequenza delle sue esequie è il momento chiave dal punto di vista del significato o, se si preferisce, del messaggio. Un montaggio di alto virtuosismo alterna immagini sulla scelta dei genitori del protagonista che, facendo professione di ateismo, decidono di non chiamare il pope, scatenando lo sgomento e gli anatemi di quest’ultimo; le doglie e il parto di una contadina; la crisi di disperazione di Natal’ja, che si contorce nuda nella sua casa; la crisi isterica del kulak assassino; l’adesione, dapprima individuale, poi torrenzialmente collettiva, dei contadini, che si radunano ad ascoltare l’appassionato discorso di un dirigente, mentre un aereo sovietico attraversa il cielo sopra di loro.
Ma il film si apre e si conclude con immagini che lo inquadrano in una prospettiva più ampia. Prati e messi battuti dal vento, un volto di donna accanto a un girasole, e mele, tante mele, inquadrate sempre più da vicino. Poi il vecchio Simon che muore sereno, mentre l’amico Pe’tro gli raccomanda di dirgli se esistono l’Inferno e il Paradiso, quando sarà di là, e come si sta una volta defunti. Più tardi, sosterà davanti alla sua tomba, in attesa vana di una risposta, mentre dei bambini lo stanno a guardare sorridendo. Qualcuno dichiara che, avendo lui lavorato 75 anni con i buoi, se fosse stato Commissario del Popolo, gli avrebbe dato la medaglia del lavoro. A chi gli risponde che una medaglia non si dà per dei buoi, ribatte :<<E per cosa, allora?>>. Una volta sottratto all’urgenza delle coordinate storiche, La terra è ancor oggi leggibile dunque come uno straordinario poema epico-lirico che, non senza senso dell’umorismo, celebra la civiltà contadina, la sua cultura della morte come naturale sviluppo del continuum della vita, e come tale depotenziato di ogni drammaticità. Non a caso il film si conclude, simmetricamente, dopo il funerale di Vasilij, anch’esso punteggiato da una teoria di girasoli, con la pioggia che scroscia su altre mele, e cocomeri, meloni, zucche e melograni, promettendo un raccolto sontuoso per la stagione a venire.
Autore di altri film memorabili come Zvenigora (id., 1928), Arsenale (Arsenal, 1929), Aerograd (id.,1935)e Mičurin (id., 1949), realizzati in collaborazione con la maglie, Julia Solnceva,Dovžénko (1894-1956) è considerato uno dei giganti della cinematografia sovietica, al pari di Ėjzenštejn o Vertov, coi quali condivise le forche caudine della censura staliniana. Essendo nato a Sosnicy Cernigovskij, oggi sarebbe da considerare a pieno titolo ucraino. Ed è certamente ucraina la pianura sterminata e poeticamente messa in scena in questo grande film. Che, in un’ottica storica, risulta quasi beffardo rispetto a quello che accadde in seguito. Come scrive Vasilij Grossman in Tutto scorre…, la liquidazione dei kulak portò all’abbassamento della superficie coltivata e alla riduzione del rendimento delle coltivazioni. Essendo l’Ucraina considerata il granaio dei Soviet, i suoi contadini vennero ritenuti responsabili di sabotaggio, e si procedette a un assassinio di massa per fame (per il quale venne coniato il termine genocidio prima della Shoah) che prese il nome di Holodomor, nel corso del quale morirono – e malissimo – milioni di persone, da 1,5 a 15 secondo differenti valutazioni. Per entrare quasi fisicamente in questo orribile dramma rimandiamo ovviamente alle pagine, alte e dolenti, del grande scrittore russo di origini ebraiche, anche se lui stesso si chiede se sia stato davvero il Piccolo Padre a firmare l’ordine di questa infamia. Rimanendo al cinema, sia pure per una ricognizione di profilo più modesto, segnaliamo L’ombra di Stalin (Mr.Jones, 2019) di Agnieszka Holland, sulla vicenda del giornalista inglese Gareth Jones che, a quel tempo convinto sostenitore del sistema sovietico, fattosi inviare in Russia riesce a intrufolarsi in Ucraina, dove scopre la terribile realtà di un popolo che per sfamarsi arriva all’antropofagia, esperienza che mette in crisi la sua determinazione di comunista militante.
Altre tragedie che hanno coinvolto il popolo ucraino, dall’invasione nazista a quella dell’esercito di Putin, attribuiscono ulteriore interesse e significato al capolavoro di Dovžénko anche a chi non voglia accontentarsi della sua abbagliante bellezza.