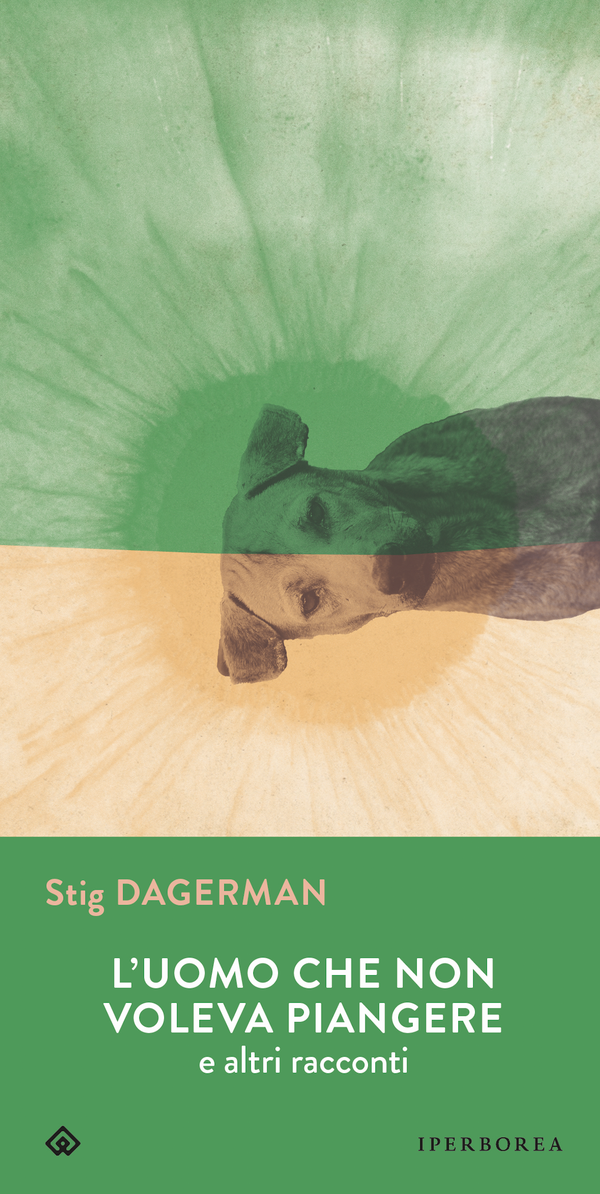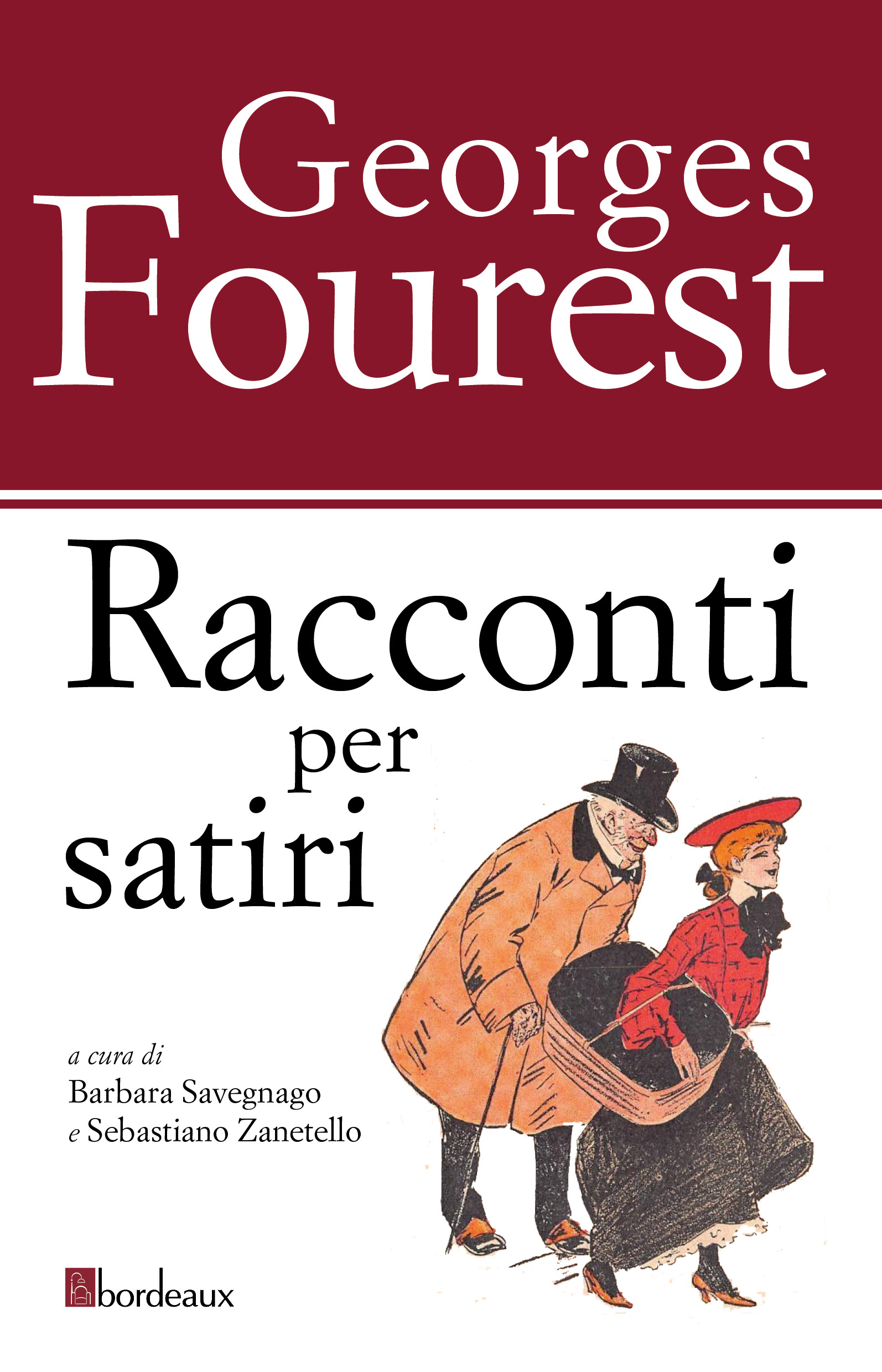Flashback – Il vento

Di Victor Sjöström (1879-1960) anche i cinefili meno acculturati ricordano la magnifica interpretazione del professor Isak Borg in Il posto delle fragole (Smultronstället, 1957). Ingmar Bergman però lo ha sempre citato come uno dei più grandi registi della storia del cinema, il maestro amato, perenne fonte di ispirazione. Assieme a Mauritz Stiller, lo scopritore di Greta Garbo, è stato infatti protagonista della ricchissima stagione del muto svedese. Influenzato dagli scrittori del suo Paese, in particolare Selma Lagerlof, che ha offerto ben sette romanzi come soggetto per i suoi film, ma anche Henrik Ibsen, da una ballata del quale deriva Terje Vigen (1917), ha saputo fare tesoro della lezione di David Wark Griffith in una prospettiva riconoscibilmente nazionale. Tra i suoi capolavori del periodo citiamo almeno I proscritti (Berg-Ejvind Och Hans Hustru,1917), in cui una delle costanti dell’autore, il rapporto colpa-espiazione, si fonde in maniera suggestiva quanto rigorosa con lo sfondo della natura aspra e inospitale dell’Islanda, e Il carretto fantasma (Körkarlen, 1920), dalla Lagerlof, la cui dimensione tragica appare ancor oggi sconvolgente, non risentendo della commissione da parte dell’Esercito della Salvezza come manifesto contro l’etilismo.
Come a Stiller, la fama apre a Sjöström le porte di Hollywood. Cambiato il cognome in Seastrom per questioni eufoniche, dirige nove film, otto muti e uno sonoro, tra i quali spiccano L’uomo che prende gli schiaffi (He Who Gets Slapped, 1924), prodotto da Irving Thalberg per la Metro e interpretato da un Lon Chaney in ambiente circense, ad anticipare lo strepitoso Freaks (id,1932) di Tod Browning, e soprattutto La lettera scarlatta,(The Scarlet Letter, 1926) dal romanzo di Nathaniel Hawthorne, del quale Pavese sottolineava una polemica antipuritana con furore puritano, dunque in perfetta sintonia con la poetica del regista. Fu appunto Lillian Gish, grandissima Hester Prynne, a imporre Seastrom alla produzione per il successivo Il vento (The Wind, 1928), chiedendo di essere affiancata da Lars Hanson, che nel film precedente aveva vestito i panni e i sensi di colpa del reverendo Arthur Dimmesdale.
Il vento deriva da un romanzo di Dorothy Scarborough sceneggiato da Frances Marion. La giovane Letty (Lillian Gish) lascia la Virginia per raggiungere il cugino Beverly (Edward Earle), che vive con la moglie Cora (Dorothy Cumming) e i tre figli in quella che gli ha descritto come una ridente fattoria. Durante il viaggio in treno è corteggiata da Roddy (Montagu Love), un commerciante di bestiame che insinua nella ragazza i primi dubbi sul ranch verso il quale si sta dirigendo. Giunta a destinazione, si accorge che si tratta di una triste baracca nel deserto battuto da un vento continuo e ossessivo. Oltretutto, Cora è gelosa di lei e la tratta malissimo. Rendendosi conto che l’unica soluzione per andarsene da quella casa diventata inospitale è il matrimonio, si propone a Roddy, che però le rivela di essere già sposato. Solo allora accetta la corte di Lige (Lars Hanson), il timido e complessato lavorante di Beverly. Ma il suo approccio la prima notte di nozze è maldestro, Letty rifiuta di concederglisi. Più tardi, approfittando del fatto che la donna è rimasta sola in casa, Roddy entra e la stupra. Letty lo uccide e cerca invano di seppellirne il corpo. La confessione del delitto a Lige riavvicina i due coniugi. La prima sceneggiatura prevedeva un finale tragico, con Letty che vagava nella bufera fino alla morte.
Girato nel deserto Mojave, Il vento ha un’ambientazione western, ma ben presto si impenna verso altre direzioni, dal mélo familiare con i suoi obbligati riflessi psicoanalitici alla tragedia con i suoi archetipi ma anche vie di fuga nel delirio onirico che prende forma nella presenza simbolica di un leggendario cavallo ripreso al ralenti e in negativo. È però soprattutto il soffiare del vento, che impazza negli esterni, penetra dalle finestre, impedisce di chiudere le porte essendo infine addirittura l’unico detersivo per pulire le stoviglie, a segnare emotivamente questo grande film. Sjöström, oltre a renderlo il dirompente protagonista sul piano visivo, riesce miracolosamente a farne percepire la voce su quello sonoro, persino l’invasività delle polveri che lo compongono su quello tattile. Come ha scritto Claude Beylie, Il vento ha rappresentato il canto del cigno del muto, insieme ad altri due capolavori come Aurora (Sunrise,1927) di Friedrich Wilhelm Murnau e Il fiume (The River, 1929) di Frank Borzage. Contemporaneamente, ha segnato la fine della carriera come regista del suo autore, probabilmente incapace di adattarsi alle regole del sonoro. Tornato in patria, Sjöström dopo tre sfortunati tentativi dietro la mdp, l’ultimo in Inghilterra, si limitò al mestiere di attore. Oltre che con Bergman, per il quale recitò anche in Verso la gioia (Till Glädje, 1949), per registi di un certo livello come Arne Mattsson, cinque volte, e Gustav Molander, tre film, uno dei quali,il notevole Ordet (id,1944), ebbe la sfortuna di essere paragonato, dieci anni dopo, all’inarrivabile remake di Carl Theodor Dreyer.