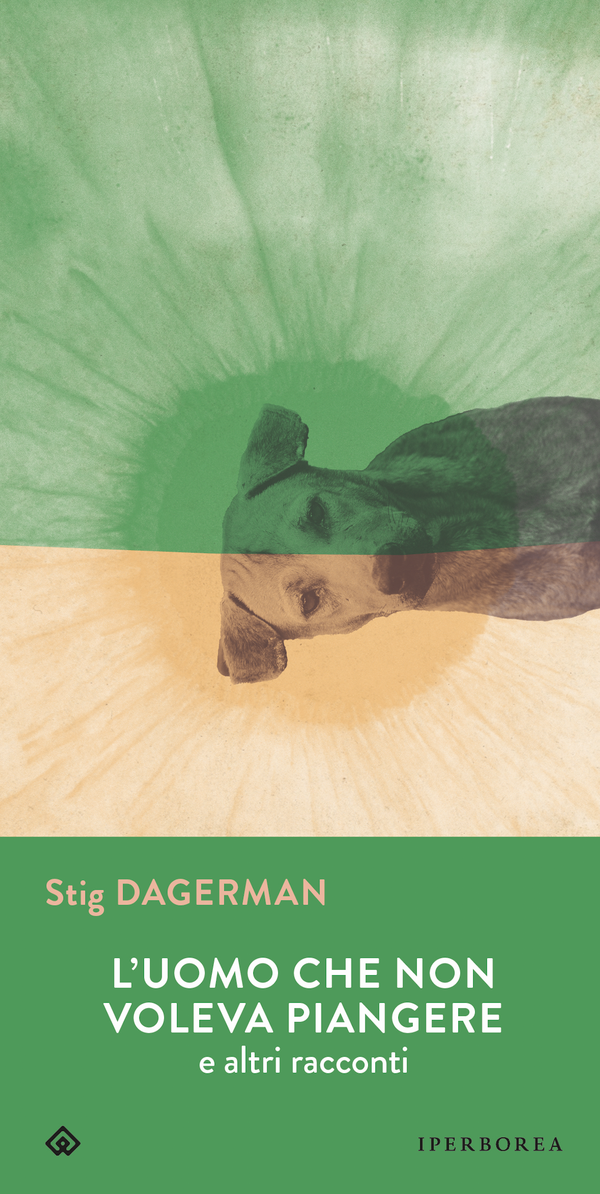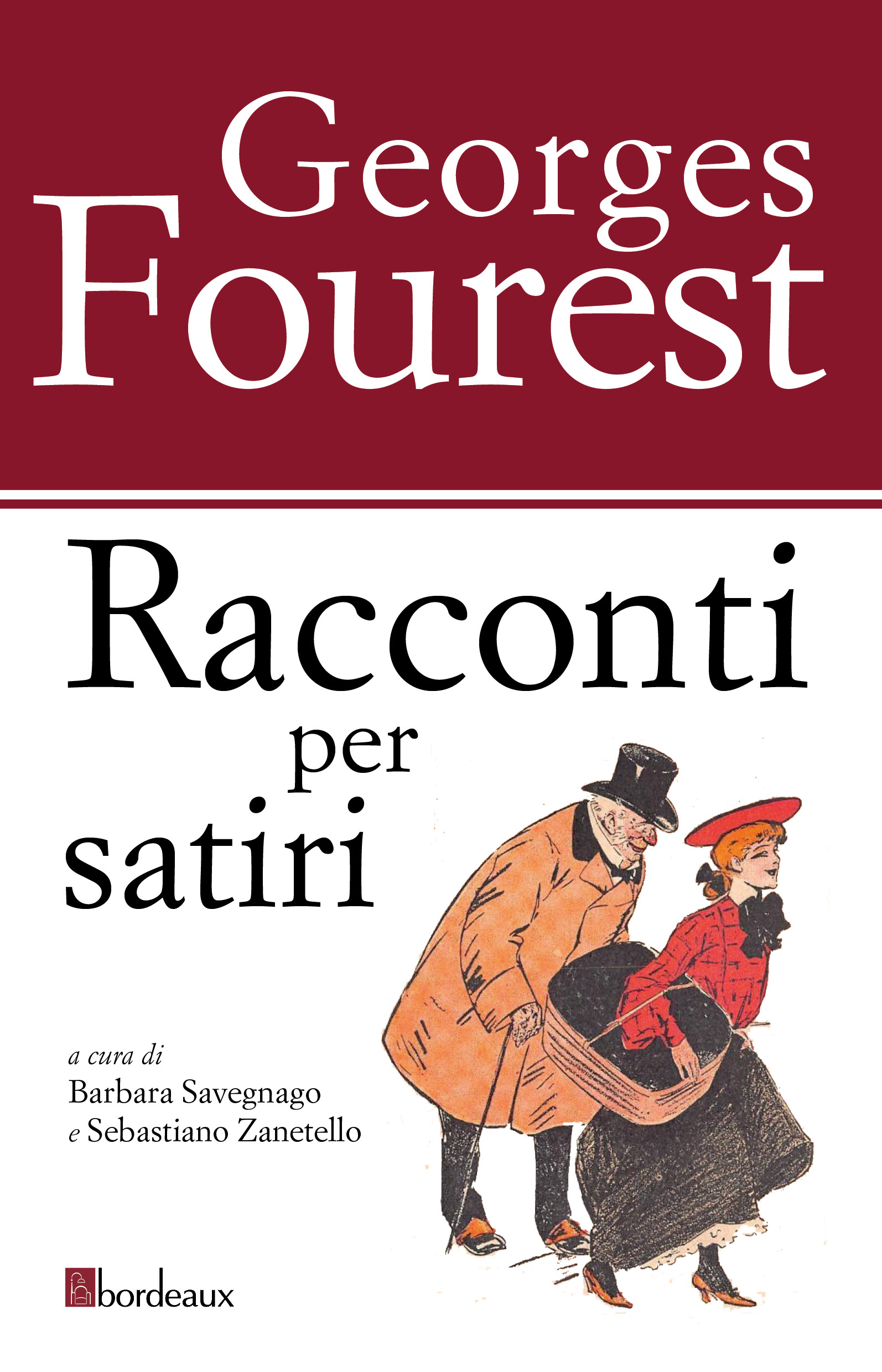L’angelo del focolare spento

MONTICCHIELLO – C’è una storia d’amore tenerissima ed amara, triste e delicata come i singhiozzi soffocati nei cuscini della gioventù, che scorre carsicamente attraverso passato e presente in questo La casa silente, il cinquantanovesimo autodramma del Teatro Povero della gente di Monticchiello, disvelandosi compiutamente solo in chiusura. È la storia di un uomo e di una donna, Margherita Del Giusto e Tacito Roghi, che nel 2059 sono ormai molto anziani ma che un tempo erano stati ragazzi insieme, su a Monticchiello, e si erano conosciuti, amati e fidanzati rimanendo sempre migliori amici e complici, la coppia più bella del paese, condividendo casa e sogni, soprattutto quelli di Tacito (il partito, la storia locale, la raccolta di oggetti e documenti che potessero testimoniare il passato del borgo) ma alcuni anche in comune, come il Teatro Povero.





E poi, a dividerli definitivamente, a segnare una distanza incolmabile, arriva l’idea di un estraneo in famiglia, di un terzo, di un figlio al quale lei naturalmente tende ma che lui al contrario non vuole perché non sarebbe possibile mantenerlo, perché il lavoro non c’è e tutto costa sempre di più, perché ha molto più senso restare in due e dedicarsi alle proprie passioni (ma nemmeno questo convincerà Margherita: Ti lamenti che tutto sta morendo, ma non capisci che le cose, per vivere, hanno bisogno di persone? Dietro le bandiere, dentro le case, nelle piazze a fare teatro). È facilissimo immedesimarsi nel loro passato che è anche il nostro presente, un tempo nel quale procreare è già diventata una scelta nettamente sconsigliabile su base razionale e divergenze laceranti di questo tenore sono pane quotidiano per molti, sono vita vissuta che scorre dentro o accanto alla nostra. L’alchimia d’amore vira rapidamente in un’estraneità sofferta, aspra e dolente. Sulla vita dei due amanti cala un sipario greve di attese disilluse e desideri frustrati, un’ombra gelida che spezza le due metà della mela come una mannaia. Le strade si dividono, Margherita, che non si sente scelta, se ne va, mentre la casa di Tacito resta vuota e silenziosa di voci, solitaria di lei, sovraccarica di oggetti accumulati con maniacalità seriale, stratificata di passato, un enorme cimitero sottosopra di cose e di senso, perché credevi di poter salvare tutto e invece dovevi fare una scelta, e quella scelta non sei stato in grado di farla.
Sembra di sentirle, le riunioni e i dibattiti fatti a Monticchiello per decidere l’argomento e l’andamento dello spettacolo, e poi sembra di starci dentro fino in fondo, a questa storia così vera, alla quale la regia e la drammaturgia di Manfredi Rutelli e Gianpiero Giglioni conferiscono la forma e la profondità di una parabola laica, un gustosissimo aforisma sapienziale che senza nulla volerci insegnare per forza e su tutto posando uno sguardo ed una penna intelligente e gentile ci interroga sul senso delle scelte, sulle loro conseguenze, ci fa sedere sull’altalena e ci dondola su cadenze dialettali inconfondibili, in un oscillare continuo tra prima e poi, tra cause ed effetti, premesse ed esiti.
La prima spinta ci porta subito nel 2059, davanti alla casa di Tacito, evocata in scena da scatoloni e mobili ammucchiati oltre un velatino bianco. La ‘squadra case silenti’, sei individui in tuta grigia d’ordinanza, si prepara a far brillare la porta per accertare l’eventuale morte del proprietario, del quale non si hanno più notizie da giorni. Gli anziani a queste date sono ormai una stragrande maggioranza sul pianeta terra e vivono tutti da soli, i bambini sono più rari dell’araba fenice ed il borgo di Monticchiello, accessibile con un pass, è appannaggio e proprietà di ricchissimi stranieri, i “livello sei”, che pur non essendo mai davvero sul posto sorvegliano e controllano tutto e tutti con sensori, telecamere, microfoni e allarmi sempre pronti a fornire materiale per sanzioni e ammende. Dall’intero non giunge risposta e la porta viene quindi fatta saltare: tra lo stupore generale si constata che il Roghi non è defunto, è assente. Le ‘cose morte’ (fotografie, manifesti, libri, documenti) iniziano a sciamare verso il mondo esterno, ad essere perlustrate e scandagliate dalle mani della squadra e degli anziani radunati davanti casa, sulla piazza, il doppio dell’acciottolato scosceso nel quale ci troviamo noi spettatori, la bella tasca morbida e ondosa nel cuore del borgo, dentro la quale scivolare ogni anno per assieparsi in vista del palco del Teatro Povero. Gli oggetti ritrovati ci trasportano avanti e indietro, dalla piazza di oggi alla casa di Tacito giovane, raccontando persone, storie, sentimenti e quel passato dolceamaro da gustare in filigrana oltre il leggero diaframma di velo bianco.
A riportarci bruscamente al presente è l’ansia di Gianni, un membro della squadra (di recente tornato a vivere con la compagna Catia al paese degli avi, giù alle micro-case) dotato agli occhi di tutti di una patente di assoluta eccezionalità in quanto padre (indossa la speciale tuta verde), è la tensione che cresce all’avvicinarsi dell’orario stabilito per il ritrovo annuale, qui in piazza, dei bambini delle tre province e dei loro genitori, alla presenza di figure di pedagoghi professionisti detti Facilitatori, che guideranno e osserveranno l’interazione dei fanciulli, valuteranno e quantificheranno le capacità genitoriali degli adulti. Gli anziani di Monticchiello, che da tempo immemore non vedono un bambino (figuriamoci più di uno insieme) chiedono il permesso di poter assistere all’esposizione di queste rarità.
Un carretto di legno con ruote e cordicella per trainare, antico balocco adrenalinico per ragazzi di collina dalle ginocchia sempreverdi, è l’oggetto-simbolo dell’assenza di Tacito, che riemerge in modo inopinabile dalla sua wunderkammer proprio durante il raduno dei preziosi esemplari, potenziali prosecutori della specie, che non si incontrano mai perché sono un bene collettivo di proprietà dello stato e vengono salvaguardati da qualsiasi tipo di pericolo o di infortunio attraverso una reclusione finalizzata alla sopravvivenza ad ogni costo, un isolamento fatto di insegnanti digitali, ologrammi, immobilità, controllo ferreo, protezione parossistica, genitori impauriti ed incapaci di emanciparsi dai protocolli. Il carretto trionfale varca la porta esplosa della casa del Roghi ed arriva a scompaginare interrompere e perturbare in modo irreversibile il programma di attività asettiche e rigide come i kimoni neri dei Facilitatori, che rendono i piccoli sempre più irascibili ed aggressivi. I vecchi insegnano ai bambini delle tre province che si può correre, giocare insieme, fare con le mani: la rivoluzione si consuma tra quattro assi di legno e una discesa finché non viene sedata dai Facilitatori ed il ‘bambino 12’, il figlio di Gianni e Catia che ha eluso la loro sorveglianza, risulta scomparso.
È così che approdiamo finalmente al ritorno a casa di Tacito, con un ultimo volo di altalena tra un anello di fidanzamento mai donato ed una donna che muore rivivendo i suoi giorni felici. Una volta esaudite le ultime volontà della sua amata, ora sepolta al paese natio, il Roghi arriva in piazza mano nella mano con Antonio, il bambino perduto che è un po’ anche quello mai nato: è lui la voce alla quale donerà la sua casa, non più silente, da abitare insieme alla sua famiglia.