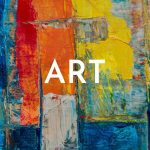Sicilia contemporanea: l’arte dialoga con la storia

In Sicilia Agrigento è capitale della cultura, in un’isola che nella storia è stata la manifestazione dell’idea di cultura, anzi di culture; vi avvengono una serie di eventi che tendono a dimostrare una sua perdurante vitalità, almeno sotto questo aspetto, che tende a vincere le resistenze all’incedere dell’arte contemporanea e far dimenticare la negativa esperienza di Nuova Gibellina.
Dall’Infiorata di Noto, in provincia di Siracusa, famosa ormai se non superiore ad altre sul territorio nazionale, è nata quest’anno la Fuori Infiorata. Ideatori e direttori artistici Alessia Montani e Luigi Grasso, a cura di Andrea Guastella, dona a questa cittadina e all’evento consolidato un’estensione aggiuntiva, arricchendo e valorizzando ulteriormente il corredo di bellezze che Noto già di suo ha da offrire.
Le idee alla base del progetto sono diverse e interagiscono. La prima: l’inserimento di opere d’arte del presente, che stabiliscono, idealmente, una sorta di colloquio stretto, spesso sorprendente, tra visione, partecipazione collettiva e patrimonio storico; poi il coinvolgimento delle persone interessate a cui viene affidata una mappa per la ricerca delle opere inserite nel contesto urbano, un’esplorazione tra il divertissement e la responsabilizzazione, a cui si collega quella che è la proposta decisiva ovvero il contrasto/incontro tra l’impianto barocco, stile prevalente nella città patrimonio dell’Unesco, e l’arte dell’oggi. Attraverso una pianta topografica circostanziata, che delinea il tessuto urbano e non solo, viene indicata la disseminazione delle istallazioni contemporanee. Come in un gioco, senza un percorso prefissato, chiunque può cimentarsi nella scoperta e nella visione dei lavori di artisti che hanno lasciato la loro impronta in diverse sedi significative della città. Il cortocircuito tra antico e moderno, tra l’opulenza del barocco e la iattante modernità delle opere, insieme al fascino e alla implicita difficoltà e indecisione di colloquiare o non con l’ambiente circostante che le ospita, crea una sorta di smarrimento, ma anche di incanto nel fruitore, turista, appassionato, studioso, che si trova, così, a dover osservare su più livelli ciò che gli sta di fronte. Un benefico disagio che vale a porre un punto fermo: esiste un attuale culturale che ci interroga e si sovrappone alla ‘storia’, non la nega, ma ne dichiara il profilo, la sua posizione nel tempo, lasciando liberi di scegliere a quali valori accostarsi.
Sul versante opposto dell’isola, in un contesto extraurbano un evento che va a sommarsi arricchendo il contributo di valori, ma affatto divergente. A Segesta non si sa con certezza se quello che si erge alla sommità del monte Barbaro sia un edificio sacro eretto dagli Elimi, come qualcuno sostiene, o una struttura appartenente alla cultura architettonica greca, ma non templare a causa dell’assenza della cella e di scanalature sulle colonne, per il resto doriche a tutti gli effetti. Ma non ha importanza. Ciò che ci interessa è l’intervento sull’impianto non finito e splendidamente conservato. L’azione Texere è un’installazione ad opera di un’artista incline alla visione sociale e naturalistica, Silvia Scaringella, che forse si ispira all’ ‘impacchettatore’ bulgaro Christo, ma non lo imita, consistente in un tessuto policromo di alcune centinaia di metri che avvolge la struttura trasformandola idealmente, senza farle perdere l’identità, in un telaio. Un’operazione che può rievocare Aracne e Penelope ma contemporaneamente si collega, sfruttandone la suggestione, ad altre due architetture di minor rilevo sullo stesso territorio, particolarmente denso di antichità, facendo discutere, in quanto è stata vista da certi spiriti critici come una profanazione di un totem dell’archeologia, della storia dell’arte, della storia.
C’è chi invece, giustamente a mio avviso, l’ha correttamente interpretata come un efficace tentativo di compenetrazione, transitoria quanto si deve e rispettosa del manufatto, tra antico e contemporaneo, che non si ferma al ‘tempio’, bensì allarga l’azione. In prossimità dell’edificio templare, come si accennava, sorgevano una chiesa medievale e la moschea del Venerdì, vicina al Teatro antico. Ciò ha suggerito all’artista l’adozione del tessuto, ispirato al tappeto di preghiera utilizzato dagli islamici, facendole scegliere la tela frutto di un riciclaggio, coinvolgendo gli studenti del territorio per la realizzazione del lavoro ed evocando con il tracciato di fibre tessili una sorta di rete che unisse le tre espressioni religiose stratificatesi nella storia: didascalica e sofisticata al contempo. Come si può capire, una serie di gesti che non vanno ad esprimere soltanto un’estetica, bensì parlano un linguaggio attuale. Grazie all’idea infatti il monumento da oggetto di contemplazione diventa strumento di riflessione e insieme didattico, affievolisce momentaneamente la sua sacralità per calarsi nell’oggi, grazie anche al reimpiego delle stoffe, e quando riprenderà la sua funzione resterà intatto, ma avrà cambiato la percezione dell’antichità nella mente di chi ha visto la sua temporanea trasformazione. Rendendolo utile per un analogo “uso artistico” futuro, attivo e non oggetto inerte di uno sterile incanto. Non è stata la soluzione giusta? Forse. Ma due considerazioni la fanno apprezzare: la non irreversibilità, quindi il rispetto del manufatto templare, e la rete di azioni e ragioni che sottostanno alla sua realizzazione.