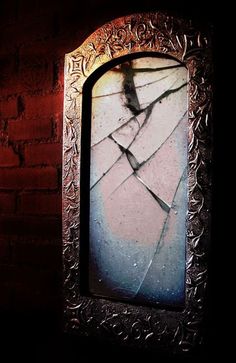Chiesa e teologia
«Al tempo de la guerra…»

Dal 1644 nel mese di giugno di ogni anno, nella cittadina di Assisi, si ripete un piccolo evento locale, la Festa del Voto che, pur avendo poca risonanza, racchiude in sé un forte potere simbolico: si fa memoria di quando, “al tempo de la guerra de Assisi” (FF 2984), Chiara a San Damiano fece suo il grido della città e la liberò, così si narra, dall’invasione dei saraceni assoldati da Federico II. Nelle Fonti Francescane l’episodio, anzi più episodi simili (forse sovrapposti) sono raccontati non solo dal biografo ufficiale, Tommaso da Celano, nella “Vita di santa Chiara vergine” (FF 3203), ma anche e soprattutto dalle monache testimoni al Processo di Canonizzazione, le quali erano state fisicamente presenti all’accaduto riportandone i dettagli e le parole stesse di Chiara.
Nella valle di Assisi erano schierate truppe di saraceni ed il monastero di San Damiano in cui vivevano le Sorelle Povere, collocato al di fuori delle mura cittadine, fu uno dei primi luoghi ad essere raggiunto. A quel punto Chiara, nonostante fosse da tempo inferma, compì un gesto fisico forte: frappose il proprio corpo esattamente lì nel mezzo, tra la sua città e coloro che ne minacciavano la pace. Tra Assisi ed i saraceni si trovava saldo il corpo di questa donna inferma che, contemporaneamente, pronunciava parole di esposizione totale: “…io voglio essere vostra recolta” (FF 2984). Intendeva, cioè, farsi sentinella e garante: “recolta”.
“Al tempo de la guerra de Assisi” Chiara visse intensamente il legame con la propria comunità cittadina, dichiarò attivamente la propria appartenenza “politica”, sociale, comunitaria a motivo della quale espose completamente sé stessa: il corpo, le parole, i gesti ed infine la preghiera. Tanto che la sua città ancora ne fa memoria, a distanza di oltre 800 anni, avendo beneficiato della sua mediazione, spirituale sì, ma non solo. La stessa intera comunità di San Damiano, nella quale convivevano donne provenienti dal territorio di Assisi o poco distante, era collocata in uno spazio di confine, uno spazio per certi versi “dialogico”, tra la “polis” e il suo esterno. Una comunità di donne, sottratte per scelta agli stretti dinamismi sociali, si pose come membrana cittadina che filtrava, come sentinella che scrutava, come garante di scambi di pace. In altre parole, si collocò in modo profetico nel suo luogo e nel suo tempo.
Come non pensare, tornando invece al nostro tempo, allo stesso gesto fisico delle dodicimila donne del Women’s Peace Camp che il 12 dicembre del 1982 circondarono la base Nato di Greenham Common, tessendo una ragnatela con fili di lana e attaccandovi sopra oggetti di vita quotidiana, ponendo anch’esse i propri corpi sul confine simbolico tra la guerra e la pace.
“Al tempo de la guerra” in cui ogni dialogo diventa difficile, i gesti acquistano la forza negata alle parole.
Il potere simbolico (e pratico) della santità si manifesta, allora, nella creazione e resistenza di quelle utopie quotidiane per le quali si crede fermamente possibile un cambiamento, che parta anche dalla propria piccola (grande) pratica feriale: che sia di pace, di dialogo, di costruzione e protezione della comunità. “Le pratiche sono un modo per avviare processi di trasformazione sociale assemblando parole, azioni e intenzioni in modo creativo e condiviso. (…) iniziative apparentemente minute e marginali, azioni capaci di incidere sull’assetto pratico e simbolico. Molte di queste pratiche hanno la fisionomia dell’utopia concreta e quotidiana” (V. Rosito, Il dialogo. Uno stile di vita, Pazzini 2020).