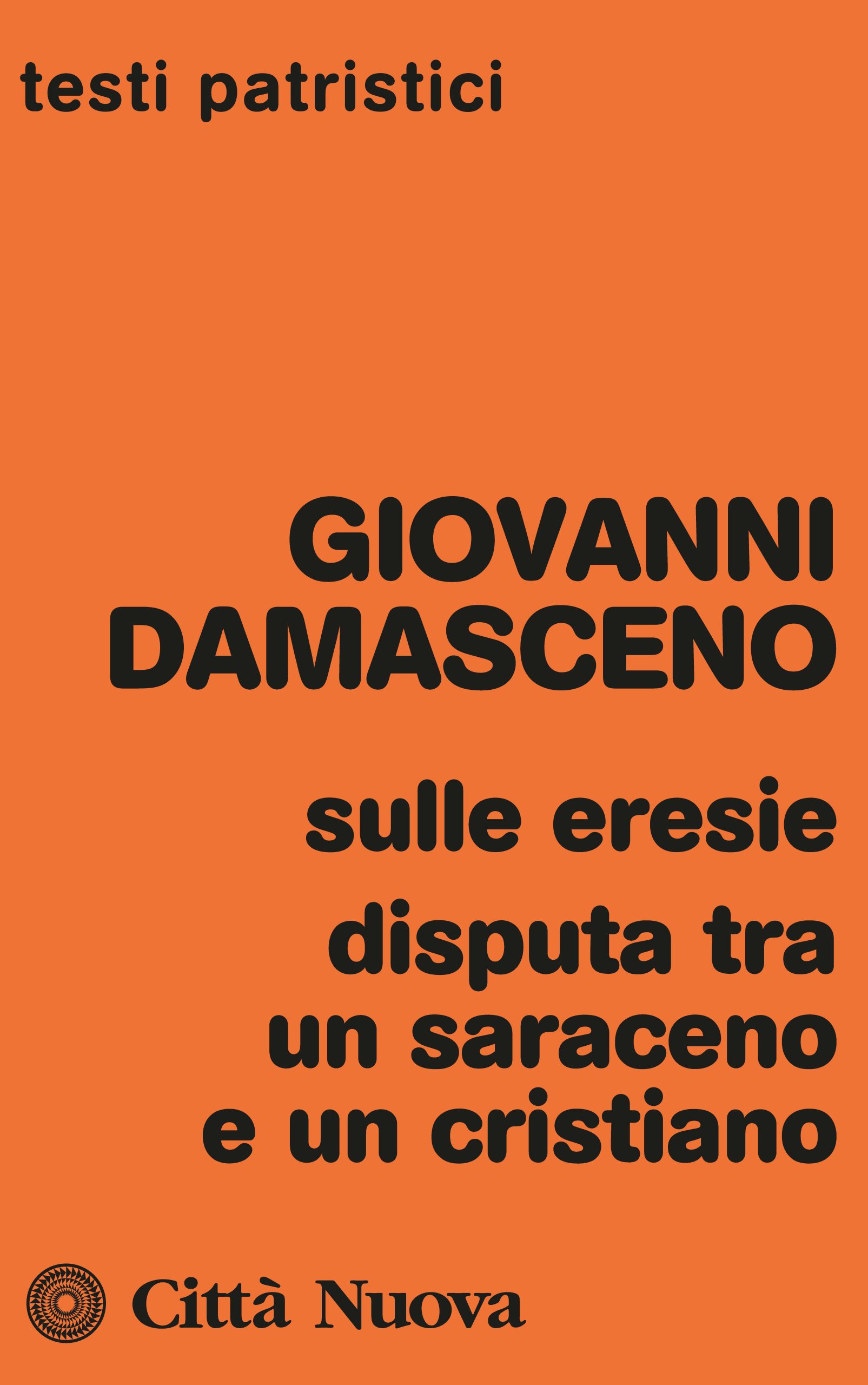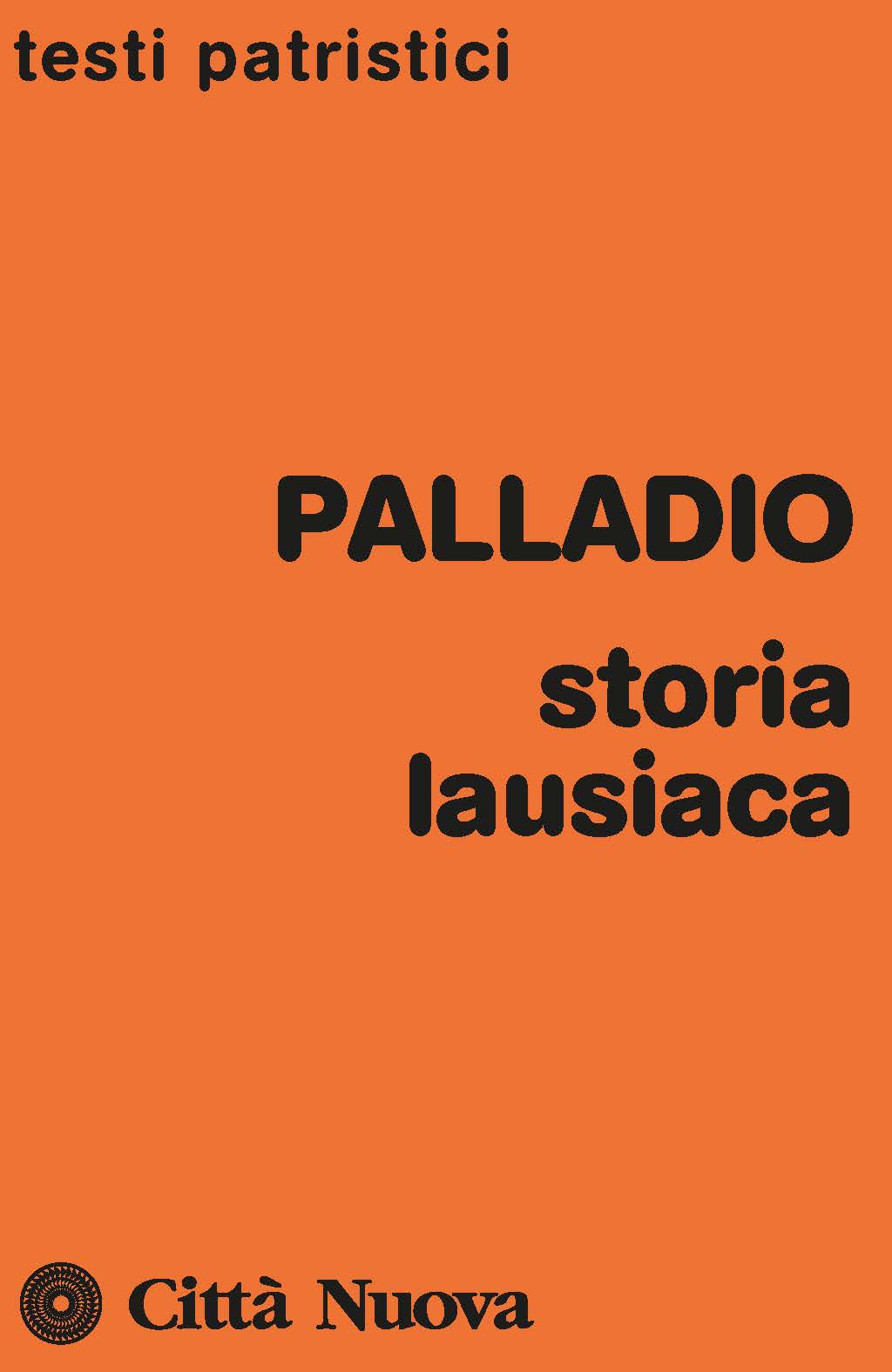Il peso dell’eredità
Tante storie
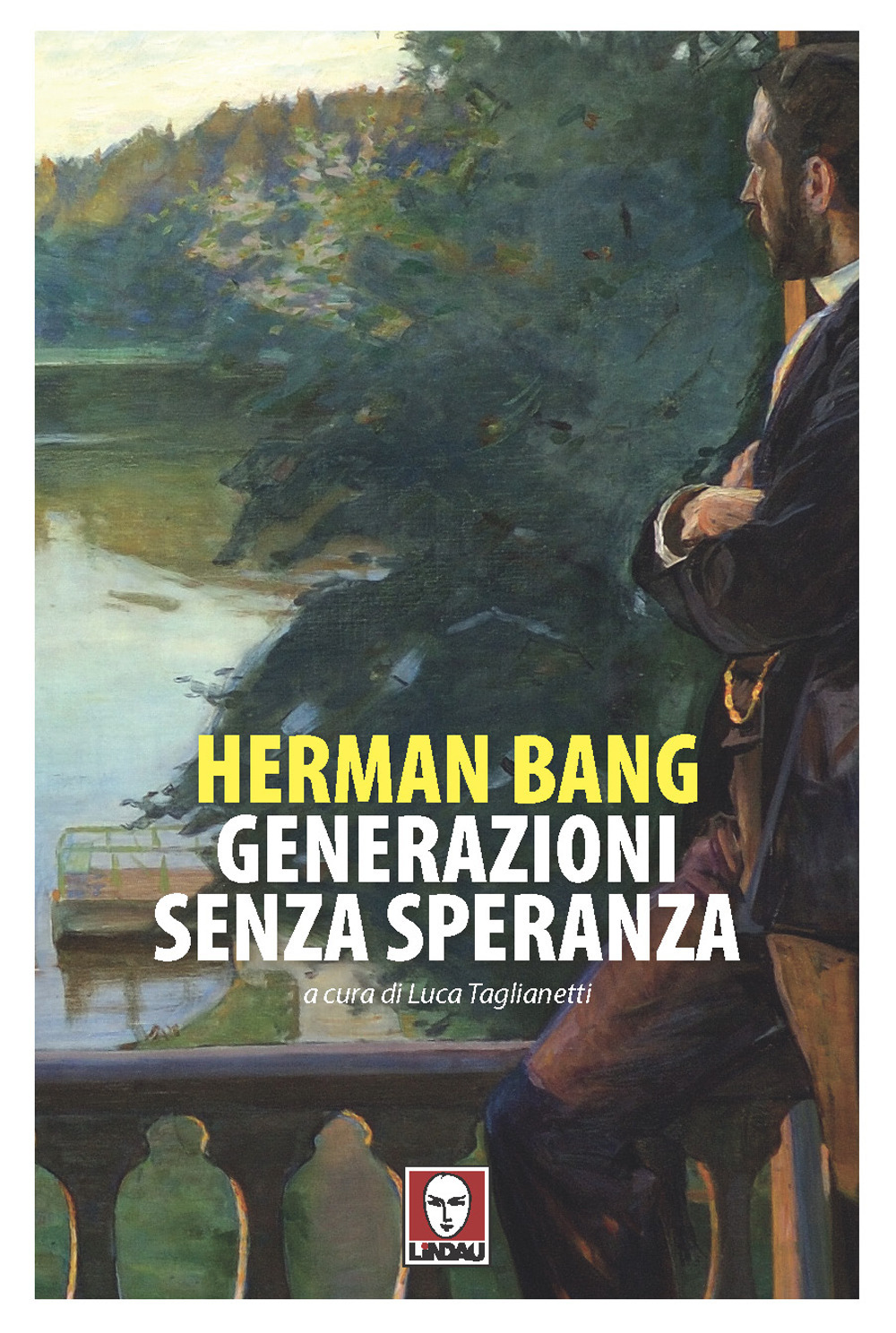
Herman Bang
Generazioni senza speranza
Lindau, 2025, pp. 500
€ 32
La pubblicazione in Italia, a quasi centocinquant’anni di distanza dalla sua prima uscita danese, di Generazioni senza speranza rappresenta un evento non solo per gli studiosi di letteratura nordica. L’editore Lindau, con un volume corposo di cinquecento pagine, restituisce finalmente al lettore italiano il romanzo d’esordio di Herman Bang, nato nella regione danese dello Jutland nel 1857 e morto in circostanze mai del tutto chiarite negli Stati Uniti nel 1912, figura tanto affascinante quanto controversa. Bang fu giornalista, attore mancato, regista teatrale, raffinato impresario culturale, ma soprattutto maestro di quella prosa impressionistica che Claude Monet non esitò a definire, con ammirazione, la prima autentica trasposizione letteraria del suo stesso metodo pittorico. La sua fama, allora come oggi, è legata all’abilità di rappresentare, con occhio attento e sensibilità crepuscolare, le tensioni psicologiche, le derive decadenti e le malinconie di esistenze destinate all’ombra.
Quando Generazioni senza speranza uscì nel 1880, l’effetto fu dirompente. L’opera suscitò scandalo immediato: le sue pagine ospitavano infatti la relazione erotica fra un giovane rampollo aristocratico e una nobildonna molto più anziana, la contessa Hatzfeldt, delineata con un’intensità che, pur priva di descrizioni esplicitamente carnali, risultò intollerabile al gusto moraleggiante della Copenhagen del tempo. L’Alta Corte di Danimarca ne decretò la natura oscena, ordinandone il sequestro e comminando a Bang una pesante ammenda per evitare il carcere. Fu la consacrazione dello scandalo come destino dell’autore, ma anche l’inizio della sua marginalità: da allora egli visse tra Parigi, Berlino, Praga, tentando invano di conciliare la vocazione artistica con la costante persecuzione sociale, alimentata dal fatto di non aver mai nascosto la propria omosessualità in un’epoca che la bollava come degenerazione da reprimere.
Il romanzo, letto oggi, non colpisce tanto per l’audacia delle scene amorose, quanto per la capacità di fondere autobiografia e finzione in un quadro di decadenza familiare e sociale che trascende il particolare danese e assume valenza universale. Il protagonista William Høg, erede di una casata in rovina, è un giovane segnato fin dall’infanzia dal peso della malattia del padre e dalla morte precoce della madre, che gli trasmette un culto ossessivo per il lignaggio. In questa atmosfera di oppressione domestica, aggravata da un’educazione scolastica rigida e sterile, William cresce come un sognatore incapace di misurarsi con la concretezza del reale: la sua mente vaga fra illusioni teatrali, slanci religiosi, amori dissonanti con donne mature che si concludono sempre nella disillusione. Il sogno di un riscatto attraverso il palcoscenico fallisce, schiacciato dalla sua stessa fragilità fisica e psichica; l’amore, anziché liberarlo, lo imprigiona in dinamiche torbide e asimmetriche. Alla fine, non resta che la amara consapevolezza di essere l’ultimo ramo sterile di una genealogia esausta, emblema di una intera generazione incapace di rinnovarsi.
La forza del romanzo risiede più che nella trama, nel modo in cui Bang cesella ogni dettaglio, ogni gesto, ogni sguardo con un’attenzione quasi cinematografica. L’impressionismo letterario che lo contraddistingue fa sì che i grandi eventi si dissolvano nelle sfumature psicologiche: ciò che resta non è tanto il ricordo di episodi clamorosi, quanto un’impressione diffusa di languore, di fragilità, di esistenze consumate dall’interno.
Generazioni senza speranza è anche un romanzo politico, nel senso più ampio del termine. Nelle sue pagine affiora il ricordo della sconfitta della Danimarca contro la Prussia nel 1864, trauma nazionale che segnò la fine di ogni velleità di potenza e lasciò nel popolo danese una ferita mai rimarginata. Bang, toccando questo nervo scoperto, si attirò accuse di antipatriottismo: attraverso il destino privato di William, è rappresentata la decadenza di un’intera nazione, incapace di affrontare il presente con vigore e condannata a ripiegarsi malinconicamente su un passato idealizzato. Il romanzo, così, intreccia strettamente il motivo autobiografico con quello storico-sociale: la genealogia che si estingue non è solo quella di William, ma l’intero tessuto di una società incapace di rigenerarsi.
A distanza di oltre un secolo, l’effetto scandaloso di Generazioni senza speranza si è attenuato, ma il romanzo conserva intatta la sua forza di testimonianza. L’edizione italiana di Lindau curata da Luca Taglianetti colma dunque un vuoto e offre al lettore la possibilità di avvicinarsi a un autore che contribuì a dare alla letteratura scandinava una dimensione pienamente europea. Non si tratta solo di un recupero filologico, ma di un atto culturale che riconosce nella voce di Bang la capacità di raccontare le zone d’ombra dell’esistenza con lirismo impressionistico. L’eleganza con cui descrive la malattia, il languore, la sensualità come forza insieme vitale e distruttiva, conferisce al romanzo una qualità ipnotica e ciò che era stato bollato come pornografia appare oggi come capacità di una sottile analisi psicologica.