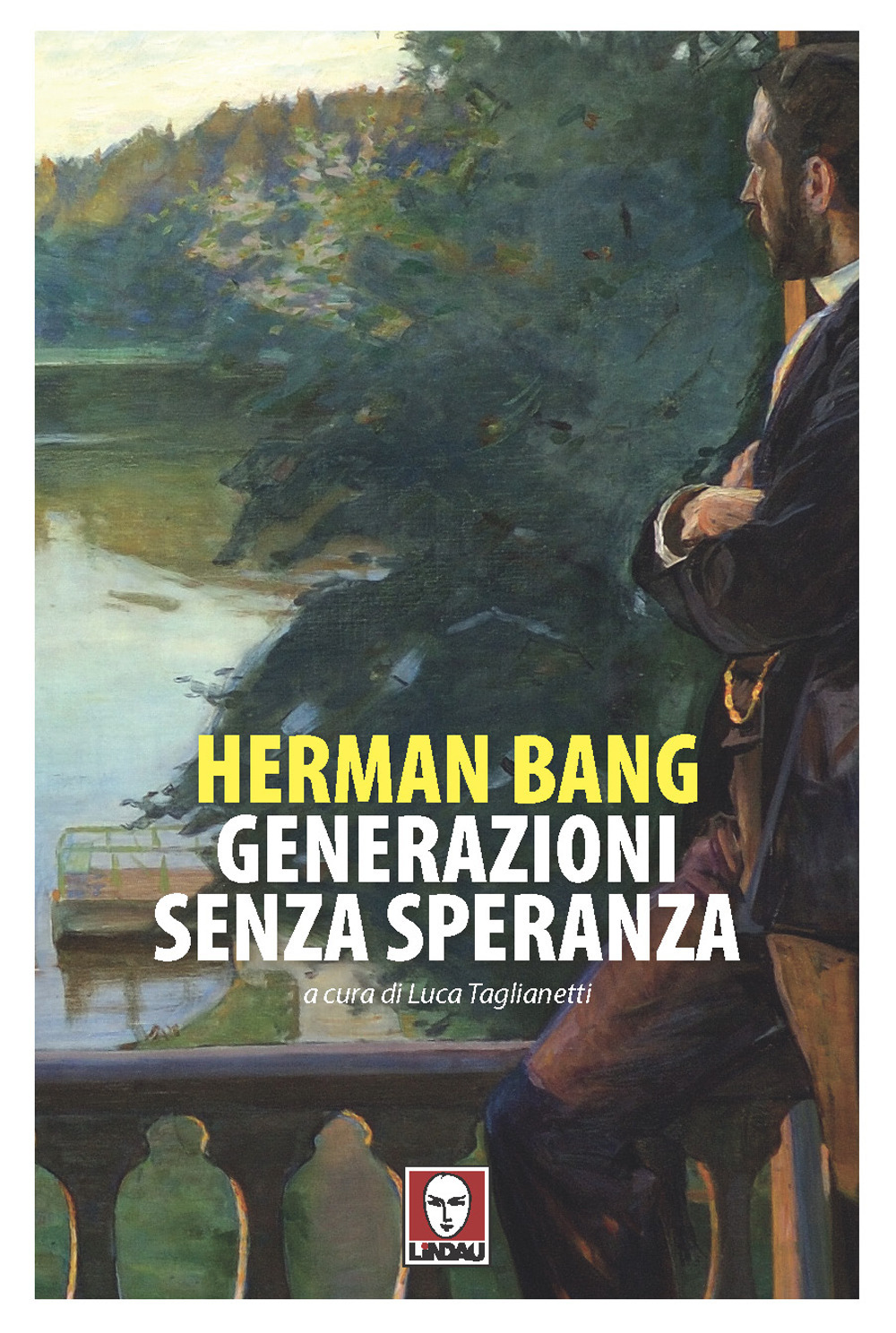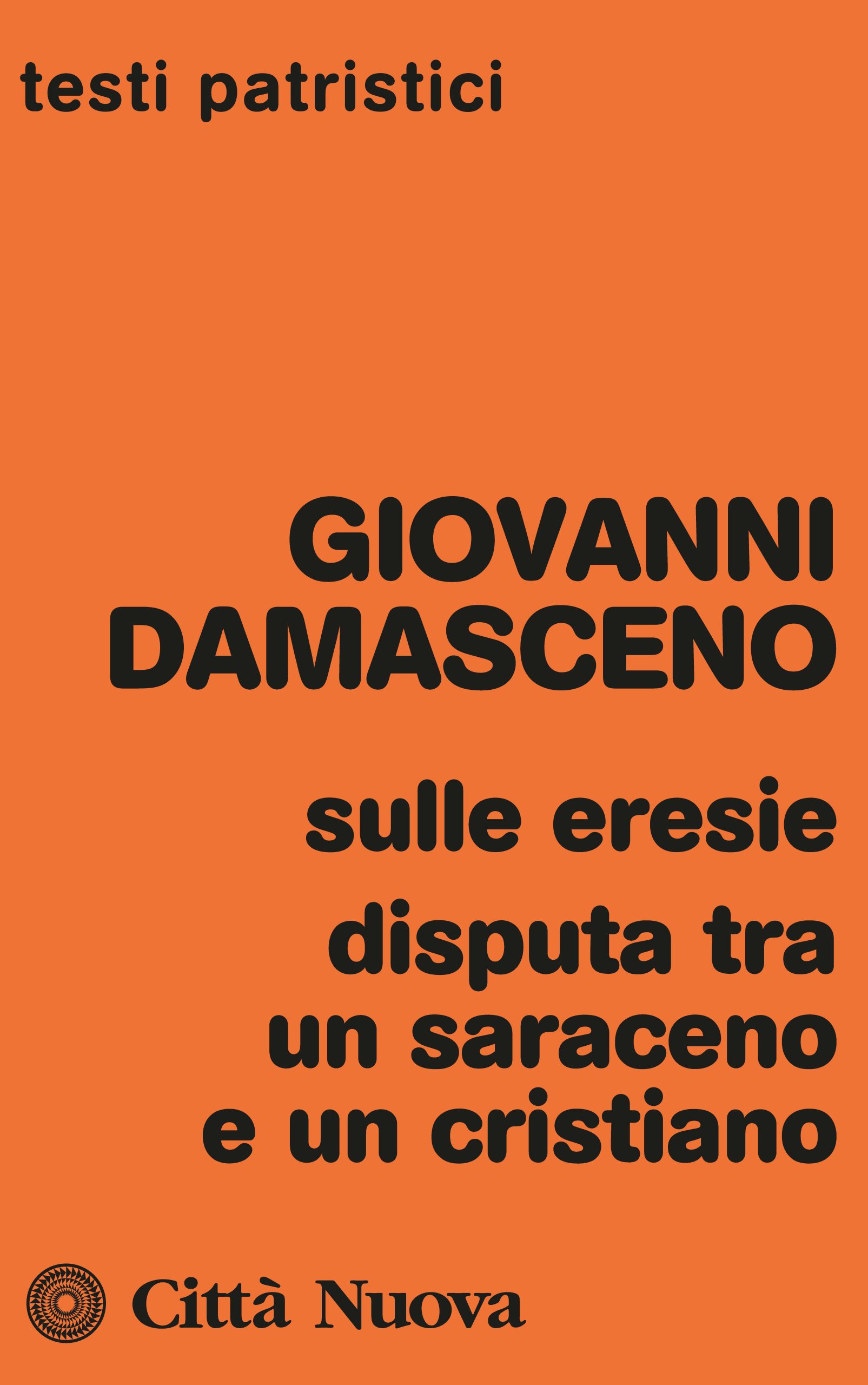Asceti e visioni
Patristica
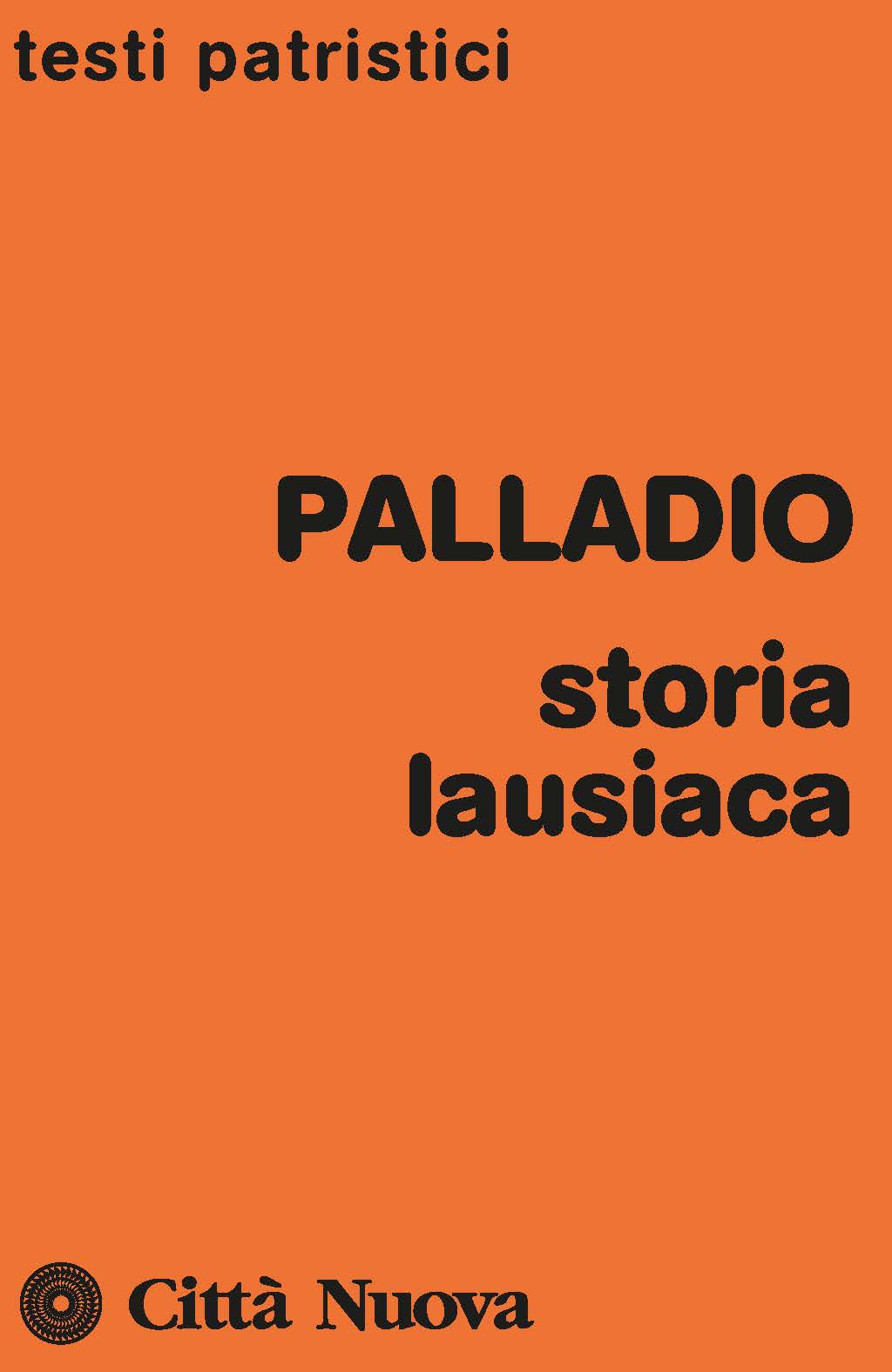
Palladio
Storia lausiaca
Curatore: Vincenzo Lombino
Città Nuova, 2025, pp. 280
€ 28
L’edizione della Storia lausiaca di Palladio, pubblicata da Città Nuova nel 2025 con la curatela di Vincenzo Lombino, offre ai lettori un accesso prezioso a una delle opere più significative della letteratura ascetica tardoantica. Il volume raccoglie il testo di questo classico del IV-V secolo, corredato da un apparato critico e introduttivo che ne chiarisce la genesi, le implicazioni teologiche e l’impatto storico.
Palladio di Galazia, vescovo e scrittore, fu figura liminale nel panorama cristiano del suo tempo: discepolo di Evagrio Pontico, influenzato dalla spiritualità origeniana e sostenitore di san Giovanni Crisostomo, visse in prima persona le tensioni ecclesiastiche che attraversarono il tardo Impero romano. La sua Storia lausiaca, redatta attorno al 420 e indirizzata a Lauso, funzionario di corte, è un’opera profondamente intrisa di esperienza personale, nata da un lungo pellegrinaggio tra i luoghi del monachesimo egiziano, palestinese e siriaco. Più che una cronaca sistematica del movimento monastico, è una galleria di ritratti spirituali, una raccolta di vite esemplari che intende tramandare modelli di virtù ascetica, di discernimento e di radicale dedizione a Dio.
La forza del testo risiede proprio nella sua natura disorganica e composita: Palladio, lungi dal costruire un’agiografia idealizzata, raccoglie con stile sobrio, talvolta brusco, episodi, aneddoti, racconti orali e testimonianze dirette che restituiscono la complessità e l’umanità dei padri e delle madri del deserto. L’autore alterna figure celeberrime, come Antonio Abate, Macario d’Egitto, Pacomio o Didimo il Cieco, a personaggi meno noti, donne ascete, monaci solitari, anacoreti itineranti, laici convertiti, costantemente sospesi tra il rigore dell’ascesi e le tentazioni del mondo. Accanto agli episodi edificanti, come le pratiche di digiuno, veglia o mortificazione corporale, non mancano narrazioni miracolose, sogni, visioni, battaglie con i demoni, resoconti di guarigioni fisiche e spirituali, spesso narrati con una vivacità narrativa che ne accentua la potenza esemplare.
L’impianto dell’opera è tuttavia più sottile di quanto la sua forma aneddotica possa far pensare. La Storia lausiaca è, in filigrana, un’operazione teologica e polemica: attraverso l’esaltazione del monachesimo vissuto, Palladio intende difendere la tradizione spirituale di Origene ed Evagrio, minacciata dalle condanne ufficiali e screditata da ambienti ecclesiastici più rigoristi. La spiritualità che emerge da queste pagine è intensamente interiore, orientata verso la conoscenza di sé, il dominio delle passioni, l’equilibrio tra corpo e mente, la preghiera incessante come strada per la deificazione. Non è un caso che molte figure descritte vivano ai margini, tra deserto e città, tra chiesa e solitudine, tra ortodossia e eresia. In questo senso, il libro è anche una contro-narrazione rispetto alle versioni più ufficiali e istituzionalizzate del cristianesimo tardoantico.
L’edizione curata da Vincenzo Lombino riesce a rendere con fedeltà e chiarezza la prosa concreta, a tratti ruvida, di Palladio. L’introduzione contestualizza efficacemente l’autore nella sua epoca, facendo emergere la sua funzione di testimone partecipe e intellettuale impegnato. L’apparato critico guida il lettore attraverso le difficoltà storiche, filologiche e teologiche di un testo che, pur nella sua semplicità, apre squarci profondi sulla vita spirituale dell’antichità cristiana.
La lettura della Storia lausiaca colpisce ancora oggi per la sua capacità di mettere in scena non solo la radicalità dell’esperienza religiosa, ma anche la tensione tra il desiderio di assoluto e la fragilità della condizione umana. Le figure descritte da Palladio non sono santi intoccabili, ma esseri attraversati da passioni, ossessioni, dubbi, spesso caricaturali nei loro estremismi, eppure paradossalmente credibili nella loro ricerca di senso. Vi è in queste pagine una tensione drammatica che prefigura la letteratura spirituale moderna: l’uomo alla ricerca di Dio come colui che deve prima di tutto fare i conti con il proprio inconscio, le proprie illusioni e la propria carne.
Non mancano tratti ironici o persino burleschi: il monaco che rifiuta il vescovado mutilandosi l’orecchio; l’eremita che beve l’acqua con un serpente nel pozzo; la vergine ricca raggirata con una frode pietosa per spingerla alla carità; l’anacoreta che cerca di non dormire per venti giorni consecutivi. L’umorismo involontario che talvolta emerge da questi racconti non è derisione, ma segno della distanza che separa il mondo dell’ascesi da quello comune, e insieme della concretezza con cui i monaci stessi vivevano le proprie stranezze.
Il valore della Storia lausiaca risiede dunque nella sua funzione di ponte: tra Oriente e Occidente, tra spiritualità colta e religiosità popolare, tra storia e leggenda, tra cronaca e mito. Essa ha influenzato la tradizione cristiana, ispirando lettori, scrittori, teologi e mistici, ma resta soprattutto un documento della varietà dell’esperienza umana davanti al mistero della fede.