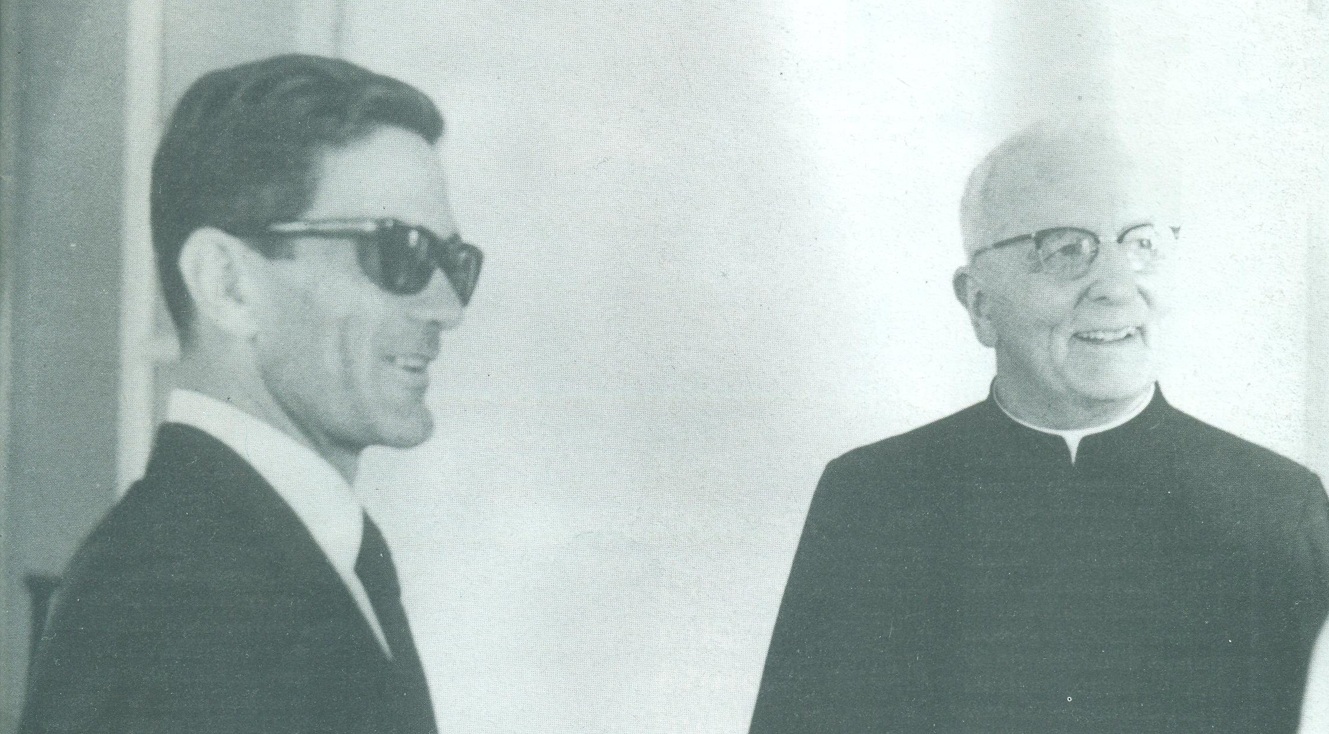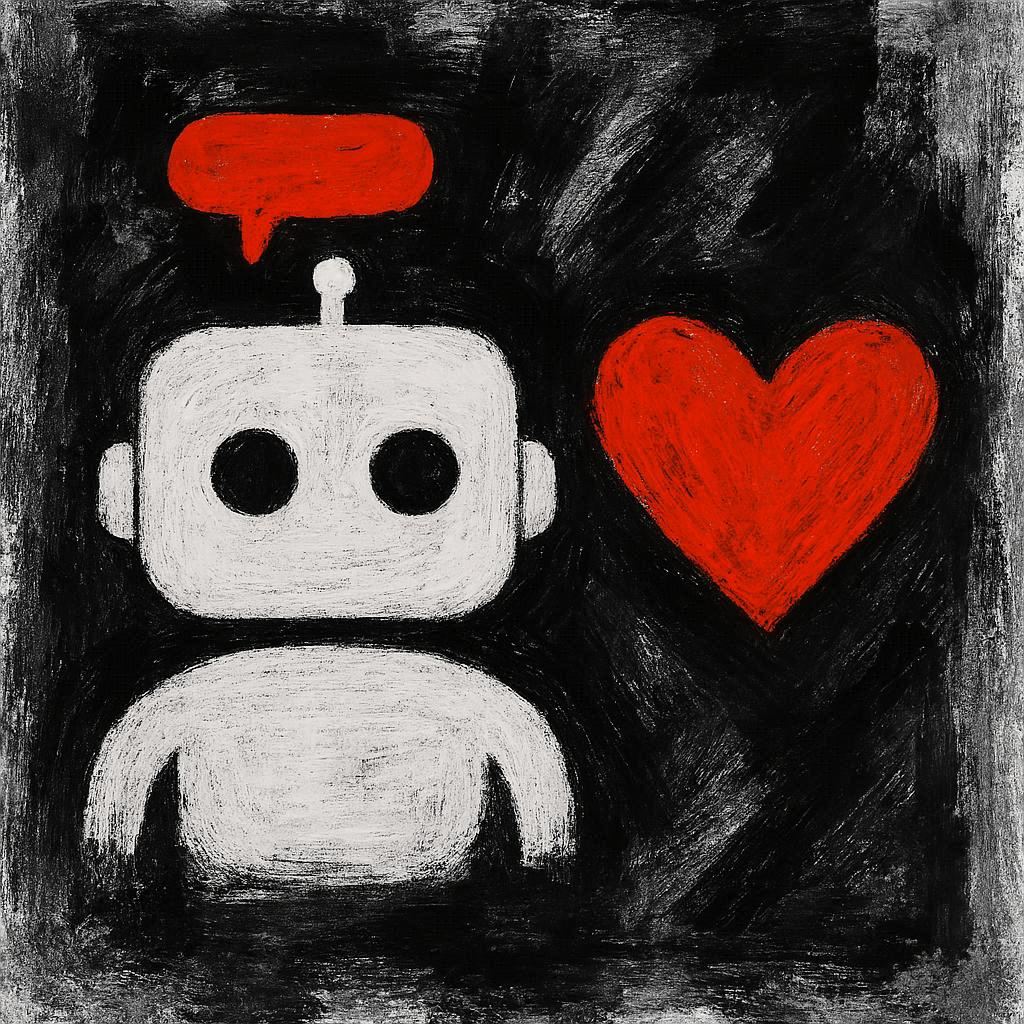Riflessioni
Giovani: un ritorno inatteso sulla scena pubblica

Sorpresa! Siamo tornati!”. Così sembrano dirci i giovani, quelli che da decenni giudichiamo irrimediabilmente assenti dalla scena pubblica, apatici, individualisti, talvolta perfino cinici. E invece oggi sono i protagonisti di maree umane che riempiono vie e piazze, al grido “Palestina libera”. Diciamo la verità: non ce l’aspettavamo. Non abbiamo previsto mobilitazioni così improvvise, estese, trasversali, trans-generazionali: giovani e anziani; carrozzini con bimbi e carrozzine con disabili; nelle metropoli, come nelle cittadine. Vedendo i primi cortei, qualcuno ha sperato che ritornasse, pari pari, la stagione delle rivolte studentesche alla guerra in Vietnam, un’epoca rimasta nella memoria dei più anziani. E invece, nelle parole di Giorgio Gaber, la realtà “è un uccello che non ha memoria, devo immaginare da che parte va, altrimenti muoio di normalità. È un uccello strano, fuori dagli schemi, che non è sensibile ai miei richiami”. Pochi hanno avuto l’abilità di immaginare dove vola quell’uccello, di cogliere un clima nuovo: certamente non viviamo una palingenesi, ma almeno, questo sì, una svolta importante. La novità sta nel fatto che è emerso un profondo spessore etico, finora più difficile da decifrare. Il filosofo-sociologo Michel Foucault parlava di “microfisica del potere”: il potere non è solo dei grandi apparati, ma si dissemina nei più minuti rivoli della società. A mio avviso si potrebbe parlare anche di “microfisica dell’etica”, che agisce concretamente a livello quotidiano, nelle relazioni interpersonali, in tante iniziative “dal basso”, come una rete fluida e in continuo mutamento. È etica anche l’indignazione verso il dominio scambiato per sicurezza, verso la violenza più oscena, la prepotenza, la legge del più forte che scardina il diritto internazionale. Così come è etica la ripulsa verso chi discetta se le stragi si possano definire “genocidio” o no; oppure verso le schermaglie su chi abbia avviato il macello per primo, polemiche che appaiono inutili, puerili (“signora maestra, ha iniziato lui!”). Tanti salutano le flottiglie come finora le uniche iniziative concrete, pacifiche, non-violente, insomma un raggio di speranza che illumina le vie della protesta. In assenza di interventi governativi, vi è un gran desiderio di appoggiare azioni concrete, operative, umanitarie. Dati alla mano, nel corso degli ultimi decenni si è aperta una faglia fra questo senso etico (che non riguarda solo la Palestina) e la logica del sistema partitico. Nello sviluppo del sentire comune, man mano si è aperta una faglia: da un lato questo senso etico, che qualcuno chiamerebbe “pre-politico”; dall’altro il sistema partitico e le sue istituzioni. Il primo versante sta crescendo; si fa più forte e più esplicita la domanda di solidarietà, giustizia, pace. Però nel frattempo cala il consenso verso il sistema politico, fino a raggiungere – soprattutto nei giovani – un grado di fiducia molto basso. Ad esempio, ma appunto è solo un esempio, in un mio recente sondaggio su giovani universitari, acculturati, niente affatto “gruppettari”, in una scala di fiducia con punteggi da 10 a 1, i partiti di sinistra hanno ottenuto una media di 4,5 e quelli di destra 3,4 (l’attuale Governo sta ancora peggio, con 2,9 di punteggio medio). Per tale motivo sarebbe “morire di normalità”, come direbbe Gaber, interpretare l’insieme di queste grandi manifestazioni popolari usando categorie politiche stantie (“sono di sinistra”, “sono pro-Hamas”, “sono strumentalizzati dai sindacati”, “vengono dai centri sociali”, “sono in continuità con la vecchia destra che era filo-palestinese”, etc.). In realtà i partiti e altre aggregazioni organizzate inseguono affannosamente questo moto popolare. Se in esso c’è qualcosa di “politico”, lo è in base alla nota definizione di don Milani: “Il mio problema è uguale al tuo; sortirne da soli è avarizia, sortirne insieme è politica”. Per il resto ciò che viene considerata la politiKa – quella con il cappa, in senso dispregiativo – è vissuta come qualcosa di diverso, spesso distante. Ciò spiega perché quelle grandi manifestazioni, che raccolgono tanto consenso, non hanno influenzato in misura significativa – sembrerebbe – gli esiti delle recenti elezioni regionali; la rivolta etica e i comportamenti elettorali sono visti come pianeti diversi, frequentabili ma incommensurabili fra loro. In sostanza, ci troviamo di fronte a uno scenario non previsto, per mancanza di categorie analitiche adeguate; ma anche perché sono diverse dalla nostra abitudine le forme di azione collettiva, i modi di organizzarsi da parte dei movimenti sociali. Un tempo l’azione collettiva era condotta in gran parte da grandi apparati, soprattutto partiti e sindacati, la cui iniziativa si basava su ampi programmi e puntava ad una mobilitazione tendenzialmente organizzata, permanente, alimentata da canali d’informazione istituzionalizzati: il giornale di partito, le sezioni, gli organismi sindacali, i consigli di fabbrica, etc. Tutto ciò è rimasto, più o meno; ma a fianco hanno preso piede altre forme di azione del tutto diverse: segmentate, reticolari, con leadership non concentrate ma diffuse; inoltre la mobilitazione è legata volta a volta a obiettivi particolari, limitati. In più, al posto di una presenza tendenzialmente stabile, è subentrato un andamento ondulatorio, dove le fasi di emersione pubblica sono precedute e seguite da periodi di latenza, da momenti di immersione invisibile. Questi ultimi preparano la successiva emersione attraverso canali comunicativi molto informali: i social e molti tipi di tamtam (per esempio le conversazioni quotidiane, o altri “luoghi terzi”, collocati fra la sfera del dibattito pubblico e l’insieme dei cittadini). Le mobilitazioni sulla Palestina sono sembrate improvvise solo perché erano precedute da una fase di latenza, immersione, invisibilità. Nel corso di questa fase si sono accumulati altri motivi di disagio, fra cui il 7 ottobre e la guerra in Ucraina. Quindi credo che non sia giusto rimproverare a tutti i “propal” di essere attenti ai palestinesi ma disattenti al pogrom del 7 ottobre o agli ucraini. Invece la tragedia palestinese ha funzionato anche da catalizzatore del dissenso verso una realtà ancora più vasta. Soprattutto i giovani coltivano una rabbia quasi sempre garbata, perché collocata fra la rassegnazione e il disagio, fra l’attesa e la speranza. Per queste nuove generazioni globalizzate, il quadro internazionale e quello nazionale si basano su un comune denominatore negativo. Allora si va in piazza inquieti, per ragioni volta a volta intercambiabili. Certamente le vicende nell’area del Medio Oriente destano l’ira; ma in un mix molto ingarbugliato – in cui ciascuna componente rafforza i sentimenti verso le altre – l’inquietudine scaturisce anche dalla condizione quotidiana, soprattutto dalle disuguaglianze sociali. Ad esempio, quasi un milione e mezzo di famiglie non è più in grado oggi di pagare le rate, l’affitto, o il mutuo. Oppure cresce il Pil ma diminuiscono i salari reali. Insomma, si sta amalgamando una miscela dagli esiti, almeno per ora, difficilmente prevedibili.