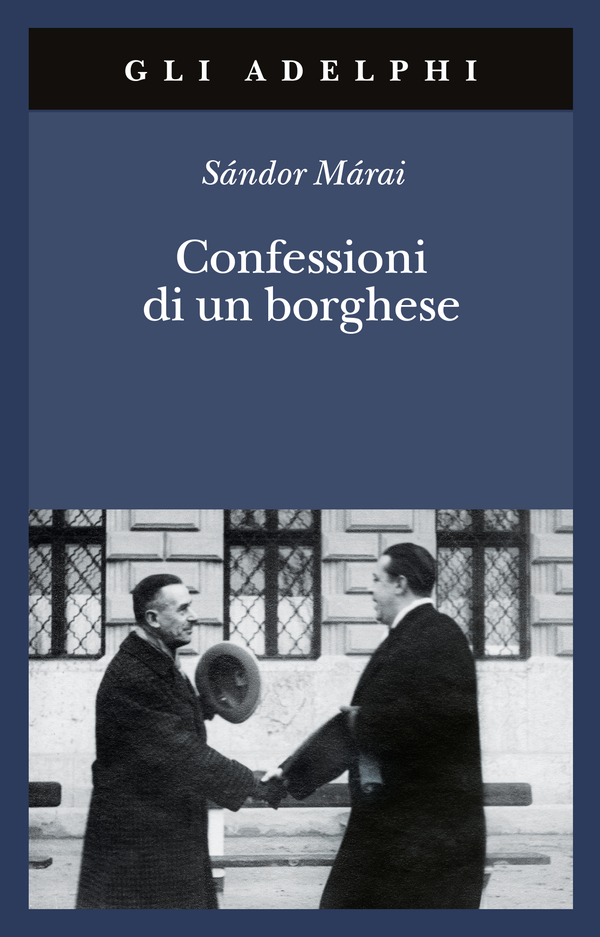Flashback – Tutti gli uomini del re

Tra i registi americani della sua generazione, Robert Rossen (1908-1966) è stato certamente uno dei più sottovalutati dalla critica a lui contemporanea, senza che la storiografia lo abbia in seguito fatto oggetto dell’attenzione che avrebbe meritato. Dopo un esordio in sordina con il noir A sangue freddo (Johnny O’ Clock, 1947)- nulla a che fare ovviamente con il libro di Truman Capote e il film di Richard Brooks – nello stesso anno ha diretto Anima e corpo (Body and Soul), ricognizione nel sottobosco della boxe emozionante nonostante finisca per ammorbidire la secchezza del magnifico racconto di Ring Lardner al quale é ispirato, così come, sia pure con modalità diverse, farà due anni dopo Mark Robson in Il grande campione (Champion), abilmente costruito intorno a un luciferino Kirk Douglas. L’interprete scelto per l’occasione da Rossen, John Garfield, finì nel mirino del maccartismo, morendo a soli trentanove anni per cause ancora non del tutto chiarite.
Non stupisce dunque che con il successivo Tutti gli uomini del re (All the King’s Men, 1949) il regista abbia dichiarato in maniera limpida da che parte si collocasse in uno dei momenti più difficili, per gli intellettuali di Hollywood e per l’America intera. Tratto dal romanzo omonimo di Robert Penn Warren, premio Pulitzer 1947, ispirato alla vicenda di Huey Pierce Long, discusso uomo politico anni ’30, racconta la resistibile ascesa di Wlillie Stark (Broderick Crawford, che grazie a questo ruolo si meritò l’Oscar) da paladino dei diritti degli ultimi a governatore senza scrupoli, capace di ogni bassezza per garantirsi e rafforzare il potere. La sua istrionica cialtroneria, giocata sulla semplificazione, anche linguistica, è mirata ad assicurarsi il consenso di un elettorato rurale scarsamente acculturato, che si identifica con entusiasmo nei suoi slogan urlati. Tra le stigmate del suo carattere, inoltre, l’atteggiamento spregiudicatamente macho nei confronti dell’altro sesso, incarnato qui dalla sua collaboratrice Sandie Burke (l’esordiente Mercedes McCambridge, altro Oscar come non protagonista) e da Anne Stanton (Joanne Dru), fidanzata del giornalista Jack Burden (John Ireland), poi amante di Stark.
Niente di nuovo sotto il sole, dunque. La forza di anticipazione del cinema è straordinaria, come d’altronde quella della letteratura. Si legga in proposito lo stupefacente Da noi non può succedere (1935), in cui il Nobel Sinclair Lewis immagina che Franklin Delano Roosevelt perda le elezioni del 1934 a favore di un personaggio orrendo, che cerca di trasformare gli USA avendo come modello le dittature a quel tempo imperanti in Europa, idea ripresa con minore efficacia e originalità da Philip Roth in Il complotto contro l’America (2004).
Tornando a Tutti gli uomini del re, si può aggiungere che, rispetto alla vicenda narrata, la novità introdotta da quella che usando un neologismo del quale ci scusiamo potremmo definire buzzurrocrazia trumpiana consiste nel fatto che, mentre i conservatori un tempo accarezzavano il pelo a quel tipo di elettorato per accaparrarsene i voti, oggi il leader è uno di loro dal punto di vista culturale, essendo la differenza con i propri sostenitori quantitativa e non qualitativa. In questo agghiacciante quanto istruttivo rapporto passato-presente, ci sta anche il parallelismo tra il film di Rossen e Un volto nella folla (A Face in the Crowd, 1957) di Elia Kazan, che sposta la vicenda sul piano mediatico, in quanto il protagonista, Larry “Lonesome” Rhodes (Andy Griffith), un folk-singer tirato fuori di galera dalla giornalista radiofonica Marcia Jeffries (Patricia Neal), usa dapprima la radio, poi la televisione, per fondare e accrescere la propria influenza, antenato in questo del nostro Silvio Berlusconi. Entrambe le pellicole, sia pure con modalità diverse (la morte violenta del primo, lo smascheramento del secondo), hanno una conclusione tutto sommato positiva, per cui la democrazia vince, anche se non proprio grazie ai suoi cosiddetti anticorpi.
Tutti gli uomini del re si aggiudicò l’Oscar, ma il premio non salvò Rossen dalle persecuzioni maccartiste. Dopo un documentario sulla tauromachia,fu costretto per lavorare a trasferirsi in Europa, dove realizzò un paio di film abbastanza insignificanti, Mambo (id., 1954) e Alessandro il grande (Alexander the Great, 1956). Poté tornare a Hollywood solo nella seconda metà degli anni cinquanta, girando un paio di opere più che dignitose, L’isola nel sole (Island in the Sun,1957) e Cordura (They Came to Cordura, 1959), prima di chiudere in bellezza una carriera nel corso della quale avrebbe potuto certamente dare di più se le circostanze professionali gli fossero state propizie. Lo spaccone (The Hustler, 1961), il suo capolavoro, fa dell’ambiente del gioco del biliardo una metafora dell’America amara, con personaggi indimenticabili come l’ipercinetico Eddie Felson di Paul Newman, la contorta Sarah Packard di Piper Laurie, lo spietato manager Bert Gordon di George C.Scott e, soprattutto, il monumentale Minnesota Fats di Jackie Gleason. Ma anche Lilith – La dea dell’amore (Lilith, 1964), tormentata love story ambientata in una clinica psichiatrica, con un insignificante ma funzionale Warren Beatty e una sensibile Jean Seberg affiancati da seconde parti del livello di Kim Hunter e Gene Hackman, rimane a tutt’oggi una delle opere più approfondite e giuste tra quante hanno affrontato il tema della malattia mentale.