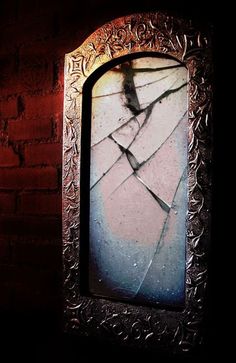Chiesa e teologia
Sorella Maria ha visto lontano

Ormai si tratta di qualche lustro fa. Piazzai due grandi pietre davanti alle ruote della macchina e mi avviai lentamente, poiché era tempo buono e tutt’intorno la vegetazione persisteva anche in quella coda d’inverno. Il viottolo stretto talvolta quasi si chiudeva per via delle piante, ma non tanto da impedire il tranquillo passaggio di una persona. Al cancello di legno, così come stava scritto, tirai con forza il manubrio e lo lasciai di colpo. Poco dopo l’abbaiare di un cane e l’arrivo di una sorella. Così sono giunto all’Eremo che, come recita la breve nota storica, scritta diligentemente a mano, risale almeno al 1370. Nel 1924 sorella Maria, “che chiamiamo la Madre”, mi disse la sorella che mi era venuta ad accogliere, lo fece acquistare da diversi amici e il 22 luglio del 1926 poté venirvi ad abitare per la prima volta con quelle che poi diventarono sorella Jacopa, sorella Immacolatella, sorella Angeluccia e sorella Rosa. Iniziarono così la libera ed evangelica koinonia di sorelle e fratelli, vicini e lontani, senza recinti di confessione. Per dar vita a una fragile vita nascosta quale quella della “violetta”, come la denominò colei che al secolo era Valeria Maria Pignetti.
Una frase di sorella Maria, scolpita in un piccolo e prezioso libretto azzurro, dà il senso di questa esperienza: “Cristo è di tutti, di quelli che credono in lui e di quelli che non lo conoscono. Gli uomini hanno sempre la tendenza a restringere… noi dobbiamo tenerci al largo per essere con tutti, diventare lungimiranti nell’attesa del Regno”. Ed ancora: “Chiamo servo di Dio ogni anima onesta che, anche senza una fede positiva, lavora per l’ideale”. L’ appartenenza della Minore, come si definiva, alla Chiesa cattolica fu sempre piena e convinta ma non volle viverla mai come separazione dal mondo. E certo dialogare nella prima metà del Novecento con Gandhi e Schweitzer, fare comunità con luterane ed anglicane e tenere per amici Ernesto Buonaiuti, il capostipite del Modernismo (Ginepro per l’Eremo) e Brizio Casciola e poi, per fratello don Primo Mazzolari (Ignazio per l’Eremo) non poteva andar giù a vescovi e vicari della diocesi. Tuttavia il dialogo, l’ecumenismo, l’essenzialità oltre la cortina dei dogmi: questi temi del Concilio sono stati seminati e vissuti quassù, tra divieti e incomprensioni, quasi mezzo secolo prima, nell’ombra e nella fiducia. Per sorella Maria tutto consiste nella ricerca del volto di Gesù che, scrive “cerco sotto il velo del pane, in memoria sua, sotto il velo del Vangelo, sotto il velo dell’innocenza dei bambini, sotto il velo della natura Madre: il grano, la vite, gli olivi, la pietra, il legno, le spine, il fior di cicoria… perché ogni natura ci rivela un raggio della Sua impronta, della presenza dell’Amico unico”.
La preghiera è certo un punto centrale di ogni esperienza religiosa ma nella vita dell’Eremo essa, andando oltre le formule del culto, raggiunge quella sostanziale tenerezza verso tutto ciò che vive e rende l’uomo capace di servire la vita. Spoglia di ogni ritualismo ossessivo e ripetitivo. D’altra parte sorella Maria aveva detto con forza che la sua religione era anzitutto “la comunione con chi amo e con chi soffre”. La preghiera è dialogo con il mondo, è creazione, è “colpo d’ala” è ricordo degli assenti, è comunione, è gioia (“un grande debito cristiano, forse il debito per eccellenza”), è “ricominciare sempre”.
Per andare alla mensa comune si attraversa il piccolo chiostro dell’Eremo e sul muro rosato ci si imbatte nel saluto della Minore: “Addio a voi tutte che mi avete aiutato a vivere… addio mille volte cari fiori azzurri… salendo dalla solitudine alle stelle porterò con me il ricordo di voi. Comunicantes in eterno! Addio chiostro più poverello del mondo, addio corridoi delle celle, addio pura semplicità azzurra, addio stanza comune, addio mensa fraterna, addio madia del pane…vigilerò per sempre”.
Era il 5 settembre 1961 quando Maria morì e al suo funerale fra Giovanni Vannucci, amico di Maria e dell’Eremo, le rendeva grazie “per aver ridato la vita alle parole essenziali del cristianesimo che per l’usura del tempo erano sbiadite: l’Agape, la Koinonia, il Sacrum facere, la Pace, la Madre Terra…; per aver riportato nel vecchio Eremo la vita dei monaci antichi ripetuta con fedeltà allo spirito e novità di forme; per averci mostrato che nella fedeltà semplice al Signore Gesù tutte le Chiese possono incontrarsi nell’unità dell’Amore”.
P.S. Questo è l’anno 150° dalla nascita di sorella Maria. Nei prossimi numeri ci piacerebbe far memoria del cammino di “una delle esperienze più limpide di vita evangelica del XX secolo” come ogni 5 settembre ricorda il ‘Libro dei Testimoni’ della Comunità di Bose.