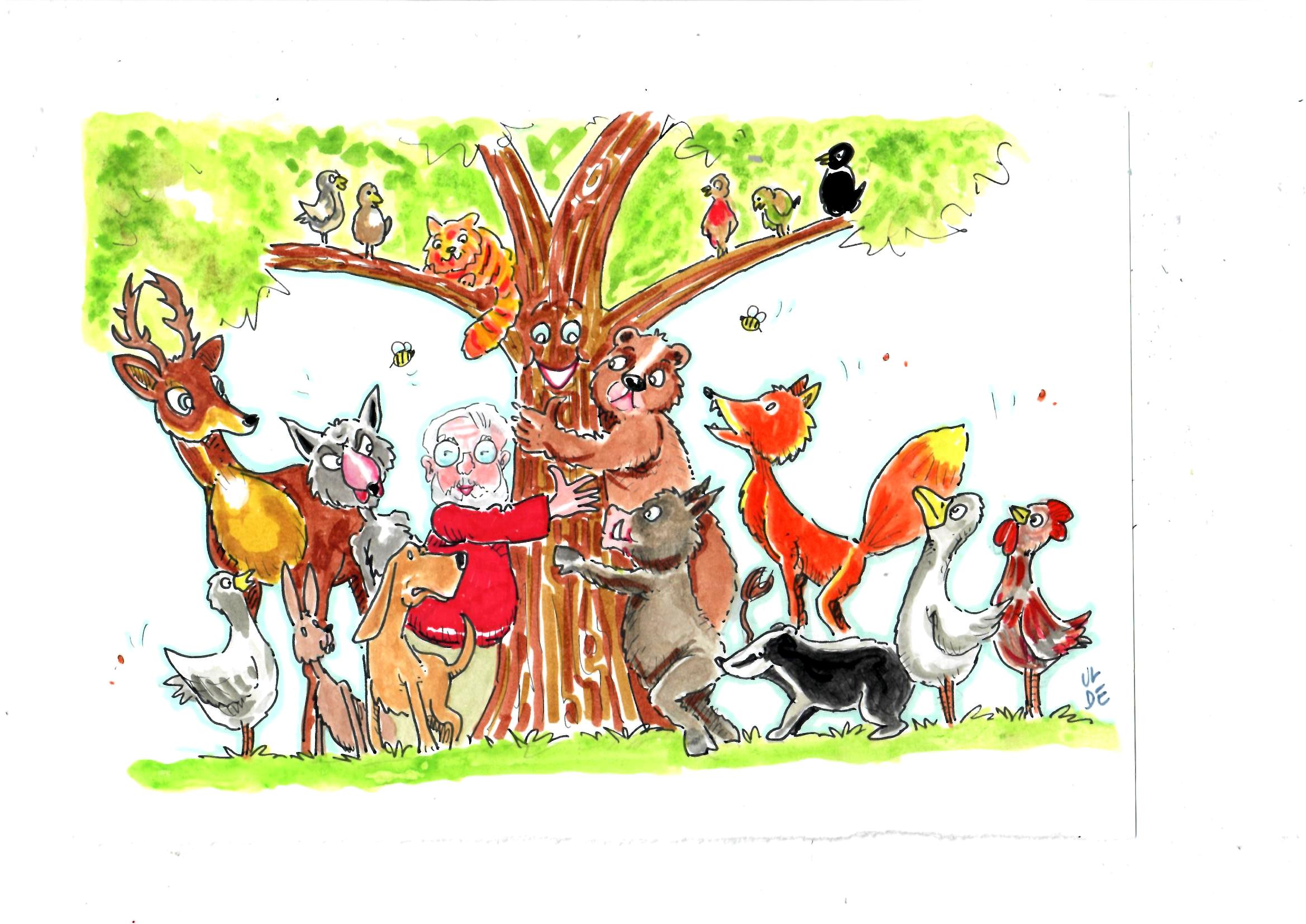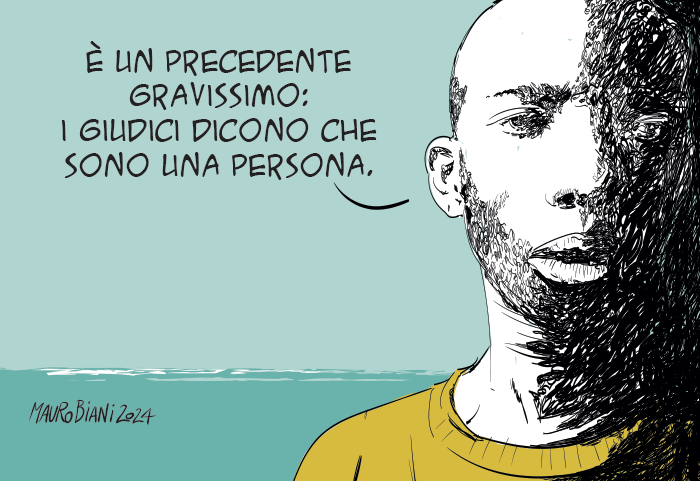Cum tucte le tue creature
Se la povertà è ricchezza

In nessun modo volendo sostenere che la miseria – materiale, culturale, morale, spirituale – sia un bene, desidero però distinguere tra miseria e povertà: beati i poveri (“Beati voi poveri” in Lc 6,20; “Beati i poveri in spirito” in Mt 5,3). In un’epoca, come la nostra, in cui il denaro da mezzo è diventato fine, un vero e proprio idolo, proviamo a delineare la bellezza dell’assenza di scopo, e non solo dal punto di vista strettamente materiale. Osserviamo due mondi, quello della brama e quello della pace, consapevoli che il nostro cuore abita entrambi, ma che si può sempre scegliere a quale dare più retta. Analizzandoli separatamente faremo un esercizio di consapevolezza, cui seguirà un atto di integrazione e discernimento.
IL MONDO DELLA BRAMA
In nessun modo volendo assumere un’ottica moralista, cerchiamo di vedere i “beni” connessi alla postura della brama: brama di essere, brama di avere, brama di dovere.
Nella brama di essere sperimentiamo l’insoddisfazione del presente così come è e ci proiettiamo costantemente in un futuro da cui attendiamo il compimento. È una postura “escatologica” a modo suo: qui e ora non si può dare ancora la pienezza, ma vogliamo credere che le cose cambieranno e ci industriamo a questo scopo. Viviamo nel costante sforzo di raggiungere delle mete concrete (degli obietti) – rispetto al corpo, alle relazioni, al lavoro, al mondo –, preoccupati di non riuscire, aggressivi nei confronti di tutto ciò che, dentro e fuori di noi, sembra ostacolare questo cammino progressivo: dal meno al più, dal peggio al meglio, dalla mancanza all’abbondanza. Pensiamo che la nostra “vera” vita ancora non si sia data e che solo quando saremo riusciti ad ottenere determinati risultati potremo essere felici. Chiaramente questo non succede mai. E anche quando abbiamo raggiunto un obiettivo ne godiamo limitatamente, subito proiettati a raggiungere qualcos’altro ancora…
Nella brama di avere siamo inconsapevoli lacchè del paradigma consumistico che la fa da padrone in questo tempo storico. Pensiamo – siamo stati indotti a pensare – che se avremo a disposizione una ricchezza sufficiente potremo soddisfare tutti i nostri bisogni, non solo materiali. Il denaro non è più un mezzo, ma diventa il fine, in quanto percepito come garante della felicità. E quando poi “consumiamo” sentiamo un sollievo, conteniamo – apparentemente e fugacemente – l’ansia che ci tormenta in modo quasi costante, e ci convinciamo che se potremo consumare di più il sollievo avrà anch’esso un segno “più”. La corsa è iniziata e chi si ferma è perduto: bisogna guadagnare sempre di più.
Nella brama di dovere identifichiamo la felicità con la perfezione. Qui i criteri possono essere diversi. Esiste l’etica del lavoro, per la quale gli obiettivi professionali diventano prioritari su tutto, anche sulla vita, che passa nella frenesia dell’iperattività, salvo poi svegliarsi troppo tardi e pentirsi di tutto ciò che non si è fatto. Esiste poi l’etica morale, per la quale diventa necessario sacrificarsi, espiare, non essere mai troppo felici, vivere sforzandosi di raggiungere standard morali eroici, cercando di costringere anche gli altri a fare altrettanto e sorprendendosi di non essere compresi. Esiste anche l’etica ideologica, qualsiasi sia l’ideologia prescelta (politica, animalista, ecologista, spiritualista nelle sue varie declinazioni etc.), per la quale si diventa fondamentalisti, ossessivi, irascibili, monotematici, noiosi.
Se siamo onesti dobbiamo riconoscere che qualcosa di queste brame abita i cuori di ciascuno/a di noi, anche se a volte diamo loro nomi più nobili: realizzazione di sé, successo, bene.
IL MONDO DELLA PACE
Nel mondo della pace, che nasce dalla meditazione, dal silenzio e dalla preghiera, che scorga dal nostro centro interiore, non si hanno scopi, e questo è a dir poco scandaloso. La pace è scandalosa, perché sa stare nel vuoto senza cercare di riempirlo con ciò che non si è, ciò che non si ha e ciò che si deve. Analizziamo lo scandalo.
Nella pace siamo scandalo a noi stessi, perché ci andiamo bene come siamo. Smettiamo di coltivare un’immagine alienata di noi stessi, e mentre recuperiamo il valore che avevamo proiettato “fuori”, in ciò che è altro dal nostro essere attuale, scopriamo un nuovo sguardo: realista e riconciliato. Cominciamo a comprendere che i “pesi” che portiamo – che si manifestano nel corpo, nella psiche, nelle attitudini – rappresentano l’unico nostro “dovere spirituale”. Esperimentiamo quanto sia salvifico accoglierci per come siamo, comprendendo il senso profondo della nostra vita con i suoi eventi. Siamo chiamati da dentro a “stare”: in noi stessi, con noi stessi, senza fughe. Tutta l’energia risparmiata in questo “ritorno a casa” si rende allora disponibile per la realizzazione del Sé (e non di sé), che mira «all’integrazione di conscio e inconscio e alla vitale cooperazione tra questi due aspetti della personalità. Non si tratta quindi di essere sempre più caratterizzati ma sempre più completi, non essere meno umani ma compiutamente umani»[1].
Nella pace siamo scandalosamente felici. Al punto da non sentire più il bisogno di correre dietro alle chimere del consumismo, grati finalmente di quanto abbiamo. Capaci di godere profondamente, a cominciare dal godimento per il tempo ritrovato, quando smettiamo di correre al centro commerciale, scorrere sul nostro cellulare, analizzare quello che non abbiamo, coltivare rancore e propositi di rivalsa. Nella pace della povertà – che non è la miseria, che va combattuta – ci scopriamo scandalosamente ricchi. Di ascolto attento, di attese fiduciose, di contemplazione attiva e azione contemplativa, di relazioni coltivate, di gratitudine. Per cosa siamo grati? Per l’essere che è, qui e ora, e per l’essere che si dà, inaspettatamente, incessantemente e gratuitamente.
Nella pace ci sentiamo scandalosamente amati. Perciò lavoriamo con impegno sì, ma come il traboccare di una brocca di acqua fresca, e la fatica diventa sorella, non più matrigna. E quando sentiamo il bisogno di riposare sorridiamo a noi stessi e ci distacchiamo dall’opera, godendo del sollievo come di una brezza leggera. Non ci sentiamo in colpa e quando vediamo il limite del nostro lavoro ne contempliamo il senso: Il Signore completerà per me l’opera sua (Sal 138,8), perché nel vuoto del nostro limite trova spazio l’oltre. Godiamo passando da possessori ad amministratori, e ringraziamo per il riposo come per il lavoro.
Nella pace ci sentiamo scandalosamente amati. Perciò smettiamo di giudicare impietosamente noi stessi e gli altri, e impariamo ad abbandonare il placebo delle pratiche sacrificali nelle loro varie formulazioni: ascesi di tipo religioso, altruismo masochista, senso del dovere esasperato, “umiltà” disfunzionale, limitazioni di ogni tipo della libertà propria e altrui. Quando queste allucinazioni si spengono, cominciamo a vedere e a sentire tutto in modo diverso e la nostra vita cambia: l’esperienza spirituale si approfondisce mentre si alleggerisce, il desiderio di bene per gli altri sboccia spontaneo da un cuore riconciliato e attento, le fatiche di ogni giorno vengono abbracciate senza farne degli idoli, si impara a riconoscere il proprio valore e ad esprimerlo senza false modestie. Si ricomincia a respirare, grati/e dell’aria e della vita, nostra e altrui. Si smette di ossessionare gli altri affinché corrispondano alle proprie ideologie e si scopre l’immensa gioia della libertà.
LA BRAMA DELLA POVERTÀ
«Non veniamo al mondo per lavorare o per accumulare ricchezza, ma per vivere. Abbiamo a disposizione l’eternità per non essere e solo un minuto per essere. Per questo, ciò che più mi offende oggi è la poca importanza che diamo al fatto di essere vivi» (José Mujica).
Sembra paradossale eppure… se per povertà intendiamo questo digiuno dal consumismo, dal successo a tutti i costi, dalle ideologie fanatiche, ecco che non si può che bramarla, con i suoi frutti di compiutezza, libertà, godimento, amore. Per riscoprire il senso della vita e ringraziare. Sì, ringraziare.
[1] C. WIDMANN, L’individuazione. Principio, processo, fine, ed. Mimesis, Sesto San Giovanni (MI) 2024, p.98