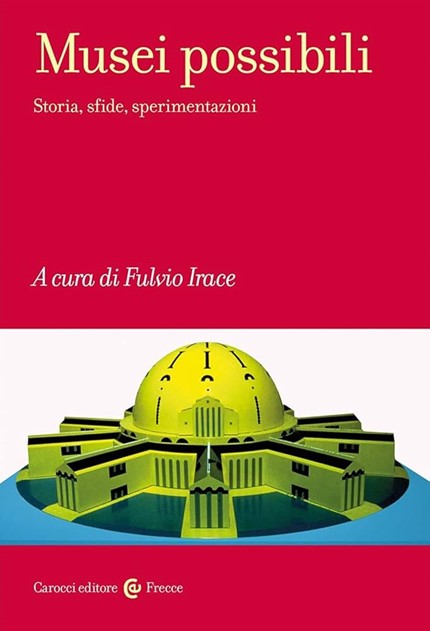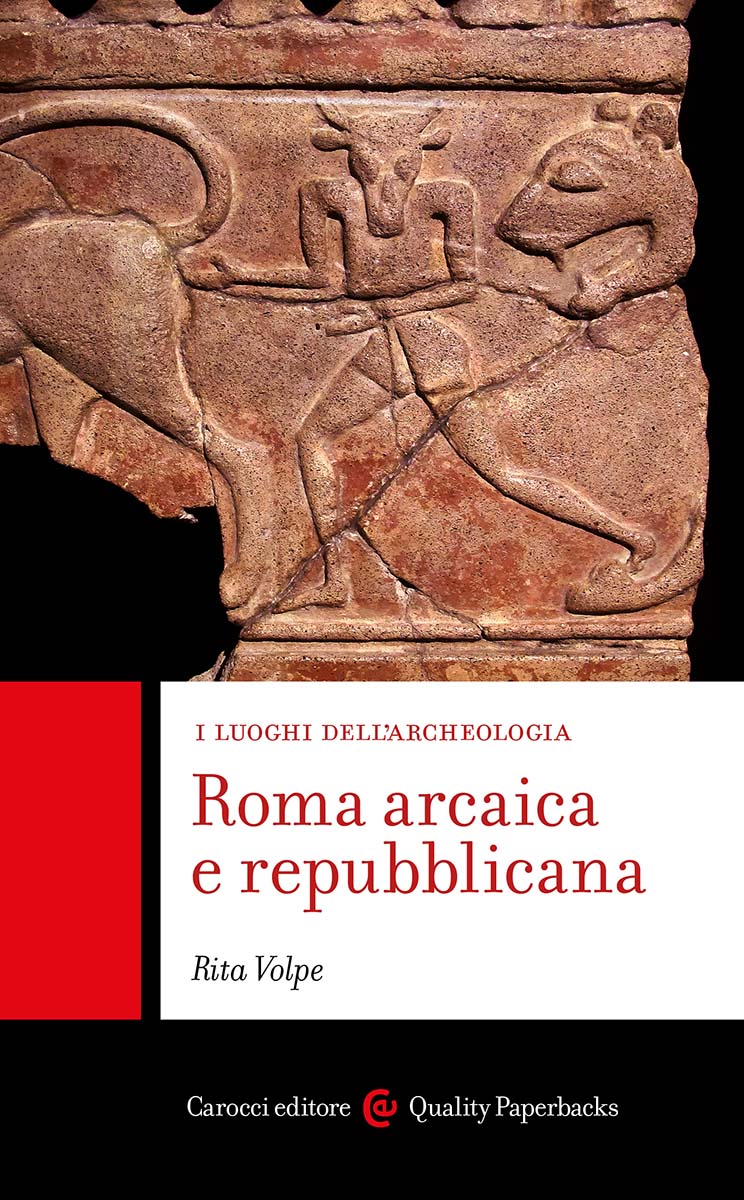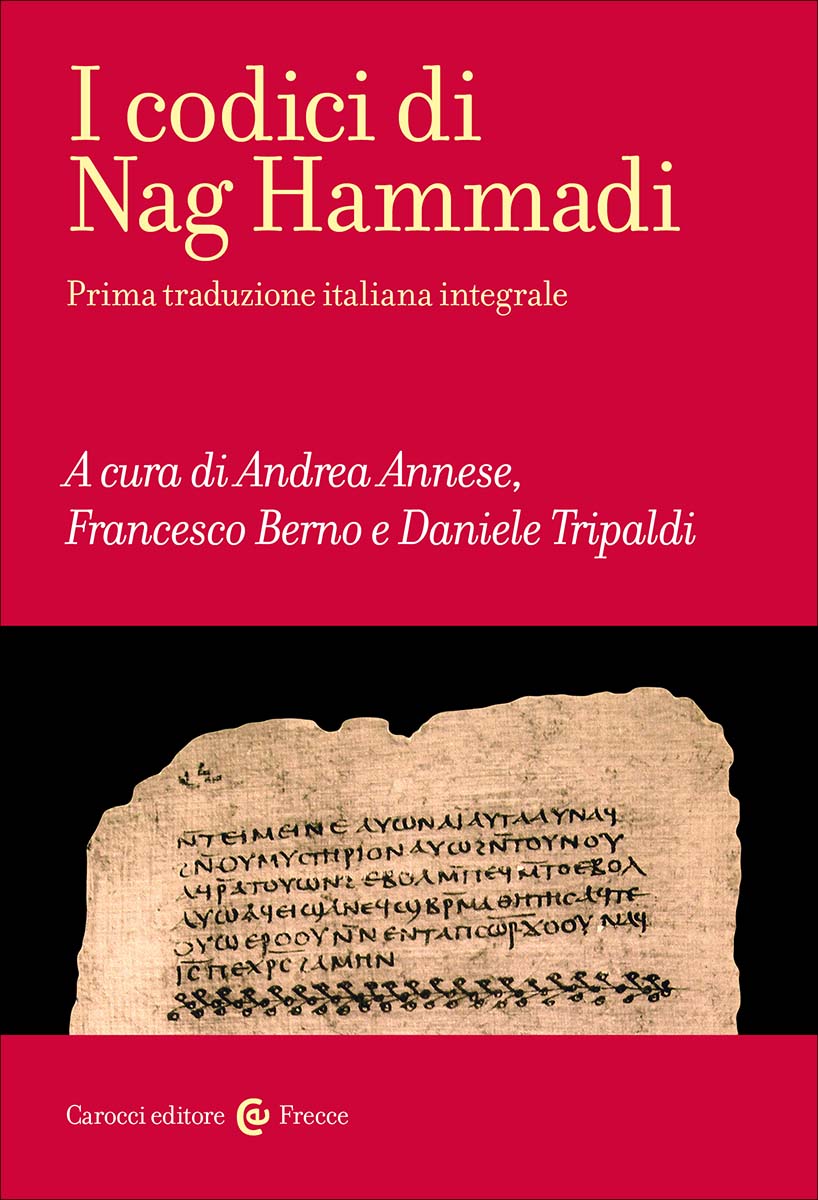Dal microcosmo al destino dell’umanità
Dice il saggio
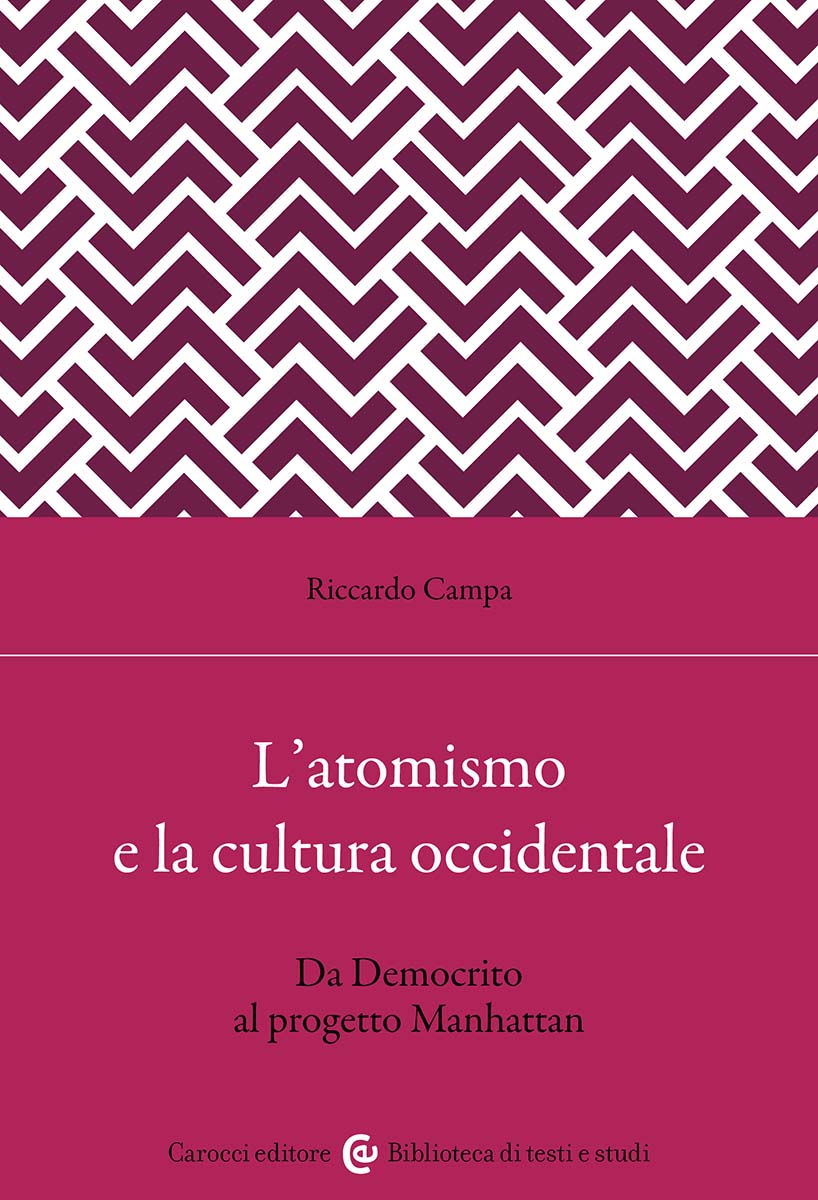
Riccardo Campa
L’atomismo e la cultura occidentale
Da Democrito al progetto Manhattan
Carocci, 2024, pp. 768
€ 69,00
Riccardo Campa, filosofo e storico della filosofia, offre con “L’atomismo e la cultura occidentale” un’opera di notevole valore intellettuale. Il testo ripercorre le tappe fondamentali della tradizione atomistica, da Democrito e Leucippo fino alle soglie della modernità con il Progetto Manhattan, evidenziando l’influenza di questa corrente di pensiero sullo sviluppo della cultura occidentale, a volte in maniera più esplicita e trasparente, in altre occasioni più sotto traccia. Campa, noto per la sua abilità nel coniugare il rigore scientifico con una profonda sensibilità umanistica, utilizza l’atomismo come lente interpretativa per esplorare l’evoluzione della scienza e della filosofia, ma anche per riflettere sulle contraddizioni e le sfide della modernità.
“L’atomismo e la cultura occidentale” si pone in continuità con il precedente lavoro di Campa “L’epoca dell’incertezza. Il dualismo contemporaneo fra mondo microscopico e macroscopico”, pubblicato, sempre per Carocci, nel 2023. Se lì il focus era sul Novecento e ciò che seguì alla Seconda Guerra mondiale, nel saggio sull’atomismo si ricostruisce tutto il percorso che condusse a quell’esito, come in un prequel che va a completare il discorso. In entrambi i casi l’autore dà vita a libri corposi (circa 800 pagine ciascuno) e ad alta densità semantica, letture senz’altro impegnative che richiedono un’immersione nel filo del ragionamento dell’autore.
Il libro si apre con un’analisi delle radici dell’atomismo nella Grecia classica, tracciando il percorso delle idee che da Leucippo e Democrito attraversano figure centrali come Epicuro e Lucrezio. Campa mette in luce come l’idea degli atomi, intesi come mattoni fondamentali della realtà, abbia esercitato un’influenza duratura sulla filosofia e sulla scienza, rappresentando una delle chiavi di volta per comprendere il rapporto tra natura e cultura.
Proseguendo, l’autore esplora il legame tra il pensiero atomistico e i grandi cambiamenti culturali della modernità. L’excursus affrontato dall’autore è notevole sia per quanto riguarda l’arco temporale di oltre due millenni, sia per i temi e le discipline coinvolte, dalla filosofia, alla politica, alla letteratura, alla musica e la cultura tout court. Il Progetto Manhattan, simbolo della tecnologia moderna, primo frutto della scoperta vera e propria degli atomi che da concetto filosofico diventano oggetto di studio e sperimentazione rappresenta per Campa la drammatica concretizzazione delle potenzialità e dei pericoli insiti nel dominio tecnico-scientifico dell’energia atomica. Hiroshima e Nagasaki diventano emblemi di un’umanità che, pur avendo raggiunto traguardi straordinari, si trova a confrontarsi con le conseguenze etiche e sociali delle proprie scoperte.
L’approccio di Campa è eminentemente interdisciplinare. Nel suo percorso, l’autore intreccia filosofia, scienza, letteratura e storia delle idee, mostrando una conoscenza enciclopedica. Egli non si limita a una trattazione storica o filosofica, ma propone una riflessione ampia e articolata sulla condizione umana e sul suo rapporto con il progresso tecnico-scientifico.
Particolarmente significative sono le riflessioni sulla rivoluzione industriale e sul ruolo della tecnologia come strumento di emancipazione ma anche di dominio. Campa descrive con precisione il passaggio da una visione mitica del mondo, dominata da simboli e metafore, a una visione razionale e tecnica, culminata nella capacità dell’uomo di manipolare le forze fondamentali dell’universo.
Il libro non si limita a descrivere il passato; offre anche spunti di riflessione per il presente e il futuro. Campa propone l’atomismo come una metafora per la complessità e l’interconnessione del mondo moderno. Egli invita i lettori a considerare le implicazioni etiche e sociali delle scoperte scientifiche, suggerendo che il progresso tecnologico debba essere accompagnato da una profonda consapevolezza morale.
In questa prospettiva, Campa si distingue come una voce critica ma costruttiva, capace di riconoscere sia i trionfi che le tragedie della civiltà occidentale. A tal fine l’autore approfondisce anche il tema del confronto con l’oriente, già al centro della filosofia novecentesca. Il suo obiettivo non è quello di condannare la modernità, ma di offrire una chiave di lettura per comprendere e affrontare le sue sfide.
Lo stile di Campa è denso e ricco di riferimenti culturali. La sua prosa, caratterizzata da una terminologia precisa e da un profondo rigore argomentativo, richiede un lettore attento e disposto a immergersi in un’opera corposa (oltre 750 pagine) di alto livello e densità. L’intero testo è suddiviso in soli due capitoli di oltre trecento pagine ciascuno. Nonostante questi limiti di accessibilità del testo, si può contare su spiegazioni chiare e una struttura della riflessione filosofica che guida il lettore attraverso i temi principali.“L’atomismo e la cultura occidentale” è un libro che merita di essere letto non solo dagli studiosi di filosofia o storia della scienza, ma da chiunque voglia approfondire le radici culturali del nostro tempo immergendosi in una riflessione a tutto campo. Riccardo Campa ci regala un’opera capace di illuminare le connessioni tra passato e presente, offrendoci strumenti preziosi per affrontare le complessità del futuro. Una lettura importante e impegnativa per chi cerca una comprensione più profonda del rapporto tra conoscenza, potere e responsabilità.